“Uomini e topi” di John Steinbeck
di Alfonso Santagata / 28 gennaio 2013
California, pochi anni dopo la crisi del 1929. Due lavoratori stagionali arrivano in un ranch per un impiego da cinquanta dollari al mese, tra sacchi d’orzo da caricarsi sulle spalle e una misera vita in una baracca con letti di paglia. Unica distrazione: le carte e il bordello in una città poco lontana. I due lavoratori/protagonisti sono George Milton, «basso e vivace, fosco in viso, dagli occhi impazienti, dai tratti taglienti e vigorosi», e Lennie Small, «il suo opposto, un giovanottone dal viso informe, occhi grandi e pallidi, spalle ampie e cascanti». Lennie, ingenuo e sensibile, è enorme, ha una forza straordinaria ed è ritardato mentalmente.
Uomini e topi è il sesto romanzo di John Steinbeck, liberamente ispirato a una storia accaduta in un ranch californiano nel 1920. Romanzo breve e ricco di dialoghi, anche perché destinato soprattutto a quei vagabondi, lavoratori stagionali, ladruncoli, uomini liberi che spesso analfabeti vagavano di stato in stato nell’America tra le due guerre mondiali. Anzi, l’autore aveva pensato inizialmente a un’opera drammatica dal titolo Something that happenend, che è poi divenuta un romanzo, come spesso accade con autori americani, dalla forza visiva dirompente. Non a caso sono due le trasposizioni cinematografiche: una del 1939 e l’altra del 1992. La prima versione teatrale è invece del 1937. Nonostante la brevità e l’esiguo numero di personaggi, Steinbeck affronta diversi temi che compariranno anche in opere dal più ampio respiro come Furore: la condizione dei lavoratori e degli emigranti nell’America post-Ventinove, la centralità del lavoro e del guadagno, il sogno americano che si traduce nel possesso di una attività produttiva. Ma per trovare l’ossatura della narrazione bisogna cogliere il senso di solitudine che trasuda da ogni pagina. Lennie e George sono un’anomalia, come subito notano tutti, proprio perché è più unico che raro vedere due lavoratori che viaggiano in coppia. Ecco allora lo scopino Candy senza più nessuno dopo l’uccisione del suo vecchio pastore tedesco. Oppure Curly, il figlio attaccabrighe del proprietario del ranch, costretto a rincorrere ogni giorno la giovane moglie che “fa gli occhi”ai lavoratori. E soprattutto Crooks e la moglie di Curly. In questo caso la solitudine diventa impossibilità di comunicare: un isolamento claustrofobico, assoluto. E Steinbeck, sempre cronachistico, ci racconta così la vita degli ultimi in quell’America: le donne e i neri.
Crooks è il garzone di stalla. Di colore e con la schiena deformata dal calcio di un cavallo. La sua vita dopo il lavoro è rinchiusa in una baracca di pochi metri quadri, diversa da quella degli altri lavoratori perché lui è nero. In un dialogo con Lennie, Crooks spiega che «Un uomo ammattisce se non ha qualcuno. Non importa chi è con lui, purché ci sia», «Un uomo passa la sera qui solo, seduto». Il garzone finisce per diventare quasi l’intellettuale del gruppo o comunque l’unico che abbia dei libri, usati, per tentare di lenire la sofferenza della solitudine e non certo per cultura personale o voglia di conoscenza. Poi c’è la moglie di Curly, l’unica donna del romanzo, il cui nome non viene mai menzionato. «Mi sento sola. Voi potete parlare con la gente, ma io solo con Curly. Diversamente, se la prende. Vi piacerebbe a voi non poter discorrere con nessuno?». Parole dette ancora una volta a Lennie, in un dialogo in un altro luogo chiuso come la stalla, immobile nel caldo del meriggio. L’importanza della comunicazione e della parola trova in Uomini e topi anche un altro esempio, ribaltato rispetto ai precedenti e proprio per questo fondamentale: tra tutti i lavoratori emerge Slim, il capo-cavallante. Saggio, pacato, carismatico; una leadership riconosciuta che emerge chiaramente. Le sue parole sono definitive, mai contestate. Quando il capo-cavallante parla il microcosmo creato da Steinbeck ascolta in silenzio.
(John Steinbeck, Uomini e topi, trad. di Cesare Pavese, Bompiani, 1937, pp. 118, euro 8,90)


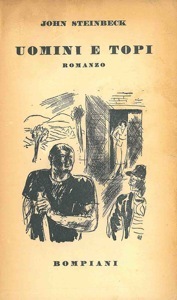



Comments