Letteratura e psicopatologia contemporanea
L’angoscia della perdita del mito in Barrie, Nabokov e Mishima
di Claudia Cautillo / 16 ottobre 2019
La letteratura, potente macchina dei sogni capace di mettere a nudo lo Zeitgeist della propria epoca, è oggi più che mai crocevia paradigmatico della nostra contemporaneità, sulla quale pesano la perdita del mito e del simbolico. L’eclatante successo di Peter Pan (1904) del drammaturgo e scrittore scozzese James M. Barrie (1860-1937) – che dall’esordio teatrale in poi si andrà radicando sempre più profondamente nell’immaginario collettivo – ne sono una prima, folgorante anticipazione. Stessa stretta consonanza tra produzione letteraria e coordinate inconsce della seconda metà del XX secolo per Lolita (1955), il più famoso tra i romanzi di Vladimir Nabokov (1899-1977) – solo sette anni più tardi consacrato sullo schermo da Stanley Kubrick con l’omonimo film – non meno che per Il padiglione d’oro (1956) di Yukio Mishima (1925-1970), da molti considerato il suo capolavoro e uno dei romanzi più significativi del Giappone moderno.
Tre grandi classici, dunque, legati dallo stesso fil rouge, quel vivere il tempo come presente angosciante e chiuso – tipico della cultura postmoderna dell’immediatezza e del pessimismo riguardo al futuro – in cui sbiadendosi modelli, sogni, utopie ed ideali, l’orizzonte e le sue sconosciute possibilità sono vissute come minaccia anziché come promessa. È così che il professor Humbert consuma la sua totalizzante passione per la natura «non già umana, ma di ninfa (vale a dire demoniaca)» della dodicenne di cui si è invaghito, quella Lolita cristallizzata in «quell’isola immateriale immersa in un tempo incantato nel quale […] si trastulla con le sue simili».
E se il mito greco della ninfa occlude lo sguardo al limite cronologico della pubertà, imprigionando Humbert nel circolo vizioso di un presente immobile per cui la vita stessa entra in scacco, in Peter – nel quale ritroviamo il riferimento mitologico al dio silvano Pan, la cui etimologia è quel “tutto”, legato all’abisso e al profondo, dunque all’esperienza del panico tipica dell’epoca postmoderna – il tempo semplicemente non esiste, ruotando in una perpetua giostra che col suo movimento circolare riporta tutto all’inizio: «I ragazzi perduti erano in giro a cercare Peter, i pirati erano in giro a cercare i ragazzi perduti, i pellirosse erano in giro a cercare i pirati e gli animali selvaggi erano in giro a cercare i pellirosse. Camminavano in tondo sull’isola ma non si incontravano perché tutti andavano alla stessa velocità».
Analogo pensiero ossessivo, ansia e impossibilità ad immaginare il proprio futuro per il giovane accolito buddista, claudicante e balbuziente Mizoguchi di Il padiglione d’oro, per il quale il tempo è quello immobilizzato e ripetitivo del non inizio, della non-azione congelata nel culto della Bellezza: «Quel mio difetto – inutile dirlo – costituì sempre una vera barriera tra me e il resto del mondo. Mi riusciva soprattutto difficile pronunciare l’inizio delle parole: l’inizio, ogni inizio, costituiva la chiave del mondo esterno, una chiave che non ho mai potuto manovrare a dovere». Mishima coglie magistralmente il genius saeculi nella disperata, quasi magica attesa della grande distruzione dell’antico tempio – non meno che del Giappone tradizionale ormai al suo tramonto – da cui è tormentato il protagonista, fino ad assegnare al suo clamoroso gesto da piromane un profondo significato simbolico e catartico.
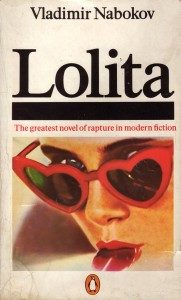
Altra fondamentale coordinata psicologica comune ai personaggi dei tre romanzi è la privatio mali, ovvero quell’odierno sentire il bene non più, come in passato, quale forza a sé stante e dunque agente, ma in quanto semplice assenza del male, di modo che ciascuno di loro si fa oggetto passivo al di là di qualunque senso etico. Per questo il professor H. Humbert è un solitario pedofilo ingabbiato nelle spire della sua mania dalla quale non vuole e non può uscire: «…ah, lasciatemi in pace nel parco della pubertà, nel mio muschioso giardino. Lasciate che giochino intorno a me per sempre. Che non crescano mai»; Lolita una ninfetta sguaiata e volgare, crudele e indifferente, che condivide con Peter Pan l’ambiguo fascino di creatura archetipica «innocente e senza cuore»; Mizoguchi un perdente chiuso nella sua doppia vita mista di rancore e ipocrisia: «…sembrare come gli altri è la cosa più importante, la cosa migliore. È allora che la gente non dubita di noi».
Ma è proprio tale visione super partes degli autori nei confronti dell’ambivalenza spesso scioccante di temi e personaggi – che a tratti sembra quasi indulgente se non addirittura empatica – a farne opere destinate a durare e a diventare potenti icone dell’immaginario. Perché la letteratura, in quanto luogo e punto d’incontro delle direzioni di senso collettivamente condivise, e che pertanto è «la vita vera, finalmente scoperta e tratta alla luce, la sola vita realmente vissuta» (M. Proust, Il tempo ritrovato, Einaudi 1978), non può tessere la sua relazione con le pulsioni inconsce se non andando oltre le maglie delle convenzioni sociali e culturali, dunque al di fuori di qualunque finalità didattica, moraleggiante o politicamente corretta.
Scrive Nabokov nella postfazione aggiunta l’anno successivo (1956) alla prima edizione di Lolita: «Esistono, presumo, lettori i quali trovano solleticante lo sfoggio di parole grandiose come un affresco in quei romanzi irrimediabilmente banali ed enormi battuti a macchina dai pollici di irrimediabili mediocrità e definiti “potenti” e “vigorosi” dalla critica interessata. Non mancano le anime buone che giudicherebbero Lolita insignificante perché non insegna loro qualcosa».
Di fatto la grandezza di Peter Pan, Lolita e Il padiglione d’oro consiste proprio nel non aver concesso nulla al perbenismo del periodo e nell’aver anzi lasciato che attraverso le pagine, nascosto tra le righe, affiorasse in filigrana il nostro lato ombra – quell’inconscio spirito del presente in dinamico rapporto tra realtà e Erlebnis, mondo ed Io – che solo può svelarci, in tutte le sue declinazioni contemporanee, i punti chiave della propria complessità. Ecco allora che lo smarrimento del simbolico, tabù della cultura contemporanea ripiegata in un presente statico che teme il futuro, rivendica prepotentemente il suo spazio: Peter Pan o il ragazzo che non voleva crescere è il titolo completo della pièce che debuttò a Londra nel 1904; di fatto Peter coltiva l’ostinata volontà di rimanere bambino, stigmatizzando con largo anticipo un fenomeno sociale che avrebbe trovato sempre più ampio riscontro nei decenni successivi.
Lontano dall’essere quella creaturina innocua e svolazzante quale ce l’ha consegnata la Disney, Peter in realtà ci dice qualcosa di molto più inquietante: abbiamo perso i genitori, le radici, i punti di riferimento saldi e, con essi, la capacità di progettare e sognare il futuro; infatti se n’è andato di casa per non diventare adulto, e il padre e la madre non l’hanno fatto più rientrare. «Perché sei scappato?» gli chiede Wendy, e ottiene questa risposta: «Perché ho sentito papà e mamma parlare di quello che sarei dovuto diventare quando fossi stato uomo». Analogo abbandono per i Ragazzi Perduti: «sono i bambini che cadono dalla carrozzina mentre la governante sta guardando dall’altra parte. Se nessuno viene a reclamarli entro sette giorni, vengono mandati lontano nell’Isola-Che-Non-C’è».
Molto più simile all’anima selvatica dell’uomo che a un ragazzino vestito di foglie, anche se ha ancora i denti da latte Peter è di fatto una presenza demoniaca, tanto che, quando i ragazzi che abitano con lui sull’isola sembrano diventare adulti — il che è contro le regole — “li sfoltisce” (thins them out), vale a dire li fa fuori o li fa uccidere dai pirati.

Perno di un meccanismo circolare in cui ogni cosa rimane immutata, Peter infatti non conosce nemmeno la sua età: «non lo so, ma sono piuttosto giovane», condividendo con Mizoguchi, per il quale «il mondo è fermo per sempre, e dunque è arrivato a destinazione», una certa ambiguità relativa alla sfera sessuale, anche in questo rifiutando il passaggio alla vita adulta tant’è che entrambi, narcisisti e sfuggenti, hanno bisogno di conferme ma temono gli affetti. Peter non vuole assolutamente essere toccato eppure trova in Wendy l’amore romantico, scatenando la gelosia di Campanellino; Giglio Tigrato è la pellirossa che rappresenta il sesso, l’avventura e l’esotismo, mentre suadenti sirene nuotano tutt’intorno all’isola, riempiendo l’aria dei loro richiami.
Non diversamente equivoco e tormentato è il contatto emotivo col mondo da parte del deforme Mizoguchi il quale, impeditone dalle sue fantasie assolutizzanti, si spingerà fino ad incendiare il padiglione d’oro, emblema di quella bellezza ideale che gli è preclusa. Ambivalenza e inafferrabilità di un codice erotico non meno che sociale – con la sua negazione del mondo reale a favore di un microcosmo costruito secondo proprie leggi – che ritroviamo come caratteristica principale della stessa Lolita e di tutte le ninfette, con la loro «grazia torbida, il fascino elusivo, mutevole, struggitore e insidioso»; né bambine né donne, né umane né divine, né colpevoli né innocenti. Limbo utopistico, illogica realtà «i lidi specchianti e le rosee rupi» dal cui confine riecheggia nella società contemporanea, come un’eco mai spenta, la nostalgia del mito.


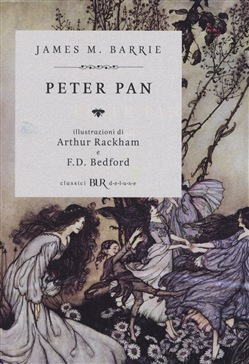



Comments