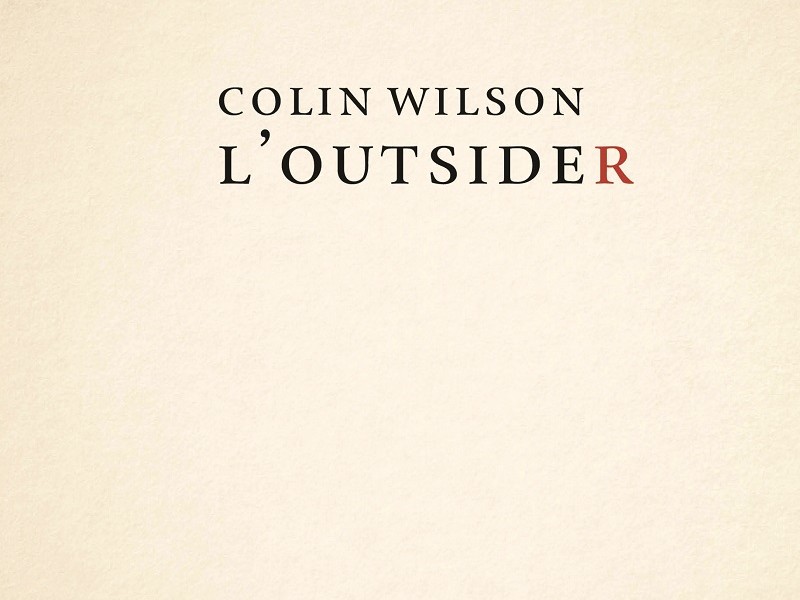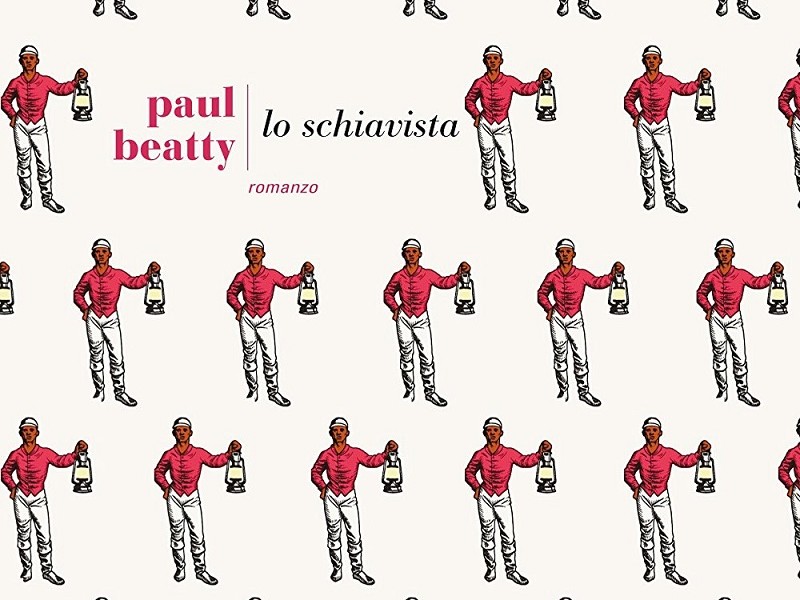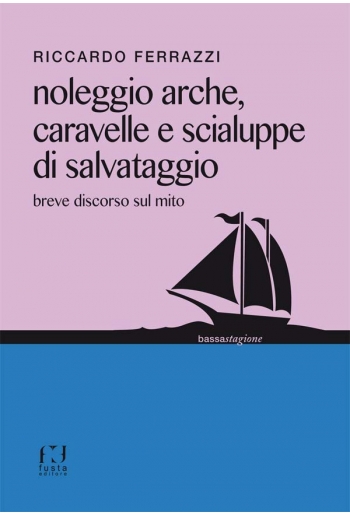Come accade per alcune delle pietre miliari della letteratura mondiale, è facile che anche Per chi suona la campana (1940), il romanzo considerato assieme a Il vecchio e il mare e Addio alle armi tra le cose migliori di Hemingway, risvegli nell’immaginario collettivo più che altro un’eco indistinta, costruita su vaghe reminescenze scolastiche e sull’inarrestabile brusio di citazioni a cui nessuno che abbia a che fare più o meno alla lontana con i libri può sottrarsi.
Ma sia l’idea di Hemingway, sia le frasi estrapolate da questo o da quel contesto, non rendono giustizia a una scoperta lampante, che può avvenire solo leggendolo: e cioè che Hemingway è sorprendentemente moderno. Più moderno dei contemporanei. E che va incontrato a mente libera, come se ci si apprestasse a un viaggio in più direzioni. Allora potrà succedere che i pensieri di Robert Jordan, l’inglés incaricato di minare un ponte di importanza strategica nella guerriglia contro i franchisti, diventino i nostri.
L’odore della terra coperta di aghi di pino, il colore sbiadito di una cartina militare, la fatica dei muscoli nella risalita della parete rocciosa, il senso di diffidenza per il capobanda Pablo, l’abbaglio a prima vista di fronte a Maria, il calore del vino e il sapore del cibo condivisi tra polvere e munizioni sono adesso le nostre percezioni, così come nostro è il senso del dovere rigoroso che dà impulso all’azione.
Far saltare un ponte. Il chiodo martellante attorno al quale ruotano dilatate a dismisura tutte le componenti di Per chi suona la campana. Hemingway ha impiegato 500 pagine per descrivere un’azione che dura sì e no settanta ore, tre giorni e tre notti, raccontati facendo ricorso al vissuto “reale” dei protagonisti, ai loro pensieri – seguendo il filo dei quali ricostruire tratti psicologici e caratteriali distintivi di ogni personaggio –, ad ampi flashback che aprono parentesi su fatti altrimenti non conoscibili, e soprattutto ai dialoghi, che racchiudono frequentemente gli apici della tensione narrativa che percorre tutta l’opera.
La storia in effetti è ridotta all’osso: Robert Jordan, intellettuale americano che ha scelto di supportare le forze antifranchiste, ritorna in Spagna per raggiungere una banda di guerriglieri, con la collaborazione dei quali dovrà far saltare un ponte d’acciaio importantissimo per i fascisti. Sulle montagne, dove i guerriglieri si nascondono, viene a contatto con uno scampolo di umanità eterogeneo, di cui fanno parte tra gli altri Pablo, ambiguo capobanda, Pilar, donna ruvida e sibillina, Maria, giovane repubblicana la cui vita è stata spezzata dalla guerra, e Anselmo, anziano guerrigliero dai profondi scrupoli morali.
L’ansia di non saper portare a termine il compito, insieme al timore di non riuscire a svolgere il proprio dovere, insegue Robert pure dentro allo sbocciare di un fortissimo amore corrisposto per Maria. Il presentimento onnipresente della morte respira addosso a tutti gli uomini, e anche, con diversa tonalità, alle due donne, alimentato dall’orrore risvegliato dai racconti delle stragi e dal ricordo dei soprusi subiti. Qui si innesta l’altra grande tematica del romanzo, quella del suicidio, inteso da un lato come atto di estrema ribellione, dall’altro come gesto di egoismo – complementarità sulla quale si basa una chiave del rapporto di Robert col padre, e la sua visione del destino.
Percorre l’opera un profondo sentimento di comprensione che investe la Spagna, la sua gente e la sua storia, pur con tutti i difetti e le contraddizioni, più intenso della violenza e del fatalismo ben percepibili in controluce. La simpatia per un intero popolo è quella che tramuta in elegia alcuni dei passi più forti, nei quali si mescolano segnali emotivi anche molto discordanti: i valori della solidarietà e del cameratismo da una parte, la paura e l’avversione nei confronti della guerra e della morte, rese attraverso la metafora ricorrente degli aerei in perlustrazione, dall’altra.
Infine non si fa che girare pagine e pagine di Per chi suona la campana, incalzati dalla complessità delle problematiche alle quali i personaggi sono chiamati moralmente a rispondere. Sino a ritrovarsi «dove i pini della foresta finivano e cominciava la verde china del prato», nella stessa scena dell’inizio, come in un circolo, salvo non riuscire a decidere se è tutto come prima, oppure tutto è cambiato.