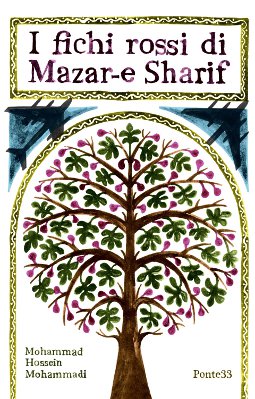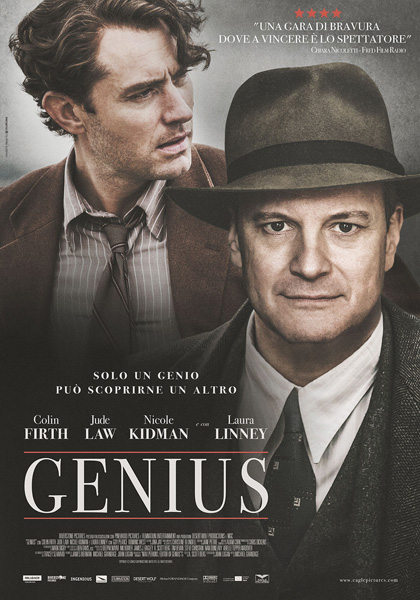«Testimoniare è fare male, nella dose minima ma sufficiente affinché ognuno capisca cosa è stato».
Conforme alla gloria di Demetrio Paolin (Voland, 2016), tra i dodici finalisti del Premio Strega 2016, è un dramma della coscienza. Mostra come la condizione di sopravvissuto trasformi chi lo è stato in una scacchiera su cui si svolgono aspri e sordidi combattimenti. A essere messa in scacco e a soccombere è l’anima: «Io sono tutta superficie. Cosa posso nascondere? Io sono così, se qualcuno mi guarda nel profondo non vede niente. Io sono solo il niente del mio corpo».
Il corpo, estremo confine del dolore e dell’estasi, è il vero protagonista del romanzo. Sono i corpi denutriti, umiliati, mutilati e disumanizzati degli ebrei prigionieri nei lager, un bersaglio perpetuo, un peso paradossalmente ingombrante da portare in giro, una macchia nella storia della Germania in particolare è mondiale in generale. Quei corpi sono lì a ricordarci che è necessario mantenere viva la parte più oscura della storia e della memoria umana, l’ombra sinistra dell’Olocausto: «Non hanno pietà. Non hanno nessuna compassione per il debole. Il debole va estirpato. Il debole è un virus che infetta il sangue. Il loro è un sangue grandioso, è quello che li spingerà all’immortalità». Niente deve essere dimenticato anche se lacera la coscienza dei sopravvissuti e dei figli di quella generazione maledetta.
Sono i corpi bruciati nel rogo della ThyssenKrupp. Da quel tetro passato alle tragedie dell’oggi, la narrazione procede avanti e indietro come una macchina implacabile che cerca di scrostare l’orrore.
Proseguendo nella lettura, si capisce che ci troviamo di fronte a un ingranaggio narrativo spietato le cui ruote dentate sono le rivelazioni relative al passato di uno dei personaggi principali, Rudolf Wollmer. È infatti la morte del padre, Heinrich Wollmer, ex guardia SS nel campo di Mathausen, a mettere in moto un assedio che progressivamente imprigiona Rudolf.
Il peso dell’eredità di questo padre rinnegato sarà molto più gravoso di quanto si possa in un primo momento pensare: «…la colpa, la vergogna, il disonore. Questi sono i doni che mio padre, prima di finire all’inferno, mi ha lasciato».
Se della casa dell’infanzia sarà facile sbarazzarsi, sarà invece impossibile per Rudolf liberarsi di uno strano quadro intitolato La gloria e di tutto ciò che esso rappresenta. Quasi come in una sorta di maleficio, Wollmer vede sfaldarsi, dissolversi la propria esistenza, diventare tutt’uno con la materia del quadro, una materia che è incarnazione letteralmente di tutto il male del mondo.
Quella tela cela un segreto inquietante di cui è custode un ex deportato torinese, Enea Fergnani, tatuatore e artista di body art. Come ogni sopravvissuto, è un uomo alla deriva, mai veramente tornato dal campo di concentramento, che attraverso le sue performance tenta di espiare la colpa di essere ancora vivo a discapito di altri: «Ci è semplicemente bastato sopravvivere a qualcosa di tremendo, ma poi? Abbiamo dovuto venire a patti, decidere cosa fare di questo eccesso di vita […] La nostra esistenza sarà il ricordo costante che gli altri sono morti e noi viviamo e guadagniamo soldi, mangiamo pranzi e cene in nome loro».
La sua vicenda è un susseguirsi frenetico di crudeli istantanee, di immagini e ritratti freddati in presa diretta sull’epidermide di Ana, modella anoressica, «sparita come corpo vivente, rimane la bellezza dei disegni che adornano un palinsesto di pelle».
Conforme alla gloria è un romanzo di presa di coscienza, ambientato in un’atmosfera sospesa di colpa, scritto con uno stile scarno e privo di orpelli. Si legge senza potersi staccare, narcotizza cuore e mente, confonde il male con il bene: «Il male non scompare con la morte di chi lo subisce, il male continua, sopravvive al disfacimento delle carni sofferenti. Filtra nelle esistenze di chi rimane, come il veleno nelle falde e intossica le acque, togliendo la vita».