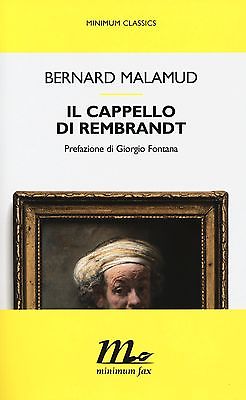Parte da una storia vera, Michele Placido, per il suo nuovo film 7 minuti, una storia di coraggio e resistenza di un gruppo di donne costrette a scegliere tra la sicurezza dell’immediato e la dignità del futuro.
I fatti raccontati sono accaduti in Francia, a Yssingeaux. C’è stato un testo teatrale, poi, di Stefano Massina, che ha avuto un grande successo di critica e pubblico sui palcoscenici italiani. Adesso arriva questo adattamento cinematografico di cui Massina è cosceneggiatore insieme a Placido e Toni Trupia. Dalla Francia ci spostiamo nel basso Lazio, dalle parti di Latina. Al momento dell’acquisto di un complesso industriale tessile da parte di un colosso francese, le rappresentanti delle operaie sono chiamate ad accettare una richiesta dall’apparenza innocua: rinunciare a 7 minuti della pausa pranzo. Le operaie più esperte capiscono in fretta come dietro ci sia un discorso molto più ampio di dignità e iniziano un lento lavoro di persuasione sulle loro colleghe.
Un tema a dir poco attuale, quello del lavoro e della sua difesa, quello scelto da Placido per il ritorno alla regia a un anno e mezzo dallo scellerato La scelta. Cambiano i temi, cambiano i toni e i riferimenti.
Il modello evidente è La parola ai giurati di Sidney Lumet, per costruire un dramma da camera chiusa con una tensione crescente che si deve risolvere in una decisione finale. Lì per la vita di un uomo, qui per il futuro di trecento persone.
Sette minuti, nel bilancio quotidiano di chiunque, non sono niente, soprattutto se la scelta se conservarli o meno potrebbe valere il posto di lavoro. Sette minuti, però, sono la metà della pausa pranzo, che prima era di quarantacinque minuti, poi di trenta, poi di quindici. Rimarrebbero otto minuti, tra un turno e l’altro. Per lavorare si può anche accettare di avere meno tempo per riposare, oggi come oggi, ma che succede poi se chi dà il lavoro si accorge che sette minuti risparmiati ogni giorno su ognuna delle operaie fanno quasi 900 ore di lavoro in più a fine mese, 900 ore che magari non servono e a quel punto, anziché riallungare la pausa, possono portare a esuberi e licenziamenti?
7 minuti ha il merito di proporre, nelle intenzioni, un’immagine sincera, autentica e sofferta del mondo del lavoro di oggi, della fatica quotidiana di migliaia di persone chiamate per portare a casa uno stipendio.
Come capita spesso con le regie di Placido, però, c’è un divario netto tra l’ambizione e il risultato finale. Pur riuscendo a gestire con mestiere la tensione della trattativa tra le operaie, 7 minuti inciampa troppo spesso in limiti di retorica che si riflettono in un’infinità di piccoli aspetti del film, dai discorsi stereotipati alla rigidità dell’impianto teatrale da cui non riesce mai del tutto a liberarsi, fino al limite più grande: l’eccessiva caratterizzazione delle protagoniste.
Con un cast che mette insieme alcune delle attrici italiane più note del cinema italiano d’oggi, Placido finisce per disperdere il potenziale in dei tipi troppo marcati che non conoscono sfumature. Così, vedere Ambra Angiolini che fa la trentacinquenne arrabbiata, piena di tatuaggi e con la passione per la boxe, sembra una presa in giro, così come Violante Placido in sedia a rotelle con ciuffi bianchi che rimpiange i bei tempi in cui andava a correre al parco e non pensava a niente. Come se non bastasse, Maria Nazionale fa la napoletana caciarona e aggressiva che urla tutto il tempo (anche se urlano tutte, non solo lei) e le attrici straniere si limitano a dire che va bene tutto per tenere il lavoro e a cadere in trabocchetti narrativi classici, tipo l’africana che racconta la favola morale della savana.
A salvarsi da una recitazione incerta e sopra le righe sono solo Ottavia Piccolo, nei panni della rappresentante del gruppo – che già aveva interpretato il testo a teatro – e la sorprendente Fiorella Mannoia, a suo agio davanti alla telecamera più di quanto fosse lecito aspettarsi.