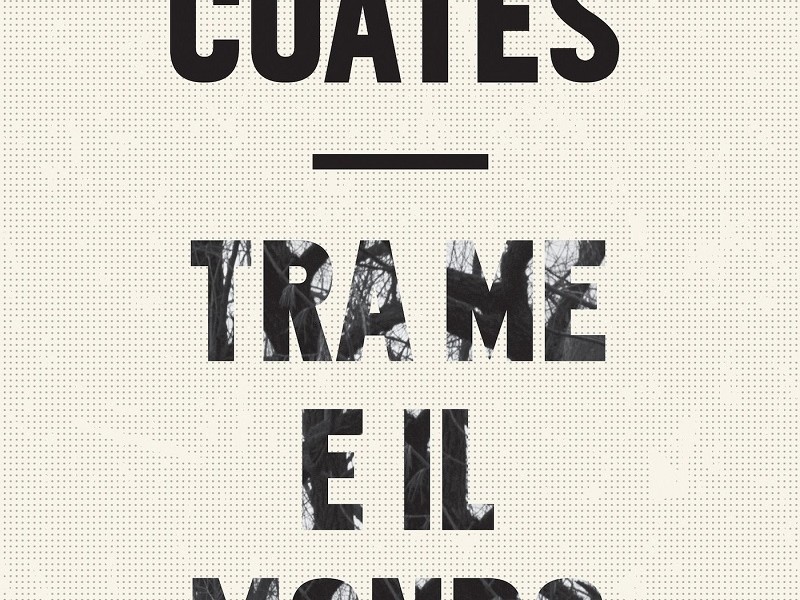Devo dirlo, quando mi arriva una mail da un mittente ignoto, la prima cosa che spero è che non si tratti di un virus o di spam, la seconda è che non sia una scocciatura. Sapere che qualche sconosciuto mi stia cercando e abbia bisogno di parlare con me, raramente mi pone in un atteggiamento di disponibilità, soprattutto perché credo di non avere tempo, di non avere mai tempo. Deve essere per colpa di questo mio atteggiamento che mi sono stupito nel leggere lo schietto ed entusiastico messaggio con cui Simona Lo Iacono, autrice per e/o di Le streghe di Lenzavacche, tra i dodici finalisti del Premio Strega 2016, ha risposto alla mia richiesta di intervista, rendendosi disponibile fin da subito a patto che le spedissi prima un sms, in modo da potersi liberare e dedicarmi tutta la sua attenzione. Una tale apertura mette al bando la misantropia.
E non è un caso se l’apertura è un tratto caratteristico di protagonisti di Le streghe di Lenzavacche : apertura alla vita, ad affrontarla senza mai perdersi d’animo, con la consapevolezza che si può anche essere streghe, si può anche essere emarginati dalla popolazione di quel piccolo paese siciliano in cui è ambientato il libro, ma non si può mai perdere la gioia di vivere. Farlo, a Lenzavacche, è un esercizio che le streghe compiono da quattrocento anni, e la loro ultima erede, Rosalba, riesce a portarlo avanti persino di fronte alla difficoltà di avere un figlio disabile, malfermo sulle gambe e incapace di eseguire i gesti più semplici in autonomia. Felice, è il nome di questo piccolo. Ma sono almeno altre tre le tematiche che accompagnano tutto il corso della lettura: la diversità, il ruolo sociale del libro, la predestinazione.
Partiamo dalla prima. Felice è un bambino sfortunato, che porta addosso tutte le fatiche di una grave disabilità motoria. Nascere negli anni Trenta – in una società che di lì a poco avrebbe adottato le leggi razziali – farlo in un paesino della più remota provincia siciliana, svilisce molte delle possibilità di essere accettato e di imporsi come individuo. Ma questo bimbo non è solo, sua madre Rosalba, la nonna (strega) Tilde, lo stravagante farmacista Mussumeli, sono tutti personaggi che contribuiscono a dargli la possibilità di affermarsi, di essere appunto un individuo. Insomma, tanta parte del romanzo ruota attorno al rapporto tra l’infanzia innocente di un bambino disabile e un mondo che, secondo le leggi che quel mondo si è dato, non dovrebbe accoglierlo.
Sì, il tema principale di è proprio quello della diversità; ed è una diversità che tocca prima di tutto Felice, non a caso il contesto storico all’interno di cui si muove è quello del ventennio fascista. E ho cercato di caratterizzarlo al massimo proprio per mettere in rilievo la diversità del bambino. Sono gli anni delle leggi razziali, ma è anche il periodo in cui in Europa si dibatteva, quando non si praticava, l’eugenetica, con i suoi programmi di soppressione dei disabili, degli affetti da Corea di Huntington, dei sordomuti, dei non vedenti. Felice nasce in un contesto storico fortemente caratterizzato dalla mancanza di accoglienza nei confronti della diversità, che è una caratteristica non solo sua, ma anche degli altri protagonisti, come le streghe, e arriva sino a un altro personaggio, il maestro Mancuso, che ha un’idea di insegnamento sovversiva. Tocca persino il farmacista del paese, Mussumeli, che ha opinioni del tutto originali sull’amore, sull’amicizia, sulla pietà umana. Quindi, certamente il libro ruota tutto attorno all’idea della diversità, ma è declinata come qualcosa che sfugge innanzitutto ai luoghi comuni e al potere costituito. Questo romanzo è pensato anche come un libro sui rapporti tra potere e libertà e paradossalmente la diversità di queste creature, si trasforma nell’affermazione della loro libertà. A scapito di qualunque idea di potere rigido, contro la quale, naturalmente e fatalmente, i personaggi si scontrano.
Mi accennavi, prima di cominciare l’intervista, che nell’ideazione del libro c’entra il tuo lavoro di magistrato. Ti sei imbattuta in un caso concreto che ha ispirato il racconto di come i parenti del bambino Felice facciano di tutto affinché il piccolo possa venire iscritto a scuola.
Spesso mi succede di partire da una scoperta. In questo caso una scoperta avvenuta durante un processo a carico di un professore che ebbe una disavventura con una ragazzina disabile. In quella occasione ho rintracciato un decreto legislativo, ancora in parte in vigore, risalente al 1925: studiando la normativa, mi sono accorta che in quel testo si prevedeva l’inserimento di invalidi e disabili all’interno di classi differenziate. Dato che l’anno del decreto era appunto il 1925, quindi sotto un regime non aperto nei confronti della disabilità, mi sono incuriosita. È una norma che rappresenta ancora oggi l’ossatura della legislazione scolastica in materia, ma che pur passata sulla carta non fu allora mai applicata, e mai invocata da qualcuno. E da lì mi è venuta l’idea: mi sono chiesta cosa sarebbe accaduto se i genitori di almeno un bimbo avessero fatto ricorso alla legge, come sarebbe andata se almeno uno di questi bambini ce l’avesse fatta ad andare a scuola sfruttando una legge che era stata promulgata in realtà a esigenze di propaganda. Ed ecco il personaggio di questo bimbetto.
La nonna Tilde, erede della tradizione delle streghe di Lenzavacche che ricerca anche nelle pozioni la soluzione ai problemi dello sfortunato nipote, a un certo punto dice che «le norme esistono per aiutare gli uomini, non gli uomini per aiutare le norme». Questo è uno dei compiti fondamentali del legislatore.
Nonna Tilde, in modo molto semplice perché lei è una donna semplice, coglie il cuore della legge. La legge è al servizio dell’uomo, non è il contrario. Quando avviene il contrario accade che la legge diventa strumento del potere, e non delle effettive esigenze dell’uomo. Tilde dà voce a una delle vocazioni più alte, più sacre della legge, che è quella proprio di creare armonia nella società, di sedare i contrasti, di andare incontro ai bisogni soprattutto degli ultimi, dei deboli, degli emarginati. La legge ha questa vocazione. Quando accade il contrario, e quindi ci troviamo di fronte a norme pretestuose, sono gli uomini a essere al servizio della norma. Purtroppo in questa epoca di evoluzione frenetica stiamo stravolgendo le regole fisiologiche dei rapporti fra esseri umani. Stravolgendo questi rapporti, non soltanto la società si complica e perde di vista certi valori, ma si mette al servizio di un talune di forze, che invece di aiutarla – al contrario – la involvono. Peraltro la strumentalizzazione della legge è un meccanismo molto abusato, anche oggi, come ai tempi del fascio, persino quando una legge può sembrare in parte giusta: quella legge del 1925 affermava dei concetti corretti, ma non lo faceva con le motivazioni giuste, non lo faceva per mettersi al servizio dei più deboli, ma solo per fare propaganda. Il rischio della strumentalizzazione è quindi sempre in agguato.
Diversi episodi di Le streghe di Lenzavacche sono dedicati ai libri, alla loro forza, alla loro capacità di essere sovversivi e magici. L’incontro fra Rosalba e l’arrotino padre di Felice avviene attraverso un libro, la stessa nascita delle streghe di Lenzavacche origina dalla passione che una donna del 1600 ha per la lettura. Passione che la condanna a essere allontanata dal marito. Insomma, a tratti hai scritto una celebrazione del fare e del godere della letteratura.
Il libro è sovversivo per eccellenza, in effetti, perché non è solo un vaso che raccoglie le storie; è uno strumento di conquista di sé stessi e della vera dimensione dell’esistenza. È un mezzo di grande libertà, ed è capace di mettere in vera comunicazione, in vera relazione gli uomini. Non è un caso se Rosalba, l’arrotino, e le vecchie streghe comunichino anche attraverso i libri. Una storia, un racconto, una narrazione è portatrice di senso, di significato, e quindi contiene un sé un percorso, che è anche un percorso di natura morale, e come tale è uno strumento pericolosissimo che va contro il potere precostituito e contro qualunque genere di costrizione. Da qui, il potenziale del libro. In tutto il romanzo, il fatto di amare la lettura è un elemento dirompente nella vita dei personaggi. Ma come può essere dirompente, allo stesso modo può unire i destini. Accade dunque che le storie servano a creare delle relazioni positive. Come avviene per Rosalba e per gli altri personaggi, le storie salvano da un destino anche molto difficile. E quindi sono uno strumento oltre che di rivoluzione anche di speranza.
Il giovane maestro Mancuso è l’estensore delle lettere che chiudono ogni capitolo, indirizzate a una zia di cui nulla sappiamo fino alle ultime pagine. A lei narra la sua esperienza a Lenzavacche. Predilige una didattica inconsueta: entra in classe e comincia a leggere storie. Di nuovo la forza terapeutica e pedagogica del racconto, anche se molti di questi bambini muoiono di sonno in classe, perché quando sono in famiglia debbono aiutare i genitori, magari nel lavorare la terra. Si impegna, Mancuso, con passione ma in un modo assolutamente non ortodosso e lo scontro col direttore dell’istituto sarà inevitabile. È da questo scontro che tratteggi uno spaccato di cosa volesse dire fare l’insegnante in epoca fascista, quali le direttive, quali gli obblighi: una pregressa attività di ricerca documentaria deve esser stata necessaria.
C’è certamente tutta una ricerca sulle circolari ministeriali del tempo. Documenti nei quali non vi erano soltanto delle istruzioni di natura organizzativa, ma tutto un decalogo sul metodo di insegnamento per l’indottrinamento. Lo scopo, naturalmente, era quello di far sì che ciascuna materia, in un modo o nell’altro, contribuisse nell’inculcare ai ragazzi i valori fascisti. Tutta la storia era vista come una preparazione all’avvento dell’era fascista, e testimone ne è la nuova numerazione del calendario. Quindi ogni materia concorreva a questa strumentalizzazione, ai fini di una crescita dell’individuo finalizzata all’acquisizione definitiva di quel genere di valori. Qualunque materia, compresa l’educazione fisica, doveva esaltare il regime. Mancuso intacca questo equilibrio e la sua classe, inizialmente composta da trenta elementi, si spopola man mano, perché i genitori cominciano a ritirare i ragazzi. Questi erano incantati dai racconti di Mancuso e sentono una forte intimità con l’arte della narrazione, ma non possono proseguire quelle lezioni perché costretti a obbedire ai genitori.
L’intreccio narrativo ci dirà come Mancuso opporrà resistenza a tale giogo e quale aspetto del suo passato lo leghi a Rosalba e alle streghe. Linguisticamente, in Le streghe di Lenzavacche ci troviamo di fronte a tre registri: il primo che si incontra leggendo l’incipit è quello intimo e dolcissimo di una madre che narra direttamente al proprio figlio i primi anni della sua vita: «La prima volta che ti vidi eri talmente imperfetto che pensai che nonna Tilde avesse ragione». Ogni capitolo, dicevamo sopra, è chiuso da una lettera che Mancuso invia a una zia, nelle quali la scrittura si fa più adulta, più descrittiva, non priva di afflati, ma certamente meno intima. E infine, tutta la seconda parte del volume è uno strappo stilistico con le pagine precedenti: una scrittura testamentaria del ’600 che richiede più impegno nella lettura: «Io, Assennato Corrada, nel pieno delle capacità mie di donna maliarda, et sanzo peccato, avendo ricevuto sacramentum riconciliationis».
L’idea è che la voce sia al servizio delle storie. E cioè, non è tanto lo scrittore che imprime il proprio modo di scrivere alla storia, ma è la storia che chiede di essere scritta in un certo modo. Quindi l’autore è una sorta di interprete, che si deve adeguare a ciò che la storia richiede. E allora, quando a parlare è Rosalba, ho cercato di fare in modo che il suo racconto trasmettesse tutta la passione che la spinge verso il figlio e verso l’arrotino. Mancuso ha uno stile epistolare. Quando viene alla luce questo testamento del ’600, ho adottato uno stile simile a quello dei documenti dell’epoca, sebbene levigandolo un po’ per non rendere davvero difficoltoso riuscire a seguire gli eventi, ma l’ossatura rispecchia lo stile dei notabili di allora. Anche la numerazione dei fogli ripete e ricalca quella in uso in età moderna, necessaria non solo per evitare che qualche pagina venisse sottratta, ma anche per calendare i fatti descritti in ciascun capitolo in base all’argomento trattato (Folius primus di folii dieci. Come sarìa che Corrada Assennato decise di farsi letterata). Il costrutto sintattico, la promiscuità con il latino, sono frutto di un lavoro di analisi di testi come il Codice rosso di Sortino, che raccoglie i banni e i comandamenti d’ordine dei feudatari dei dintorni di Siracusa. Si tratta di una quantità di editti che questi signori emettevano nei confronti dei propri sottoposti e quindi forniscono una serie di dettami e ammaestramenti rivolti a chi amministrava le loro terre. Ed erano dei più vari tipi: riguardavano la caccia, la pesca, la moneta da utilizzare, ma anche questioni di vita quotidiana e sociale, come per esempio i costumi delle donne. Ho attinto a piene mani da questo documento per appropriarmi di un linguaggio che chiaramente è molto lontano dal nostro. Il testamento posto nella seconda parte del volume deve dare la sensazione di tornare veramente indietro di quattrocento anni. Perché è con questo salto nel tempo che si spiegano molte delle cose che coinvolgono i protagonisti. E quindi la lingua è al servizio di questa strategia temporale, se vogliamo: necessitavo di uno stacco molto forte fra la prima e la seconda parte del romanzo e tale stacco sarebbe dovuto passare anche attraverso la lingua.
Dunque, i tasselli del mosaico, separati e anche molto lontani nella prima parte, si ricompongono nella seconda. È una partita in cui il destino ha un ruolo fondamentale e resta la sensazione che i personaggi poco possano contro di esso: Tilde che cuce la propria coperta di morte, il padre di Felice, l’arrotino, che incontra Rosalba e capisce da subito di non poter sopire quel legame anche se sarà un legame di sofferenza, lo stesso Mancuso è in Sicilia non solo per insegnare, ma anche per rispondere al richiamo di un suo misterioso passato.
Ma è un destino che offre una seconda possibilità. Ciò che la storia ha ferito in passato può essere ribaltato, e quel che si è perduto può essere recuperato in un momento successivo. Nei fatti, tutta la vita di Felice e di Rosalba, che noi vediamo nella prima parte del romanzo, è un ripianamento di ferite che erano state inferte alle streghe nel 1600, come se queste ferite potessero cicatrizzarsi solo ritornando su loro stesse. Rosalba ricuce il rapporto strappato con gli uomini, che nella prima parte della storia sono stati profondamente violenti nei confronti delle donne; il maestro Mancuso riscopre un particolare fondamentale del suo passato proprio a Lenzavacche, e le streghe tutte hanno una possibilità di riscatto. Questo destino offre una rinascita, una rivisitazione. Quello che si tenta di suggerire è proprio questa seconda opportunità.
La chiacchierata con Simona Lo Iacono prosegue, e si finisce a parlare di processioni cristiane, di qual è il confine settentrionale dell’Italia meridionale, di Roma, delle dimensioni spropositate di questa città, del traffico e del fatto che qui gli arrotini hanno il disco registrato e girano su delle Peugeot 206, ma questa è evidentemente un’altra storia.
(Simona Lo Iacono, Le streghe di Lenzavacche, edizioni e/o, 2016, pp. 160, euro 15)