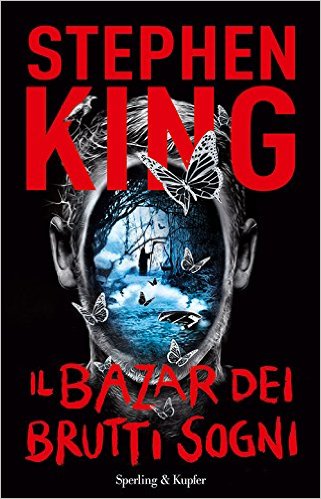Il cinghiale che uccise Liberty Valance è il primo romanzo di Giordano Meacci, 45 anni, già autore per minimum fax di una raccolta di racconti (Tutto quello che posso, 2005) e di un saggio su Pasolini insegnante (Improvviso il Novecento. Pasolini professore, 2000, poi di nuovo 2015). Nell’ultimo anno, Meacci è stato un nome importante anche al cinema per aver scritto, insieme a Francesca Serafini e al regista, la sceneggiatura di Non essere cattivo, l’ultimo film realizzato da Claudio Caligari prima della morte.
Il cinghiale è stato accolto molto bene dalla critica, se ne è parlato tanto, soprattutto per la capacità di Meacci di creare un linguaggio completamente nuovo. Finora, ha vinto il premio Lo Straniero, fa parte dei finalisti del premio Procida – Isola d’Arturo – Elsa Morante, ed è entrato nella cinquina dei finalisti del Premio Strega 2016.
Meacci ha immaginato un paese tra Toscana e Umbria, Corsignano, sospeso insieme ai suoi abitanti tra il 1999 e il 2000, in un continuo oscillare del tempo, e un cinghiale, Apperbohr, che d’improvviso inizia a capire il linguaggio degli uomini e ad avere coscienza di sé e della propria esistenza.
Abbiamo deciso di affrontare Il cinghiale che uccise Liberty Valance con una lettura doppia. Francesco e Luigi lo hanno letto in contemporanea e si sono scambiati impressioni usando i messaggi del cellulare nel corso della lettura. Lo hanno fatto mesi fa, ma poi non hanno avuto la costanza di tirare fuori un articolo. Hanno ripreso a farlo adesso, per arrivare a delle conclusioni prima dell’annuncio del vincitore del Premio Strega.
Francesco: È passato un bel po’ di tempo ormai da quando ho finito di leggere Il cinghiale. Ho letto molti altri libri nel frattempo, ma posso dire tranquillamente che riprendendolo in mano mi accorgo che ho ritrovato subito le sensazioni che avevo provato leggendolo la prima volta. Da un lato c’è ammirazione e meraviglia per la capacità di inventare uno – o più – linguaggi, costruire un mondo, muoversi avanti e indietro sul piano temporale tenendo insieme una massa di fatti, personaggi e storie intrecciate tra di loro. Dall’altro, un fastidio profondo per quello che comunque mi continua a sembrare, a tratti, un puro e semplice sfoggio di talento, un’ostentazione narcisistica di stile.
Luigi: Sì, stesse sensazioni, anche se nel tempo non sono riuscito a non apprezzarlo. Ho ricordato quante volte ho letto le prime pagine, e non perché mi piacessero particolarmente. Non capivo nulla. Proprio nulla. Leggevo cinque, dieci pagine e mi dicevo: «Ma che roba è questa? Perché mi vuoi prendere in giro, Meacci?» Ho pensato di lasciar perdere più volte, ero affranto. Mi sembrava di leggere in una lingua studiata male al liceo.
Francesco: Esatto. Le prime pagine sono state le più dure da mandare giù. La sensazione era quella di essere di fronte a qualcosa di inutilmente complicato.
Luigi: La domanda è, allora: perché lo abbiamo continuato a leggere? Forse, nonostante tutto, avevamo captato qualcosa di estremamente valido nel Cinghiale. Altrimenti non si spiega, no?
Francesco: Io sono andato avanti con la lettura perché non ho mai lasciato un libro a metà. È un discorso di principio, posso sempre trovare qualcosa, anche solo una parola usata bene, che possa giustificare il tempo che dedico a un libro. Poi c’è un discorso che possiamo chiamare di aspettativa sociale, o culturale. L’entusiasmo generale intorno al libro – era tutto un articolo dopo l’altro di elogio – ha spinto la curiosità oltre la fatica. E senza dubbio ne è valsa la pena. La parte che ho apprezzato di più in assoluto è stata quella centrale, quando ormai mi ero abituato allo stile e avevo iniziato a perdermi appresso a cinghiali e corsignanesi.
Luigi: Io ne ho lasciati molti di libri a tre quarti, metà, un quarto. Però questo, non so. È vero, se ne parlava molto. Moltissimo. E forse questa cosa ha influito sulla mia resistenza. Dopo diverse riletture iniziavo a intravedere degli spiragli di luce. Mi accorgevo che iniziavo a capire. Non so come, ma capivo il senso di quelle strutture grammaticali strambe e di quel lessico un po’ folle. Iniziavo a capire Il cinghiale. Ancora oggi non so come, ma appena è scattato quel qualcosa nella mia testa, ho iniziato a leggerlo realmente.
Francesco: Però per me il momento d’oro si è esaurito dopo un po’. Facendo un discorso semplicistico di quantità, Il cinghiale ha circa 450 pagine. Diciamo che le prime 150 le ho lette con fastidio crescente. Cercavo di capire dove volesse andare a parare, perché se ne parlasse tanto bene ovunque, cosa fosse che non capivo per farmi unire al coro degli entusiasmi. Tutto sommato, la sensazione prevalente era quella di essere preso in giro da un esercizio intellettualoide che in qualche modo aveva raggiunto il consenso quasi unanime della critica dei lettori forti. Poi, scavalcato il primo terzo del libro, l’opinione è cambiata: ho iniziato ad apprezzare le sfumature, ad addentrarmi nella trama, a voler tornare indietro per capire meglio cosa non avevo ancora capito. In sostanza, mi sono piacevolmente perso nella lettura. Non sono arrivato all’entusiasmo, quello no, ma ho iniziato a capire un bel po’ di cose del consenso generale. Solo che poi l’incanto si è rotto di nuovo andando avanti. Non sono tornato indietro, alla sensazione di essere preso in giro, alla distanza tra il libro e la lettura, ma è tornato a prevalere il fastidio per qualcosa di esagerato, a tratti gonfio.
Luigi: Io l’entusiamo l’ho provato almeno una volta: quando Apperbohr prende coscienza di sé come essere pensante. Quando cerca, attraverso il linguaggio, di formulare concetti. E lo strazio di trovarsi a metà tra i suoi simili, i cinghiali, e gli uomini: non è né uno, né l’altro. Lì Meacci mi ha steso.
Francesco: Effettivamente la scoperta della coscienza di Apperbohr è un momento emozionante. Mi ha fatto venire in mente un filosofo francese che avevo studiato per laurearmi, Maurice Marleau-Ponty, e i suoi studi sulla percezione del sé nel mondo. Quello, sì, è un grandissimo momento.
Luigi: Meno entusiasmo, invece – molto meno –, l’ho provato durante le disquisizioni su L’uomo che uccise Liberty Valance di Fabrizio e Walter. Non che in paese bisogna essere per forza ignoranti, per carità, però la qualità di quei discorsi sembrava fuori contesto. Non potevano appartenere davvero a quelle persone. Tra l’altro: io e te abbiamo anche visto insieme il film di Ford. Hai più ripensato per quale motivo Meacci abbia scelto proprio quel film?
Francesco: Il problema di immergere cultura alta in contesti non adeguati, secondo me, è un problema comune a tanta parte della letteratura italiana contemporanea, che parla a se stessa e di se stessa, quindi dà per scontato che la gente passi le notti a guardare e riguardare i film di John Ford analizzandoli fotogramma per fotogramma.
Poi, perché Meacci abbia scelto quel film non lo so. Forse mi viene da dire che il personaggio di James Stewart è l’equivalente del cinghiale nel romanzo. Entrambi sono personaggi esterni al contesto in cui vivono, di cultura e coscienza superiore, ma che alla fine sono costretti comunque a misurarsi con la componente istintuale e più primitiva di loro stessi. James Stewart accetta il duello con Liberty Valance suo malgrado, pur non ritenendola una forma di giustizia, così come Apperbohr guida la rivolta, chiamiamola così, dei cinghiali, pur non volendo la violenza.
Luigi: Certo, a pensarci bene pensiamo che sia più credibile che un cinghiale prenda coscienza attraverso il linguaggio che due ragazzi di paese siano in fissa con un film di John Ford. Non ci avevo pensato fino a ora.
Francesco: Il discorso che fai è giusto fino a un certo punto: la rivelazione di Apperbohr è l’unico elemento fantastico, o irrazionale, in un romanzo comunque attento a mantenere l’aderenza al reale. Quello che dico e che pensiamo entrambi è che il reale va benissimo, ma perde di credibilità nel momento in cui inserisce un livello culturale fuori registro nei dialoghi, siano le disquisizioni maniacali sul film o i due cugini, Andrea e Durante, che fanno a gara a chi sa più cose.
Luigi: Non capisco se è un limite o un pregio. Il momento di Apperbohr è molto più reale, molto più intriso di realtà, dei due ragazzetti malati di western o di quegli altri due che parlano in greco antico. Forse in questo si riassumono le difficoltà che ho avuto e ho con Il cinghiale – sintassi e lessico a parte.
A proposito: ricordi quando ti dicevo che Il cinghiale era Gadda scritto da Ammaniti (e viceversa)? Inizialmente pensavo di averla sparata grossa, sul versante Gadda, e forse lo penso ancora: però secondo me può rendere l’idea di che tipo di libro è. Ricordo anche che tu non l’avevi presa molto bene questa definizione, no?
Francesco: No no, io l’avevo presa bene, ci sta tutta come sintesi iperbolica. Anche perché il linguaggio è la cifra più evidente del libro. Tu dici Gadda – e io ti do ragione come se avessi letto mai qualcosa di più di qualche pagina del Pasticciaccio brutto –, altri tirano in ballo Calvino, Cassola, Faulkner, Cortázar. Nel commentarlo si sono soffermati tutti quanti sul linguaggio, che è l’aspetto più potente del libro, sia esso quello di Apperbohr che si approccia al mondo degli umani, sia quello degli uomini, quella fusione di dialetti che appunto fa molto Gadda.
Giorgio Vasta, nella sua recensione su Il Manifesto, ha paragonato Apperbohr a San Paolo sulla via di Damasco: «La luce che lo abbaglia non lo redime ma lo precipita nel baratro del linguaggio», e questa cosa qui, del baratro del linguaggio, è molto bella, «Perché il presentimento della lingua – la possibilità che i suoni significhino e che in ogni loro miscuglio ci sia l’ambizione (se non la tracotanza) di estrarre dal mondo qualcosa di comprensibile – non potrà che essere per lui gloria e tormento, ciò che suo malgrado lo separa da tutti, siano essi cinghiali o umani, costringendolo in un punto intermedio, a metà del guado, uno spazio-tempo minuscolo e insieme smisurato in cui non può stare nessuno se non lo stesso Apperbohr e la sua esperienza delle parole».
Questa lettura mi fa pensare a una visione cristiana del Cinghiale: non punto di incontro tra umano e divino, come il figlio di Dio, ma tra umano e bestiale e di conseguenza incastrato nella distanza immensa tra i due mondi tra cui è ponte.
Forse, tornando indietro al perché Meacci abbia fatto girare tutto intorno al film di John Ford, una risposta la si può cercare nella portata iconoclasta del film sull’immaginario western, nello sguardo diverso sul mito della frontiera, rinchiusa con Liberty Valance tutta nella cucina di un saloon, che il personaggio di James Stewart portava contrapposto alle dinamiche abituali dell’eroe – John Wayne – e dell’antieroe – Liberty Valance.
Stewart è un personaggio esterno, un uomo di città, di legge, che osserva e inquadra il mondo del West rivelandone le illogicità. Allo stesso tempo, però, comprende i limiti del mondo di diritto che rappresenta, così come Apperbohr, comprendendo all’improvviso l’uomo, si trova a essere in mezzo alle due condizioni, senza riuscire a essere nulla, né uomo né animale. Anche il cinghiale guarda dall’esterno l’uomo e ne capisce la natura molto più di quanto possa fare l’uomo stesso, con la potenza rivelatrice delle prime volte che questa sua Epifania sensoriale scatena.
Per rimanere sul cinema, c’è un film di Robert Bresson completamente folle, Au hasard Balthazar, del 1966. Il protagonista è un asino. Non è uno di quei film con gli animali parlanti o tipo 4 cuccioli da salvare. È un asino che passa per vari proprietari e finisce sempre peggio. Anche qui il punto di vista animale serve a inquadrare l’umanità nelle sue miserie, come ha fatto Meacci con Apperbohr.
Luigi: Allora: non come risponderti, nel senso che mi sembra una tesi intrigante e possibile – per quanto non conosciamo ovviamente l’intento di Meacci –, ma io credo che tutto ruoti attorno alla lingua come plasmatrice della realtà, infatti Apperbohr prende coscienza di sè quando si accorge di sviluppare idee e concetti. Si trova di fronte a un altro mondo, derivato proprio dalla nuova lingua. Ma non sono un filosofo, quindi evito di addentrami in un discorso eccessivamente complesso.
Francesco: Quale sarebbe la tesi intrigante?
Luigi: Quella del cinghiale cristiano. Probabilmente una cosa non esclude l’altra
Francesco: Vabbè ogni figura di eroe ha in sé l’elemento del Cristo, pure Jon Snow. Non è che volevo dire che è un libro cristiano, solo che la rappresentazione del cinghiale può essere accostata a quella di Gesù. Comunque, provando ad arrivare a delle conclusioni, a riparlarne adesso a mesi di distanza dalla prima lettura, mi rendo conto di quanto Il cinghiale che uccise Liberty Valance sia il classico libro “importante”, quello di cui si parla, lo si analizza e se ne discute.
Luigi: La sensazione, infatti, per me è che, comunque la si pensi, si parla di letteratura di un certo livello.
Francesco: Forse dico una fesseria, ma mi sa che era dai tempi di Vasta e di Il tempo materiale che non c’era qualcosa del genere nella letteratura italiana. Forse Luciano Funetta quest’anno, forse in misura minore La ferocia lo scorso anno.
Luigi: Non voglio addentrarmi nel discorso Funetta, ma secondo me non sono comparabili.
Francesco: Perché non sono paragonabili? Io non parlo del libro, io parlo del tipo di portata che hanno avuto nel dibattito critico.
Luigi: Sì, da questo punto di vista certamente.
Francesco: Questo comunque non toglie che lo Strega lo vincerà Albinati con La scuola cattolica. È il classico libro che vince un premio come lo Strega.
Luigi: Pure per me – ce l’ho sulla scrivania ma ho paura di leggerlo. Volevo iniziare un discorso sul fatto che gli Strega di solito sono libri più o meno commerciali, ma mi sa che andiamo fuori tema.
Francesco: Diciamo che se vai a vedere gli ultimi, che ne so, dieci anni si sono alternati successi commerciali a libri fatti apposta per i premi letterari, ma non diciamo altro. Certo che Il cinghiale, per quanto se ne è parlato, e per quanto se ne è parlato bene, potrebbe essere una novità di un certo peso
Luigi: minimum fax ha mai vinto? Anche da quel punto di vista lo sarebbe.
Francesco: No, credo che sia addirittura la prima volta in cinquina, ma lasciamo perdere che rischiamo di fare un discorso sul fatto che vincono sempre le case grandi eccetera che non ci riguarda neanche.
Luigi: Infatti.
(Giordano Meacci, Il cinghiale che uccise Liberty Valance, minimum fax, 2016, pp. 452, euro 16)