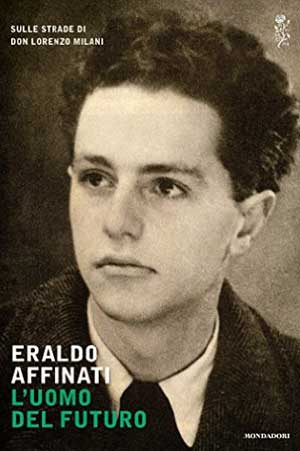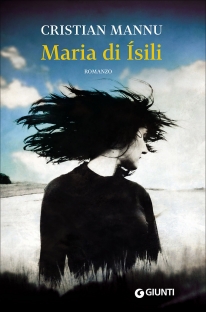Profugěre in latino significa “cercare scampo”. Le pagine della Storia del Terzo millennio sono continuamente riscritte dalle storie di milioni di profughi in fuga da lotte intestine, persecuzioni e carestia. Il mare ormai quotidianamente inghiotte e rigurgita centinaia di corpi sulle coste libiche o cretesi. Imbarcazioni fatiscenti e stracariche di uomini, donne e bambini percorrono ogni giorno la rotta balcanica che si è trasformata in un sentiero di morte. Il Mediterraneo è diventato l’orizzonte di un desolato presente e l’Europa un posto dove si arriva morendo.
Questa è la realtà che ci sbatte in faccia Hakan Günday, lo scrittore turco, 39 anni, della generazione successiva a quella dei grandi Orhan Pamuk ed Elif Shafak, in Ancóra (Marcos y Marcos, 2015). Grande osservatore dell’umanità, a Istanbul, la città dove vive, pur essendo nato a Rodi (è figlio di diplomatici), invece di frequentare i corsi di Scienze politiche, si fermava spesso in un caffè davanti all’università, a guardare la vita che gli scorreva davanti.
Ancóra è il suo secondo romanzo con cui ha vinto il Prix Mèdicis 2015. Gazâ, questo il nome del protagonista, ha vissuto una vita durissima senza madre e con un padre, Ahad, trafficante di migranti, un passeur, ovvero un trasportatore di persone disperate in un camion fino agli imbarchi sulle rive dell’Egeo. «Uno dei mestieri più infami del mondo».
è il suo secondo romanzo con cui ha vinto il Prix Mèdicis 2015. Gazâ, questo il nome del protagonista, ha vissuto una vita durissima senza madre e con un padre, Ahad, trafficante di migranti, un passeur, ovvero un trasportatore di persone disperate in un camion fino agli imbarchi sulle rive dell’Egeo. «Uno dei mestieri più infami del mondo».
Per Ahad non sono persone ma merci. Li carica sul furgone e li nasconde sottoterra nella cisterna del suo giardino controllata da Gazâ. Ed è questa umanità dolente, terribilmente attuale, al centro del romanzo. Sono i profughi che sbarcano in Turchia e si disperdono in Europa. Sono rassegnati, umiliati, disumanizzati. La Turchia è divenuta negli ultimi anni, soprattutto a seguito della guerra in Siria, uno dei principali gestori dei flussi migratori da Asia e Medioriente verso l’Europa: «La differenza fra l’Oriente e l’Occidente è la Turchia. Non so se sia il risultato della differenza tra Est e Ovest, ma la distanza fra di essi è grande quanto la Turchia […] Il nostro paese è un ponte antico, con un piede scalzo a Oriente e l’altro infilato in una scarpa a Occidente, da cui transita qualsiasi merce illegale. Per il nostro ventre passa ogni cosa. Specialmente gli uomini chiamati clandestini…E noi facciamo del nostro meglio…Li ingoiamo e, per non strozzarci, li mandiamo via. Là dove devono andare…».
Sono afghani, pachistani, siriani e iracheni, che in turco conoscono una sola parola, Daha, “Ancóra”, ancora acqua, ancora cibo, ancora aria.
Il libro è stato pubblicato in Turchia nel 2013, quando le cose atroci che lo scrittore ha immaginato sembravano solo fiction. La realtà ha di molto superato la fantasia come possiamo quotidianamente vedere in tv. A offrire lo spunto per Hakan Günday sono state poche righe di un giornale sull’arresto, in una piccola città turca affacciata sul mar Egeo, di una banda di malfattori. Fabbricavano giubbotti di salvataggio pieni di segatura, che non potevano galleggiare, per venderli alle famiglie di clandestini che cercavano di raggiungere la Grecia su imbarcazioni di fortuna.
È una storia di puro orrore, narrata con lucida ferocia, dove non si trova altro che buio, una storia piena di puntini di sospensione per la materia scivolosa e inenarrabile che tratta. La realtà è oscena. La deriva non risparmia nulla e nessuno, una realtà pesante come l’aria da respirare di una speranza guasta. In questo contesto il protagonista cresce, travolto e contaminato dal male e dalla violenza. Chi intende fare la sua conoscenza si troverà di fronte a uno degli sguardi più visceralmente cinici e gelidamente accurati che nella letteratura attuale si posa sull’inconveniente di essere nati.
Perché il male è irresistibile? Perché tutti mentono, tradiscono, corrompono, evitano responsabilità e si fanno complici di delitti?
Gazâ è senz’altro anche una vittima: vissuto senza madre, fin da bambino è stato costretto dal padre Ahad (daha al rovescio) ad aiutarlo nel commercio di esseri umani. È cresciuto in un ambiente completamente permeato dalla violenza, quella fisica esercitata sui migranti e quella psicologica esercitata su di lui. Ma è anche un terribile carnefice: in una scena minaccia di annegare tutti i clandestini nascosti nella cisterna installata nel suo giardino pur di ottenere un rapporto sessuale con la profuga più bella del mondo: «Loro pensavano che io fossi un mostro e io lo diventai».
L’unico gesto di umanità proviene da Cuma (“Venerdì” in turco, che richiama non tanto il personaggio di Daniel Defoe quanto quello di Celine), un prigioniero afghano ucciso per asfissia da una dimenticanza del ragazzo (si accorge di non aver acceso il ventilatore nel camion che lo doveva trasportare verso la salvezza, ma ormai è troppo tardi per evitare la tragedia). Prima di partire, l’uomo gli aveva regalato un origami, una piccola rana di carta che farà da guida a Gazâ durante la sua odissea, verso una possibile redenzione da tutto il male fatto e subito. La voce di Cuma, portavoce della coscienza del protagonista, costringerà Gazâ nei momenti più duri della sua esistenza a confrontarsi con se stesso, in un dialogo che si svolge tutto all’interno della sua testa.
Ancóra è un ininterrotto monologo, quasi urlato, cosparso come è da punti esclamativi, dove Gazâ si confessa usando un linguaggio furioso. Tutto il racconto non concede nulla all’empatia, anzi è respingente e a volte insopportabile. Sono pagine sconvolgenti, eppure terribilmente efficaci. L’unico interesse che il ragazzo nutre per quell’ammasso di carne umana è puramente scientifico.
In realtà, Gazâ non è affatto un bruto ignorante come il padre. È intelligente e bravo nello studio. Il suo desiderio è fuggire per andare a studiare all’università in Inghilterra. Ma Günday manda in frantumi il classico schema del ragazzo che si salva attraverso l’istruzione. Al contrario, la sua genialità e la sua sete di conoscenza lo portano ad essere persino peggiore del padre: «Non c’era alcuna differenza tra me e Ahad. Non mi importava niente di ni niente, proprio come a lui. Mi ci voleva un po’ di tempo per accettare questa realtà, tutto qua. Ci vuole tempo per abituarsi non solo al mondo esterno, ma anche a sé stessi».
È un vortice di Male che si autoalimenta. Costringe gli uomini e le donne rinchiusi a una specie di mostruoso esperimento sociologico, registrandone con cura, attraverso un sistema di telecamere, proprio come un entomologo osserverebbe un formicaio, le reazioni di fronte a situazioni di pericolo di esseri umani talmente disperati da rinunciare ai propri diritti più elementari pur di fuggire dall’orrore e la povertà sofferte in patria, dilaniata da decenni di guerra civile, per capire come si comportano gli esseri umani e quanto riescano a sostenersi o a scannarsi. Ne ricava persino un saggio dal titolo paradigmatico La forza del potere, ossia il potere di vita o di morte in mano ad un adolescente. Da questo campo di osservazione antropologica privilegiato, giunge dunque a una cruda filosofica visione della società come hobbesiana guerra di tutti contro tutti, dove la sottomissione al dominio è fondata sulla paura.
È a questo punto del romanzo che la tensione accumulata esplode. Gazâ precipita insieme al padre con un carico di clandestini in un precipizio. Muoiono tutti tranne lui che rimane per 13 giorni sepolto da quegli stessi corpi che aveva imprigionato. È l’inferno. Quando si risveglia in un letto di ospedale e apprende della morte del genitore, capisce di essere finalmente libero e di poter così iniziare una nuova vita. Ma il livello di corruzione morale raggiunto sembrerebbe non consentire il lieto fine. Gazâ impazzisce. Nell’ospedale psichiatrico in cui viene rinchiuso, il suo vicino di letto Şeref gli chiede: «Quindi quand’è che il male si trasforma in bene? Dove? Perché il male si trasforma in bene, giusto? Secondo te non è così?». Günday non fornisce risposta a queste domande. L’esergo di Rimbaud («L’unica cosa insopportabile è che nulla è insopportabile») rivela che di intollerabile a questo mondo non c’è proprio nulla, che ci si adatta anche alle atrocità più impensabili, che persino un bambino può diventare un mostro.
(Hakan Günday, Ancóra, trad. di Fulvio Bertuccelli, Marcos y Marcos, 2016, pp. 500, euro 18)