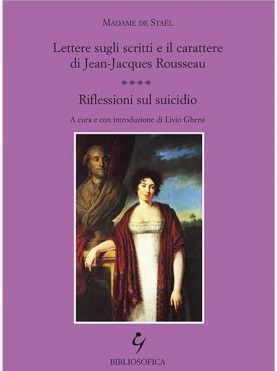L’ambizione di uno scrittore spesso è provare a consegnare al lettore, attraverso le sue opere, un mondo più complesso di quello da lui inizialmente immaginato. La narrativa trasmette emozioni, ci consola, ma nello stesso tempo, con la sua parola libera, interroga la complessità del reale e ci aiuta a comprenderla.
I racconti di Puntazza di Simone Innocenti (L’erudita, 2016), cronista del Corriere Fiorentino, appassionato d’arte e letteratura, colui che diffuse il 16 gennaio 2012 in anteprima mondiale il file audio «Vada a bordo, cazzo», pronunciato dal capitano De Falco rivolgendosi al comandante Schettino, a seguito del naufragio della Concordia, sono testi brevi ben congegnati, relativamente autonomi e compiuti, che mettono a fuoco la nostra società e ne compongono un quadro che, pur rimanendo fedele al dato sociale, si allarga a un orizzonte più vasto. Racconta la crisi antropologica di una cultura, la nostra.
Moltissimi sono i personaggi colti nel punto di inciampo, nell’atto del passo fatale o nel momento del crollo, diverso per ciascuno. Come sei riuscito a muoverti fra tante figure diverse (sensuali suore assassine, appassionati di tirwatching, trafficanti di animali, improbabili ladri di gratta e vinci, eredità inaspettate, gelosia, violenza, amore immortale)? È possibile rintracciare una cifra comune?
I miei sono personaggi assolutamente normali, quanto meno nella mia testa lo sono. Le mie esperienze di vita mi hanno messo a contatto con quelle che comunemente vengono definite situazioni estreme. Ho fatto molto volontariato in ospedali e nelle case di cura, ho visto la malattia vera e che fa paura; ho conosciuto persone massacrate perché non considerate normali soltanto perché – venti anni fa – essere omossessuali era un delitto; mi occupo da anni di crimini, di persone che uccidono, stuprano, ammazzano, sgozzano, accoltellano, rubano, delinquono; ho parlato con le vittime dei crimini, con i genitori di ragazze uccise, ho pianto con loro quando mi raccontavano le loro storie. La cifra comune è che i miei personaggi sono – nella mia testa – personaggi assolutamente comuni. Gente che puoi incontrare ovunque: a Puntazza, che è un giardino di un paese di provincia come pure in un parco giochi a Milano o a Roma. Io mi sono limitato a catturarli mentre li vedevo in azione nella loro normalità. E quindi facendoli inciampare sulla scrittura.
«Inciampando sulla scrittura», in sostanza, tu dipingi un affresco della società contemporanea ma anche un’indagine sul sé, sulla relazione tra l’io e l’altro, da cui emerge una crisi di coscienza e di valori. Mi sono appuntata alcune frasi che hanno la pretesa quasi di essere verità assolute in bocca ad alcuni personaggi: «La vita te la devi inculare perché se aspetti che smetta di incularti non hai capito proprio nulla»; «La loro vita una meta ben precisa non l’ha mai avuta»; «Posso solo arredare il vuoto, adesso. Lo posso arredare col vuoto che io sono». Cosa davvero conta e quale e quanto duraturo è il segno che l’uomo lascia dietro di sé?
Ogni frase pronunciata è assoluta, nel momento in cui una persona la pronuncia. L’altro da sé – per parafrasare Lacan – è un relativismo assoluto ma non quello che l’uomo pensa di sé. Credo ci sia un crinale molto difficile da tracciare, a proposito di segni. Il segno è – se vuoi – un qualcosa che include soltanto chi quel segno è in grado di percepirlo, una specie di gilda autorizzata. Il segno, a ben pensarci, è un qualcosa che ci circonda da sempre: la società contemporanea si basa su segni, che sono emoticon, segnali stradali, frecce, numeri. Quindi l’uomo fruisce di segni che qualcuno ha sdoganato nella quotidianità e che quindi hanno perso il senso più profondo del segno che include solo chi è in grado di essere incluso. Cerca quindi segni che lo contraddistinguono ma in maniera temporalmente definita: la morte incombe a ogni passo. Quello che conta davvero è un segno, un segno nuovo, che qualcuno lascia dietro di sé. Che sia un segno di amicizia o di lungimiranza narrativa non ha poi molta importanza. Gli sbirri la chiamerebbero traccia. Una traccia che non si riproduce, direi io. E in questo senso ognuno lascia una sua personale traccia.
È ormai diventato un luogo comune quello che il genere racconto venga sconsigliato da editori e agenti letterari che tentano di dissuadere gli scrittori dallo scriverne perché «il racconto non vende»…
Esiste una differenza tra lettori di romanzi e di racconti? Possono le parole cambiare in base alla lunghezza di una metrica? Esiste una differenza tra il Wallace dei romanzi e il Wallace dei racconti? O tra lo Svevo dei racconti brevi e quello di La coscienza di Zeno? Prendiamo il campo della musica, e in particolar modo della musica jazz. Prendiamo un mostro sacro come Keith Jarrett: esiste una differenza tra gli standard di 4 minuti e i “solo piano” che durano almeno un’ora e mezzo?
Quali sono le qualità dei tuoi racconti di Puntazza che pensi abbiano o possano catturare i lettori?
I miei racconti sono come gente di paese. Loro se ne battono il cazzo di piacere, se ne stanno al bar e raccontano storie e ti possono piacere o meno ma quelle sono le storie che raccontano. Usano parole forti, usano sguardi divertiti, usano – se vuoi – anche toni cattivi. Poi quando la storia finisce si beve una cosa, si fa amicizia o si fa a botte. I racconti di Puntazza sono genuini, non c’è nulla di artefatto, è presa diretta, è cronaca. Chi ha avuto voglia e tempo da dedicare a Puntazza è diventato a sua volta Puntazza. Ogni lettore è Puntazza. Puntazza è lo sguardo della professoressa di italiano, del maresciallo, dell’industriale, del cameriere. Puntazza è lo sguardo della normalità.
A questo proposito, quali sono, secondo te, gli ingredienti che rendono riuscita una storia di breve respiro?
Non credo ci siano ingredienti. Credo ci siano momenti e momenti in cui una persona scrive o si sente pronto a scrivere. Per esempio: Karl Kraus ha scritto aforismi che sono meglio di un trattato di storia o di sociologia o anche di romanzi, certe battute di Tibor Fischer sono poderose e valgono più di un saggio. Credo che l’unico ingrediente sia la chiarezza: una storia deve essere chiara, anche quando – apparentemente – non lo è.
L’essere passato dalla cronaca nera ti ha aiutato a “visualizzare” le tue storie?
Mi ha aiutato a non debordare ma non a visualizzare le mie storie. Non c’è nulla da visualizzare quando vedi bare bianche o senti il profumo del sangue o vedi un corpo martoriato dalle coltellate. Visualizzare è un verbo sterilizzato rispetto a chi certe scene le ha viste, ascoltate, odorate e vomitate per davvero. La cronaca nera non aiuta a visualizzare, è la molla che porta rabbia alla scrittura.
Mettendo invece da parte il giornalista, attento osservatore dei “fattacci” della nostra società, quali scrittori ami leggere e da quali autori trai ispirazione?
Da dove cominciare? Boris Vian, Chuck Pahalahniuk, Hunter Thompson, Carver, Cortazár, Calvino, Pavese, Pessoa, Yourcenar, Merini, William Lashner, Tibor Fischer, Ennio Flaiano, Giuseppe Genna, Kundera, Dino Campana, Federico Tozzi, Scerbanenco, Arlt, Paolo Sortino, Carlotto. La lista è immensa, comprende autori teatrali e poeti, ma anche pittori che hanno scritto come Lorenzo Viani.