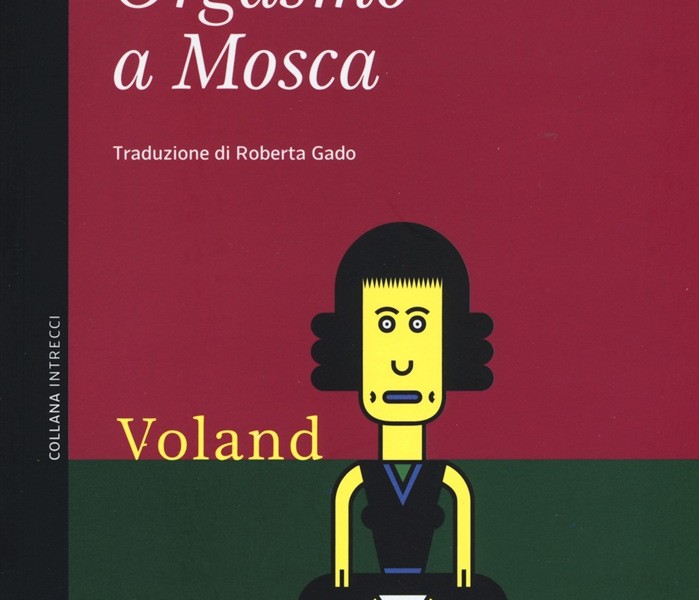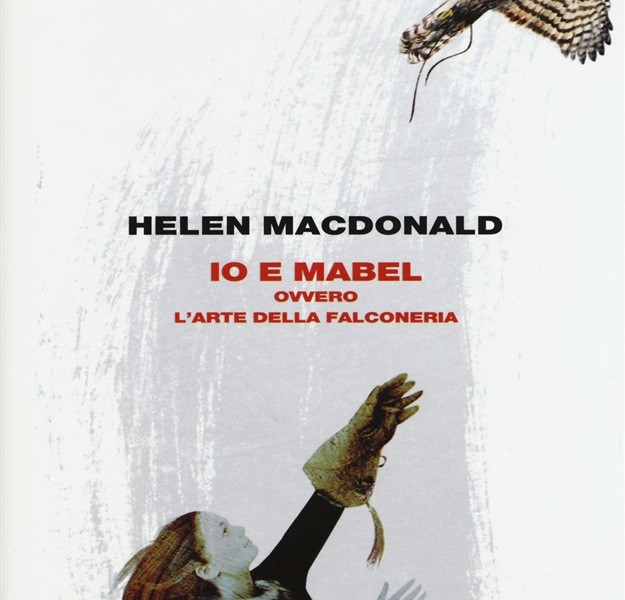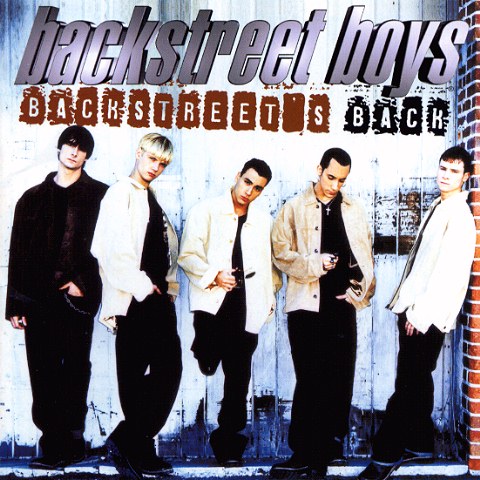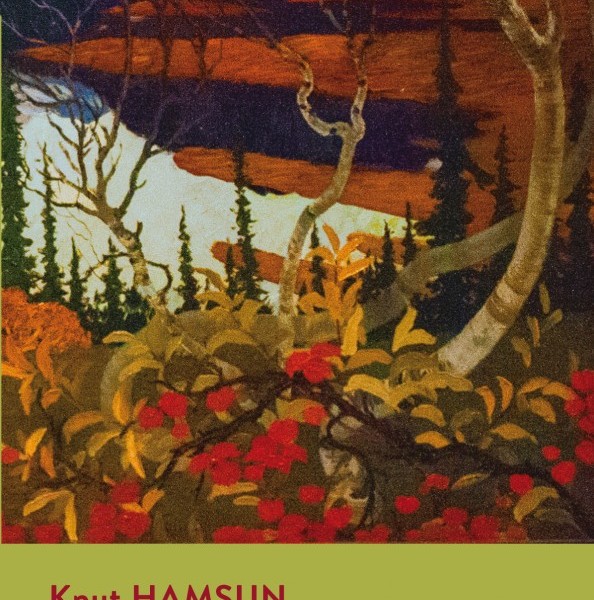Un artista incompiuto che decide di tagliare i ponti con il mondo dell’arte e soprattutto con gli individui che vi orbitano attorno; una ragazza ordinaria, con un lavoro da impiegata nell’hinterland milanese e una vita monocorde, che abbraccia la fede cristiana: sono questi Federico Morpio e Adele Cassetti, protagonisti espliciti di Il brevetto del geco (Einaudi, 2016), ultimo libro di Tiziano Scarpa. L’autore ci accompagna attraverso la delicatissima fase di rinnovamento della vita dei due: entrambi proveranno a imboccare nuove strade, e troveranno il coraggio per farlo grazie all’aiuto del cestello di una lavatrice e delle zampette di un geco…
Ho incontrato Tiziano Scarpa in un caffè nei pressi di via dei Gracchi e, separati da un tavolino di legno, abbiamo chiacchierato per un’intensa ora.
Partiamo dai prossimi lettori, quelli che per il momento hanno solo sfogliato Il brevetto del geco o sono alle primissime battute, ma che si saranno certamente accorti del tuo utilizzo di segni grafici e glifi lungo buona parte del volume, perché li hai utilizzati?
L’uso di simboli grafici – che poi sono quella sezione che ormai fa parte dell’offerta di qualsiasi programma di scrittura – è interessante perché rappresenta una soglia della scrittura: indica un varco per saltare il fosso verso l’immagine. Se pensiamo all’arte, molto spesso le immagini mostrano il nascosto, l’enigmatico, ed è così anche nelle opere di Federico Morpio, dove i volti delle persone sono ingranditi fino al punto di arrivare a vedere gli acari che abitano nei pori. Ma persino personaggi non artisti, i Cristiani Sovversivi, cercano di rendere visibile l’invisibile, ossia la passione di Cristo e soprattutto il vertice dell’invisibilità: la risurrezione, vero e proprio punto cieco e massimo simbolo di fede, in quanto non è stata nemmeno narrata dai vangeli. Cristo, per così dire, risorge fra le righe, ed esiste solo la narrazione di due apostoli che arrivano di corsa in un sepolcro e lo trovano vuoto. In un certo senso, lavorando al libro ho trovato una fortissima parentela con tutta la raffigurazione del vuoto, del minimalismo archetipico di molta arte contemporanea, che si trova in Yves Klein, o in Malevič o Sol Lewitt. Tutto ciò mi sembra in grande consonanza sia con l’arte contemporanea sia con la fede, intesa come punto oscuro del visibile, come il non raffigurabile. E in tal senso, anche i simboli tipografici rappresentano quel momento in cui l’alfabeto sfonda per così dire sé stesso, passando da una funzione di tipo fonetico a una di tipo iconico. C’è una sorta di ambivalenza in questa soglia, e mi piaceva raffigurarla, inchiostrarla.
Uno dei personaggi chiave del libro, l’Interrotto, utilizza le parole per descrivere quel mondo che non ha potuto vedere. Attraverso di esse, questo protagonista di quinta prova a dare significato ad alcune sensazioni che se avesse avuto anche un solo scampolo di vita sarebbe stato magari in grado di provare. Ma l’Interrotto può solo immaginarsele, e verbalizzarle per renderle palpabili.
Si tratta di consegnare l’esperienza dell’esistenza a chi non è nato, e quindi di chiedere alle parole una prestazione al contempo sonora, uditiva ed evocativa. Ho tentato di dire che cosa significa essere al mondo a chi nel mondo non c’è, a chi non è nato. Ciò mi ha aiutato a vivere quell’impossibilità di esplicitare che cos’è il significato delle parole, tema su cui si sono rotti la testa tutti i filosofi del linguaggio. In un certo senso, il significato è qualcosa che vaga dentro le parole, è una sostanza volatile, mentale, ma è anche a volte un desiderio, un’aspettativa, perché spesso le parole ci fregano. Questo l’ho detto in maniera meno lambiccata in Stabat Mater: a un certo punto la protagonista, Cecilia, incontra delle parole, portate all’interno dell’orfanotrofio dalle ragazze aristocratiche che lo frequentano per studiare musica; parole come passione. Fino a quel momento, per Cecilia la passione era esclusivamente quella sacra, ma poi scopre che dentro quella parola c’è un altro significato, un non esperito, che perciò apre delle aspettative in lei. È un problema, perché la passione diventa qualcosa di intensissimo che però non è ancora vissuto. Le parole hanno nei loro significati, spesso, qualcosa di molto illusorio, perché ti fanno delle promesse; ti dicono che esistono cose che non hai ancora vissuto, ti dicono che non sei ancora nato a sufficienza.
Oltre alle parole, un altro elemento sembra una costante di Il brevetto del geco: la ricerca della corporeità. Su minima&moralia è apparsa una considerazione che evidenziava come tra le ossessioni di Scarpa ci siano corpo e parola. Certamente, fra i temi trattati nel libro, questi due elementi emergono con prestanza.
Devo dire la verità, non ho grande simpatia per la parola ossessione applicata alla letteratura o all’arte, perché forse la considero con un’accezione incombente, qualcosa che opprime. Insomma, quasi da patologia del pensiero. Corpo e parola possono essere temi ricorrenti della mia scrittura, sì. Intanto la questione del corpo mi sembra una condizione primaria di ciascuno di noi; inoltre, oggi il tema del vivente è molto politico, non solo perché – come ci hanno insegnato i grandi, da Foucault ad Agamben – la biopolitica è decisiva, ma perché il tema del principio e della fine della vita, quello del concepimento, della gestione della morte, dell’agonia, sono tutti condivisi nel dibattito pubblico. Quindi un po’ mi colpisce anche che si noti questa predilezione per il corpo, che mi sembra debba essere una cosa molto più praticata dagli scrittori e le scrittrici. Dico questo perché c’è una specie di superficialità anagrafica nel trattare i personaggi come puri portatori di identità; ecco, mi sembra che sia troppo poco, come se i personaggi fossero dei nomiferi. Ma i personaggi non sono nomiferi, dei portatori di fatti o storia; i personaggi sono corpi, sgraziati, belli, brutti, decrepiti, prestanti, che hanno una propria consapevolezza anche fisica.
Lo svolgersi della storia corre lungo due binari paralleli, a capitoli alterni. Da una parte Adele, che in un passo molto delicato indichi come una «persona di segno meno» perché tutto quello che le accade è in tono minore, fosse anche un fatto negativo. Morpio, invece, viene dall’ambiente dell’arte. Sembra che la parabola di questo personaggio non si compia, mentre quella di Adele sì, pur approdando dove non avrebbe desiderato, cioè all’organizzazione terroristica dei Cristiani Sovversivi. È su questi ultimi il cuore della mia domanda: i Cristiani Sovversivi compiono atti terroristici perché sentono di aver trovato la vera fede e vogliono costringere la società ad adeguarsi, oppure sono spinti da una necessità di ricerca della fede, che non è ancora conclusa, e che avvertono di dover manifestare in maniera violenta? Perché in realtà la fede che tu narri in Adele è quella di una continua, estenuante e delusa ricerca. Inoltre, a margine, va detto che i Cristiani Sovversivi vengono nominati nella quarta di copertina di Il brevetto del geco, ma poi nel libro occorre attendere a lungo prima di incontrarli.
È vero, quella dei Cristiani Sovversivi è una promessa depistante del risvolto di copertina. È anche vero che essi sono quasi un enzima provocatorio nel senso nobile del termine; la loro attitudine è quella di rendere esplicite certe incoerenze, certe impasse, certe mancanze di attuazione di chi la fede ce l’ha. Distinguerei tra fede e religione. La religione è un vincolo con una dottrina e una trascendenza mistica, che si raggiunge attraverso una liturgia, ossia una procedura rituale che garantisce una comunicazione, una comunione con un’entità sovraindividuale, per chi crede. Questo è tutt’altro dalla fede. Io non volevo, anche per rispetto dei cattolici che credono e vivono la liturgia come canale di comunicazione con il corpo mistico, mescolare le due cose. Per questo anche ho lasciato i Cristiani Sovversivi su una soglia ambivalente, che non fa parte della liturgia; li ho lasciati fuori dalla Chiesa intesa come pratica liturgica dei fedeli. I Cristiani Sovversivi di Il brevetto del geco, hai detto benissimo, sono in un certo senso alla ricerca della loro stessa fede e proprio perché la ricercano la mettono in atto. Esigono coerenza tra ciò che loro credono e ciò che loro vivono. Forse proprio perché non hanno una liturgia che li pacifica. Sai, se credi nel fatto che mangiando una particella di materia sei in comunione con un’entità sovrannaturale… Questo, se non ti pacifica, quantomeno ti allarga degli orizzonti. Quando tu non hai trovato una simile via di ingresso puoi dire: esiste Dio, esiste qualcosa che è più grande di me e questa entità mi dice di essere buono in un certo modo, di difendere la vita in un altro modo, allora metto in atto tutto direttamente. Per i Cristiani Sovversivi è come se l’ultima cena non fosse sufficiente e seguissero una seconda via, cioè incontrarsi nel nome di Cristo e fare delle buone azioni, che però nel loro caso sono spesso prevaricanti e violente.
Tutti i capitoli dedicati a Morpio contengono una critica allo star system dell’arte, ai meccanismi dello scouting, del riconoscimento dei talenti, all’accreditamento di un percorso di artista. Morpio non può essere niente in mezzo, ma può essere due poli: un fallito – uno che non essendo arrivato trova sempre l’occasione buona per dire di aver già visto opere o performance simili a quelle che incontra – oppure uno che, consapevole dell’impossibilità di modificare questo sistema, lo delegittima e se ne va. La sua rappresentazione dell’arte è quella di un mondo senza speranze.
È vero. Io che amo tantissimo, svisceratamente l’arte contemporanea, posso confrontare quel mondo con il mio, che è quello dell’editoria. E, vedi, l’editoria, bene o male, ha un pubblico che – bene o male – ha voce in capitolo, mentre nell’arte contemporanea la voce del pubblico non c’è. Ci sono solo i mediatori. Ed è veramente paradossale che questo accada oggi quando contano i like, i click, l’audience, le copie vendute, gli spettatori. L’arte non ha mai avuto una legittimazione plebiscitaria, chiamiamola così. Mentre, a un certo punto la letteratura sì. Da Dickens in poi, da Balzac in poi, basta leggere Illusioni perdute; nelle pagine che parlano del mercato librario, Balzac mette i brividi. È vero però che alcuni artisti hanno saltato il fosso, nel Novecento. Penso per esempio a Toulouse Lautrec, che realizzava affiche, ma si può pensare a Enzo Mari, che a un certo punto si è chiesto perché dovesse realizzare poche cose per gente ricca, ed è diventato designer, consentendo all’oggetto artistico di venire riprodotto in maniera gutenberghiana.
Tiriamo le somme, in che rapporti sei con Adele e Morpio?
Adele è un po’ un’aliena, che ho cercato di capire più che potessi. Con lei condivido un passato di ricerca della fede, che è più vicina alla mia adolescenza. Ho visto di più e ho vissuto di più Morpio, anche perché io ho le stesse sue insicurezze, invidie, passioni tristissime. E anche condivido di Morpio la medesima incertezza sul valore di ciò che fa, poiché nessuno può garantire che l’attività artistica – nel mio caso di scrittore – abbia una sua validità. E questa incertezza cardinale è secondo me fondante, nel suo essere abissale, perché attraverso di lei sai che non poggi in realtà i piedi da nessuna parte.
Dico a Tiziano Scarpa che su queste parole ho pensato a Venezia. Sorride.
(Tiziano Scarpa, Il brevetto del geco, Einaudi, 2016, pp. 336, euro 20)