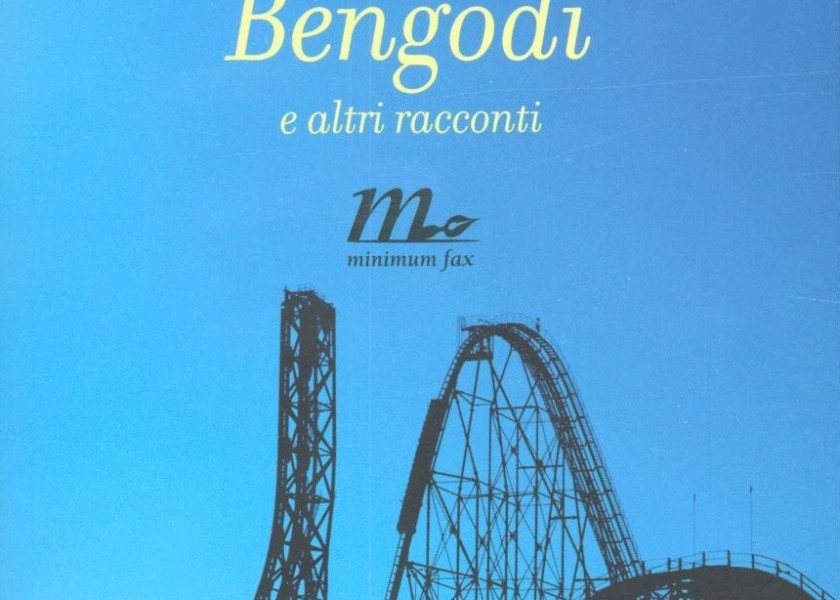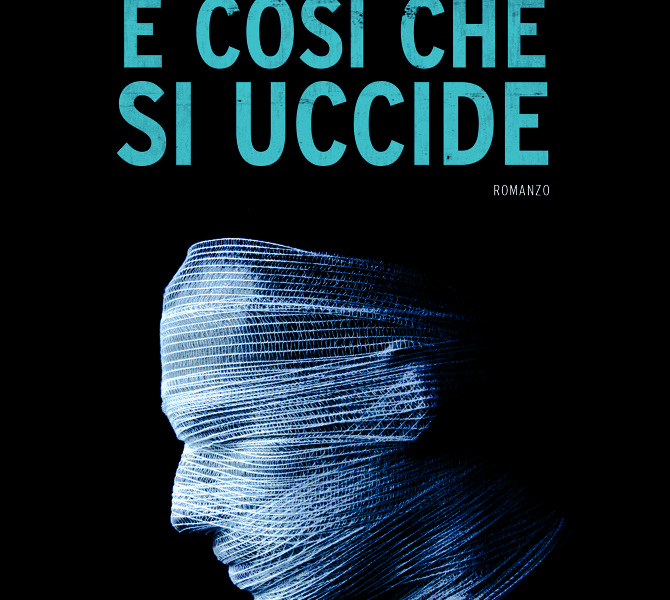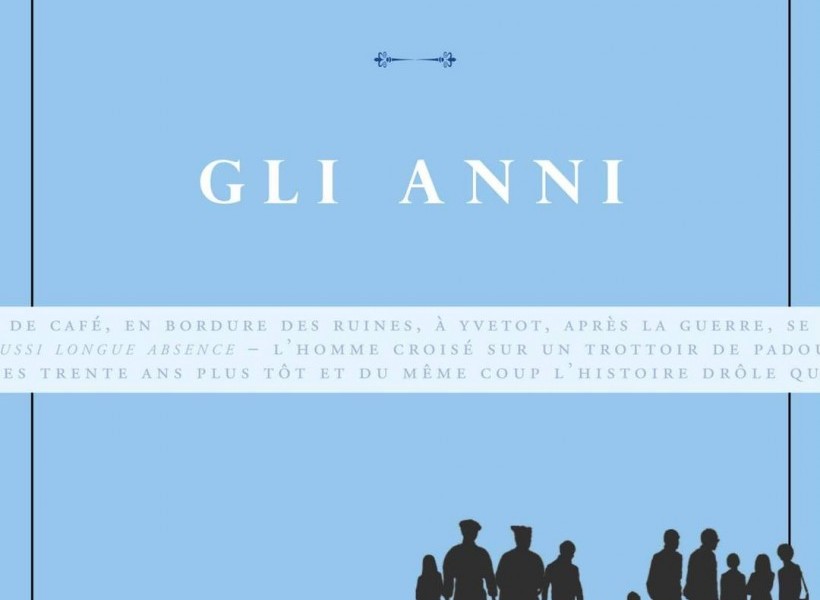Da quando sono arrivata qui mi capita di pregare. Anche adesso che infilo un passo dietro l’altro sulla neve, muovo appena le labbra. Ave regina dei cieli che rechi nel mondo la luce, pronuncio piano. «Come dice?» mi chiede la signora dell’alimentari impegnata a liberare l’ingresso dal ghiaccio. Ha i capelli lunghi, legati in una treccia arrotolata dietro la nuca. Insieme ai fustini di Dash vende pure il pane, sette filoni al giorno, non di più. «Niente», rispondo io schiarendo la gola. Quando prego mi esce fuori un’altra voce. È un fruscìo di parole attaccate, un soffiare che emetto il più delle volte sovrappensiero. «Troppo tempo, passi da sola», si lamenta mia madre a telefono, «troppo» ripete. E io allontano la cornetta dall’orecchio. Perché mia madre urla, soprattutto quando parla con qualcuno che si trova in un altro paese. «E quanti abitanti fa?», mi chiede poi. «Ottocento», rispondo. E mi ricordo di quando sono arrivata, e dentro l’unico bar mi hanno detto «qui non c’è niente».
Godi, vergine gloriosa bella fra tutte le donne, salve o tutta santa, prega per noi. Ecco, tutta santa, lo ripeto anche adesso, davanti alla fontana, godi. E affretto il passo, se non mi sbrigo finisce pure la luce di oggi.
Stanotte ha nevicato ancora. La scuola è rimasta chiusa. Incredibile, per me che sono cresciuta al mare. Il bianco è così largo che il cuore ci si perde. Mi hanno detto che qua intorno è pieno di passeggiate da fare. È che da sola non mi viene voglia. Ma oggi, finito il pranzo, ho sentito quel poco di voglia. E come dice la collega che è rimasta a insegnare al mare, dopo i quarant’anni le voglie vanno assecondate. Per questo ho infilato gli stivali, sono uscita a camminare.
Dopo la rotatoria, già non c’è più nessuno. Alle mie spalle il paese si fa piccolo, poche case di pietra, arroccate sopra la valle. Davanti agli occhi la faggeta spoglia è un ricamo che si avvicina. Santa Maria per cui ogni creatura si rinnova, prega per noi, sfilo via le parole una dietro l’altra. Con le suole sbriciolo il ghiaccio del sentiero. C’è tanto silenzio che riesco a percepire il rumore della borsa di cotone scivolarmi dalla spalla ogni tre passi.
«Ma che ti porti appresso, sempre tutti ’sti fogli!» mi dice ogni volta mia madre. «Sti fogli», così dice. Per me sono i fogli, per mia madre invece sono solo fogli.
Me la ricordo come era iniziata, la storia delle preghiere. Nonn’Assunta me le faceva dire ogni mattina. Mi metteva seduta sulla cassapanca, i piedi che non arrivavano a terra, e cominciava. Ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus, diceva sgranando il rosario, prega per noi. Tutte le sapeva, nonn’Assunta. Pace all’anima sua. Quelle parole me le infilava in testa a forza. E adesso eccole riaffiorarmi tra le labbra – porta del cielo, stella del mattino – tornano a screpolarmi la lingua – regina di tutti i santi, regina della pace – mentre cerco di evitare con gli stivali la neve più morbida. Non sono abituata alla vita di montagna. L’inverno per me è una spiaggia deserta con i legnetti portati a riva dalle mareggiate.
Ora che ci sono arrivata lo bisbiglio. Bosco. Parola dai rami tesi. Rami che reggono il cielo con le punte. Ho fatto bene a venire fin qui, penso, mi sta facendo bene questa cosa di respirare e ingoiare tutta la luce, questa poca luce. Qui è un altro mondo. Le gambe pesano meno, i capelli si fanno morbidi, il fiato lungo. Dev’essere l’aria, l’ossigeno, la distanza dal livello del mare. Non lo so cosa, ma qualcosa dev’essere, penso mentre cammino. E ho l’anima mezza piena.
Poi lo vedo. Un uomo mi viene incontro a passo svelto lungo il percorso ghiacciato. Si tiene a un bastone di legno, sotto il berretto ha i capelli bianchi. Mi saluta come fanno le persone sui sentieri, senza conoscersi. «Buonasera», rispondo io e abbasso lo sguardo alla statura delle carote selvatiche sopravvissute lungo i bordi del tracciato. Faccio un passo piccolo, in avanti, per proseguire. «Il comune non ha fatto niente» dice lui «niente», ripete, e disegna un semicerchio in aria con il naso. «Vede gli aceri, lì, piegati» dice indicando i tronchi, sempre con il naso. «Vede il faggio, laggiù, i rami, tutti spezzati» alza il mento. «E la strada, qui? Come si fa a camminare, qui, se non spalano?» scuote la testa lentamente. «Che quest’anno pure ne ha fatta di neve. Ma domani ci vado, dal sindaco, se non ci viene lui a vedere, ci vado io» promette. E per un attimo resta in silenzio e mi fissa negli occhi, non distoglie lo sguardo. Lo faccio io allora, che non l’avevo previsto, d’essere guardata così. Nelle città di mare le persone si guardano la bocca, o il naso, o le mani. Mai gli occhi. E allora lo scruto tutt’intorno. Mi soffermo sulle piccole rughe adiacenti alle palpebre, sulla pelle imbrunita dal sole, sull’ovale lievemente schiacciato da un sorriso che si allarga fino alle orecchie man mano che i secondi trascorrono.
«Quella, la bambina, ci vuole sempre venire» dice lui. «Ma se resta tutto così, è chiaro che poi i piedi si bagnano. E la madre s’incazza, che sarebbe mia figlia» punta a terra il bastone. «Ma la bambina ci vuole venire, e io ce la porto. Quella, per lei starebbe sempre qua», aggiunge a voce più bassa. «Pure la notte, sempre ci vorrebbe tornare. Mo’ non è ora di bosco, la sgrida la nonna, che sarebbe mia moglie. Ma quella, la bambina, piange, sbatte i piedi ’nterra, che ci vuole venire. E io ce la porto. Sempre, ce la porto. Stiamo tutti i giorni qua. Nonno, dice, mi chiama, facciamo la passeggiata. E facciamo la passeggiata. Quella le piacciono gli alberi, il verde, ’sti fatti. Nonno, dice, mi chiama, facciamo il gioco delle foglie. E facciamo il gioco delle foglie, rispondo io».
Sorrido, non dico niente. «Mi chiamo Gennaro, piacere» fa lui. Si passa il bastone nell’altra mano e allunga la destra. Allora anch’io tiro fuori la mano. «Piacere», rispondo. E quando i palmi si sfiorano me lo concedo appena, di sbirciare dentro agli occhi di Gennaro. E mi sembra di infilare le dita dei piedi in un lago di brina.
Restiamo un po’ fermi così, mano nella mano. Un mondo a parte. Quando faccio per ritirarmi, ché alla fine chi lo conosce, «Gennaro», annuisce lui, «come gennaio, ma con la erre» precisa. E non mi lascia la mano, continua a tenermela stretta, non smette di fissarmi negli occhi mentre ogni cosa tace, e a scandire il tempo resta solo il ticchettare delle gocce dai rami. «Quella, la bambina, ci vuole sempre venire» mi sussurra in un orecchio. Annuisco. Il paese da qui è un disegno dentro una cornice, distante, lontano. Sento un brivido percorrermi le vertebre. E mi cade lo sguardo sul bastone. Ha la cima intagliata, la testa di un animale. Forse un lupo, o una capra, non si capisce, è qualcosa dal muso appuntito. Gennaro continua a parlare, passa la mano intorno al bastone. Lo guardo spostare le dita, ma non lo ascolto più. Santa Maria nostra speranza vera. Il bastone, penso solo.
«Quella, la bambina, starebbe sempre qua» dice Gennaro. «Nonno, mi chiama, facciamo il gioco delle foglie. E facciamo il gioco delle foglie, rispondo io». Gennaro lo ripete uguale a prima. Non ci sta tanto con la testa, penso. E faccio un altro passo, di lato, per congedarmi e proseguire. Ma Gennaro non mi lascia andare, il bastone lo gira nel ghiaccio come si fa per piantare un ombrellone. E senza togliermi gli occhi di dosso mi stringe ancora un poco la mano, mi chiede «come ti chiami?».
Mi guardo intorno. Non c’è nessuno. Sono in trappola, penso. E mi manca l’aria. Questo regno delle cose sottili, delicate, inconsistenti, adesso mi opprime i polmoni. È un bianco senza vie di fuga. Allora mi torna in mente il documentario dove ammazzano le foche. E mi sembra di vedere sulla neve la scia color porpora seguire il corpo del mammifero abbattuto. No, non è possibile, mi ripeto. Gennaro è una brava persona. Si capisce dalle rughe intorno agli occhi. Ha lo sguardo troppo sereno, le iridi troppo limpide. «Che ci è venuto a fare qui oggi?» chiedo per cambiare discorso, e le gambe mi tremano.
È in quel momento che Gennaro solleva il bastone in aria. Lo fa di scatto, all’improvviso. Con la tensione che precede un colpo netto. Zac. E io salto. Sono una molla, un fascio di nervi in preda a un tic involontario. La borsa cade e cade tutto. Ed è così veloce che non sento niente, a parte il sangue. Mi pulsa nel petto e mi punge le dita. Vacillo, e con lo sguardo annebbiato vedo che Gennaro ha solo ruotato il bastone per indicare la montagna grande. «Io abito là», mi spiega indicando il versante. «Ci vuole un’ora per scendere, altre due per salire» continua rivolto all’entità calcarea. «Torno tutti i giorni», aggiunge, e agita in aria il bastone a tracciare un ipotetico percorso con tanto di tornanti. Poi si gira di nuovo verso di me, e per la prima volta s’incupisce.
«Sono venuto a cercare la bambina», dice. «Sono due anni che la vado cercando. Tutti ripetono che non c’è più niente da fare. Ma quelli, che gliene frega a loro. Se non ci vengo io, a cercarla ogni giorno, per loro potrebbe pure morire di freddo. E quest’anno ne ha fatto di freddo». Gennaro guarda dove i tronchi si fanno più fitti, resta in silenzio.
I fogli sono per terra, sparpagliati, trasparenti, si confondono con il bianco del ghiaccio. Gennaro li vede e si china a raccoglierli. Lo fermo prima. «Non importa», dico posandogli la mano sulla spalla. E resto a guardare tutti quei segni frantumati sul sentiero. Teorema, Pi greco, radice, aperta parentesi graffa. Cerco di recuperare qualcosa, ma i fogli sono inzuppati, e a sollevarli si strappano. Allora faccio un mucchio di carta fradicia e mi rialzo. Ho le mani gelate. Ci soffio sopra un po’ di fiato vapore.
«Perché non ci viene a trovare» m’invita Gennaro guardando la montagna. Io sorrido, lo ringrazio, prometto che ci penserò. «Arrivederci», lo saluto indietreggiando sul sentiero. Santa Maria porta serrata e aperta, prega per noi, bisbiglio. Gennaro invece risponde solo «speriamo di vederci sempre». E senza smettere di guardarmi lo ripete. Speriamo, di vederci, sempre.
Claudia Bruno è nata a Foggia nel 1984 e vive a sud di Roma. Suoi racconti sono comparsi su Abbiamo le prove, Colla, Cadillac Magazine, Il Paradiso degli Orchi e altre riviste. Il suo racconto “Anna sottosopra” è stato selezionato finalista per Note al Margine Premio Letterario per le Periferie Romane. Il suo microracconto “41P”, tra i vincitori del concorso Italians del Corriere della Sera, è contenuto nell’omonimo e-book (Rizzoli, 2008). Suoi scritti sono inclusi in raccolte di Iacobelli, Viella, Bloomsbury, Toletta edizioni. Su spremutesenzazucchero.it dispensa favole al limone e altre brevità.