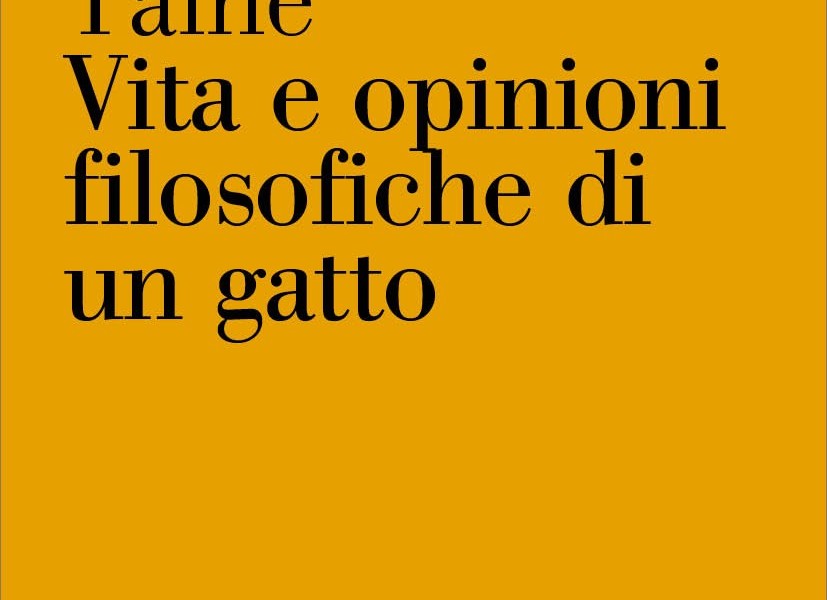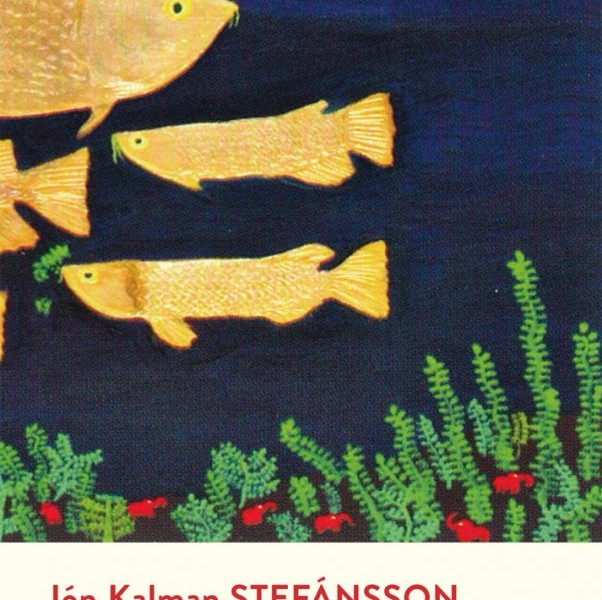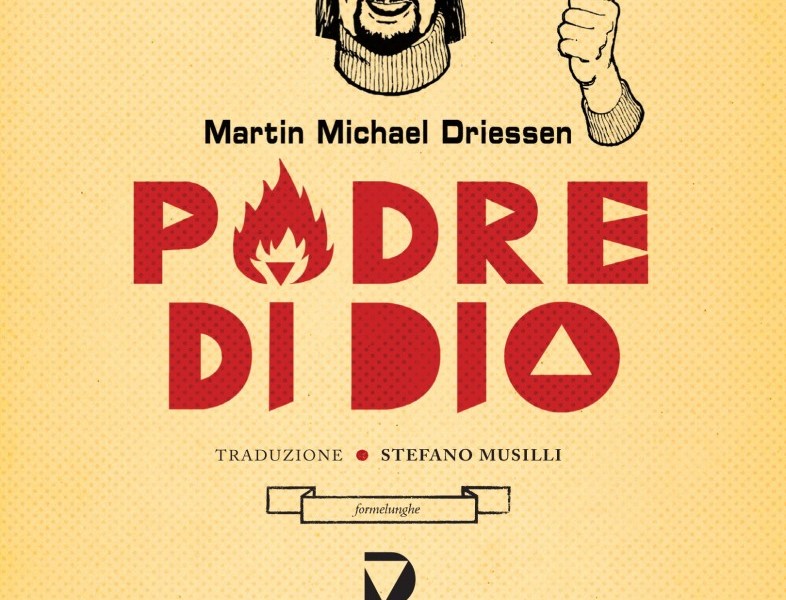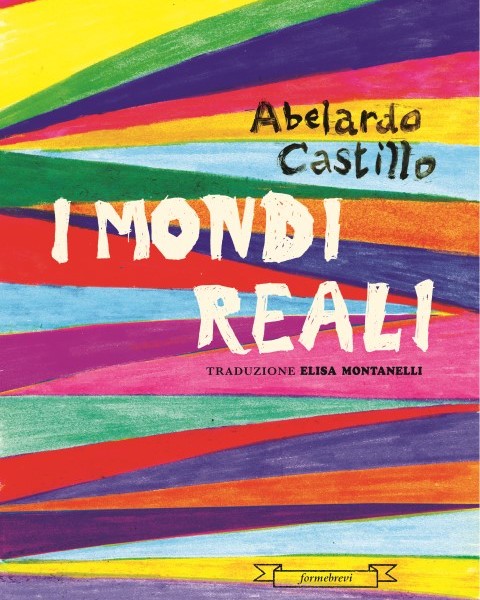A quasi 40 anni dalla morte (1977, era nato a Perugia nel 1906), Sandro Penna ci appare ancora oggi come un poeta profondamente misterioso. Misteriosa è stata la sua semplice vita, naïve maledetta e insieme normale, e misterioso il suo rapporto con la poesia, il rapporto cioè di uno che per sua stessa ammissione «non leggeva niente» e scriveva sui biglietti del tram o sul bordo dei giornali, ma al tempo stesso era oggetto di un vero e proprio culto da parte di letterati e intellettuali come Saba, Montale, Pasolini, Morante, Garboli e tanti altri. Visse la parte più consistente della sua vita a Roma, fece molti mestieri ma negli ultimi anni si sostentò con un piccolo commercio di quadri: «La gente che viene da me non è molto per l’avanguardia – dice in una bella intervista del 1972 girata da Mario Schifano – compra più che altro roba molto figurativa, spesso brutta anche…» e poco dopo aggiunge: «Poesie non ne scrivo più da dieci anni…»
La bellezza, questo, per dirlo in una parola, può essere il senso della vita e della scrittura di Penna, poeta sempre recepito come un a parte nella storia dei vari movimenti a cavallo della seconda guerra mondiale. Sempre nella stessa intervista, introducendo maliziosamente la lettura di un suo componimento, dice così: «Questa è una di quelle di un’ingenuità tale che bisogna volermi bene per credere che è molto bella, però oggi penso che sia bella»:
Eccoli gli operai sul prato verde
a mangiare: non sono forse belli?
Corrono le automobili d’intorno,
passan le genti piene di giornali.
Ma gli operai non sono forse belli?
Garboli ripete in più di un’occasione che Penna considerava le sue poesie come quadri, provava a venderle o a “piazzarle” a piccoli gruppi nascondendo le migliori per un commercio futuro. Rileggendo questi testi con l’occhio scevro da ogni influenza che scaturisce dal mito e dal caso letterario, bisogna notare come uno degli effetti di maggiore riuscita delle sue piccole rappresentazioni stia nell’incisività di un tratto sicuro, nella semplicità e nell’immediatezza della sua espressione. Eccoli, dice il poeta quasi mostrandoci con la mano la scena, sul fondo neutro di un prato genericamente verde la rappresentazione che ci invita ad ammirare è quella di un gruppo di uomini abituati al lavoro fisico presi in un momento di riposo, come un gruppo scultoreo o pittorico di veneri al bagno (gli operai!). Avvicinata al concetto della bellezza è proprio la parola operai a caricarsi di una grazia inaudita nel suo uso assolutamente anti-ideologico. Non sono forse belli? Suggerisce il poeta rivolgendosi con un mezzo sorriso di pudore e imbarazzo al suo invisibile interlocutore. La scena stacca su un altrettanto normale intermezzo cittadino: passano macchine e persone indaffarate, si sente il caos di una grande città in movimento, rumorosa e indifferente. Il poeta, confuso non si sa bene se per l’apparizione dei begli operai o per il traffico che c’è intorno è ancora lì a indugiare, a osservare. Il suggerimento malizioso si è fatto ora un mormorio a fior di labbra, ratificato da quel ma che riprende la domanda opponendo la grazia al caos, Ma gli operai non sono forse belli? Eccola la delicatezza e la plasticità rappresentativa di Penna: con tre tocchi la bellezza morbida degli operai (proprio loro!) è contrapposta a una serie di linee spezzate che stanno intorno: il traffico latamente umano della città.
La magia di uno dei più grandi incantatori in versi del nostro (non solo) secolo XX sembra tutta nel senso dei suoi ritratti, paesaggi, scene d’interno, nature morte.
Non so se sia stato studiato debitamente il rapporto che Penna aveva con i suoi amici pittori. Solo nell’intervista citata (girata da un pittore!) il poeta fa il nome di due o tre artisti (Spazzapan, Tano Festa, Lo Savio, ma anche Guttuso) che da soli basterebbero a evocare e a penetrare tante atmosfere penniane, ma anche a inserire in un movimento più ampio la figura di questo isolato che forse era “in contatto” e più “al centro” di tanti altri.
Interno
Dal portiere non c’era nessuno.
C’era la luce sui poveri letti
disfatti. E sopra un tavolaccio
dormiva un ragazzaccio
bellissimo.
Uscì dalle sue braccia
annuvolate, esitando, un gattino
L’impressione è che Penna fermi l’uso dei valori fonici e retorici della lingua a uno stadio di elementarità momentanea che non risponde ad altro che alla figura; Penna è cioè un poeta veloce che dipinge le sue parole per fermare le immagini che con grande libertà, ma anche precisione, gli si affacciano alla mente; l’immediatezza quasi fulminea del suo tocco è ciò che comunemente è stato scambiato per la sua semplicità e che invece corrisponde a un modo arcaico e arcano di comporre, supportato da un gusto indubitabile (preparazione, esperienza) che da solo basta a reggere il carico del ricordo o dell’ispirazione. Come conferma chi lo ha conosciuto di persona (Giuseppe Leonelli, autore di un Commentario penniano edito da Aragno e fresco di stampa) Penna era anche appassionato di cinema, anzi, pare che nei cinemini di Trastevere fosse una vera e propria leggenda. Ecco, il cinema. Esattamente come Penna non è un autore ingenuo né semplice (del resto nessuno si sognerebbe di definire le forme geometriche di Lo Savio semplici…) le sue rappresentazioni riescono in più di un’occasione a bucare l’immobilità della rappresentazione e a descrivere perfetto un movimento, un gesto, come la caravaggesca fuga del gattino dalle braccia annuvolate del ragazzaccio tolto dell’esempio sopra riportato. In questo caso passiamo dall’assenza all’immobilità di un corpo che dorme tramite un fotogramma di sola luce: dal portiere non c’è nessuno → c’è la luce sui poveri tetti disfatti → sopra un tavolaccio dorme un ragazzaccio. Un dettaglio non da poco: il ragazzaccio è bellissimo, e la sua bellezza, va da sé, è al centro dello stupore del poeta e della composizione, fin qui ferma. Il movimento è introdotto, dopo lo scalino grafico, in due versi (che tra l’altro sono un settenario e un endecasillabo), da un unico verbo, uscì, e dalla presenza angelica, quasi irreale (onirica) di un gattino che esitando si divincola dalle braccia del ragazzo e si dirige verso chi osserva la scena, dunque verso noi. Un ultimo esempio, fra i più famosi:
Città
Livida alba, io sono senza dio.
Visi assonnati vanno per le vie
sepolti sotto fasci d’erbe diacce.
Gridano al freddo vuoto i venditori.
Albe più dense di colori vidi
su mari su campagne inutilmente.
Mi abbandono all’amore di quei visi.
Se è vero, come è certamente vero, che una delle parole tematiche di Penna sia “vita”, è altrettanto vero che “colore” può rivaleggiare con questa per numero di presenze e importanza. L’assenza di colore, la luce livida descritta in apertura con due parole, costituisce, nel caso dell’esempio proposto, la fotografia di questa scena. E l’accostamento del tono generale (della luce) e del sentimento di perdizione e smarrimento provato dal poeta (io sono senza dio) costituisce quasi la didascalia assertiva dello scatto preso nelle strofe successive. Il freddo e il vuoto in cui si muovono gli sparuti personaggi di questo esterno rimandano a una dimensione infernale, dantesca, cocitea, abbastanza evidente. Ma chi scrive è calato in quella realtà senza orrore, tanto da poter provare amore, l’unica parola astratta in quasi-opposizione con la parola “dio” del primo verso, per i visi poveri e scavati dei dannati alla vita.
A distanza di tempo, Sandro Penna è tutto nel suo libro, che tra l’altro sta diventando una piccola rarità (non viene ristampato, si aspetta il Meridiano Mondadori).
Fare un culto di Penna, come Pasolini diceva di aver fatto, è forse, oggi, il modo meno adatto per accostarsi a questa poesia. Del resto il Novecento sembra essersi protetto da Penna almeno quanto Penna si è protetto dalla storia. Ma la bellezza e la rotondità non più raggiunta dei suoi versi sono ancora lì a testimoniare una vita di grazia.