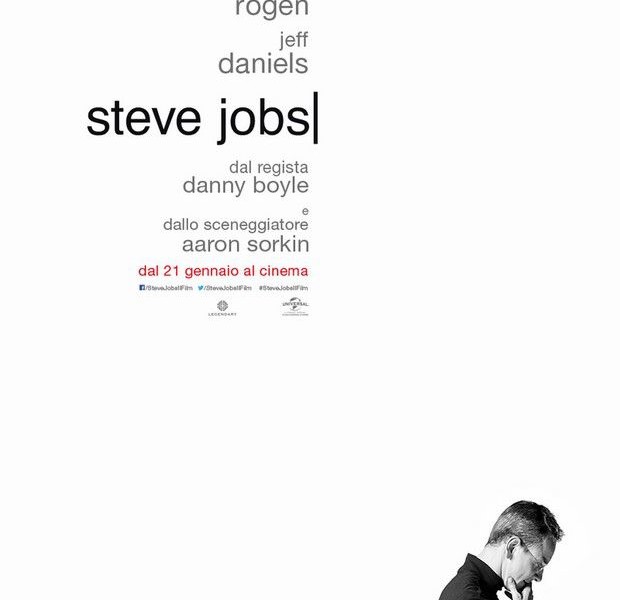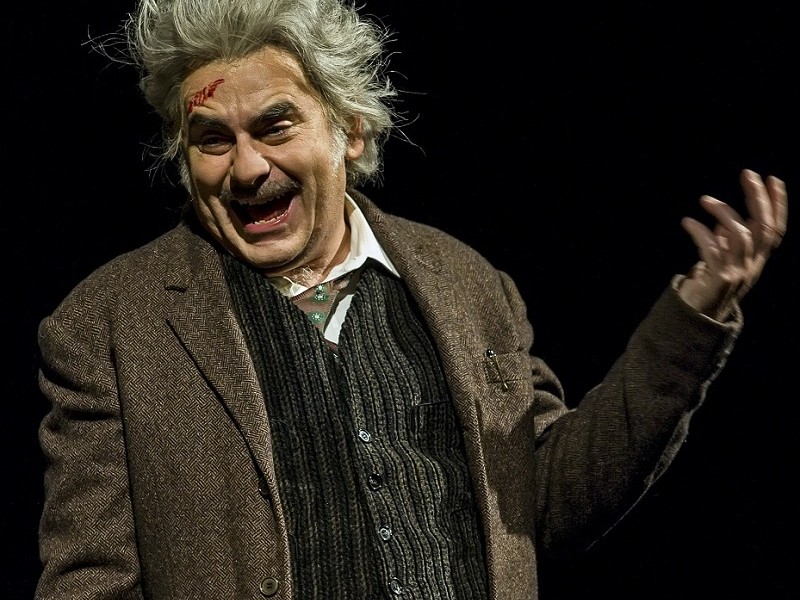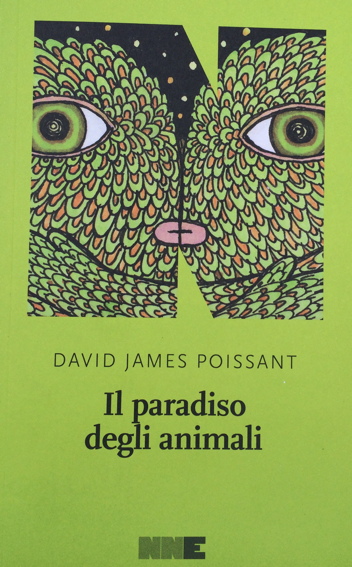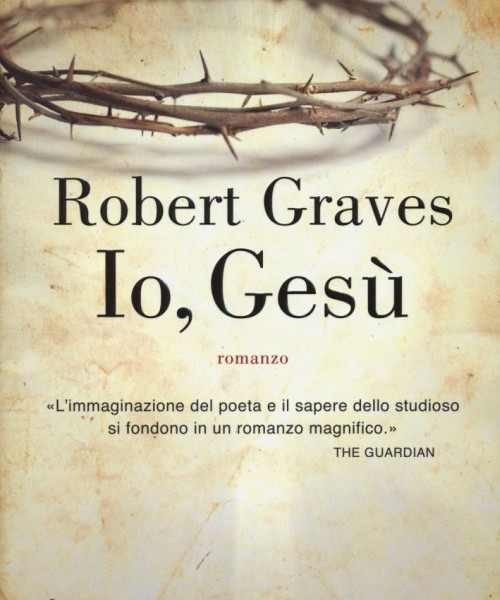Un Naipaul conradiano è stato definito da più parti, quello di Sull’ansa del fiume (Adelphi, 2015), romanzo ora ritradotto da Valeria Gattei e risalente alla fine degli anni ’70. Lo scrittore nato a Trinidad e di lingua inglese è uno dei pochi Nobel non politicamente corretti degli ultimi quindici anni, scrittore di alcuni romanzi notevoli, saggista prolifico e controverso, nonché polemista assai iracondo. Che rifiutava – almeno all’epoca – di accettare una qualche filiazione dall’autore di Cuore di Tenebra.
Di sicuro, siamo nell’Africa centrale. Il protagonista è un indiano di fede musulmana, viene dalla costa orientale, deciso a cambiare vita e a lasciarsi alle spalle un mondo da cui si sente oppresso. Anche perché gli avrebbero apparecchiato pure un matrimonio di cui invece non intende darsi pensiero. Lo stesso suocero mancato gli anticipa cosa troverà nel luogo in cui Salim, questo il suo nome, ha deciso di andare. Preleverà un suo bazar nel centro commerciale di una città che ha conosciuto la colonizzazione europea, la ribellione e la liberazione, il caos inevitabile del dopo. Caos che investe Salim e lo lascia disorientato, assai solo, incerto sulle eventuali e improbabili affinità elettive, scentrato rispetto a qualunque senso identitario, deluso di fronte a un mondo che non avanza nella direzione emancipatrice che aveva immaginato. E continua a immaginare per non abbattersi, salvo constatare che nessun progetto per il futuro muove la popolazione al di qua del bush; che in tanti hanno accumulato troppa rabbia dagli anni del dominio e della schiavitù; e altri ancora si scannano fra loro (al punto che non mancano gli schiavi che preferirebbero restare tali piuttosto che partecipare alla mattanza con «altri africani sconosciuti e ostili»).
Il disorientamento, quando non la paura, il senso di ostilità che lo accerchia, l’inquietudine di un clima in cui nemmeno lo spirito degli antenati sembra rassicurante, la labilità di una fragile memoria storica che i bianchi hanno costruito per gli indigeni falsificandola, trova un primo compimento quando un ragazzo che gli viene mandato per aiutarlo lo denuncia al nuovo dittatore del paese per commercio illegale. Intorno al nuovo potere (vi si adombra senza mani nominarlo ma con profluvio di riferimenti quello di Mobutu) bianchi e neri non si mostrano molto diversi: entrare nella sua orbita, goderne piuttosto che combatterlo è il destino si scelgono e che al disincantato Naipaul non può sfuggire. Se non è quella sull’ansa del fiume la terra promessa, la dipartita per Londra non riserverà a Salim sorprese migliori. Considerando i risultati e cosa egli dice di se stesso («non volevo essere buono, desideravo trovare fortuna»), e nonostante “l’idea romantica” che pure era all’origine del romanzo descritta in una breve prefazione, Naipaul mostra, con una lingua certo più secca di quella conradiana, quanto siano ingannevoli le promesse progressiste.
Molti lo considerano un nichilista, un reazionario – qualcuno addirittura un nemico dell’umanità. Noi agli scrittori che si preoccupano di far fare bella figura agli uomini preferiamo gli scrittori che ne raccontano lucidamente il cuore di tenebra. Uno di questi è Naipaul.
(V.S. Naipaul, Sull’ansa del fiume, trad. di Valeria Gattei, Adelphi, 2015, pp. 327 euro 26)