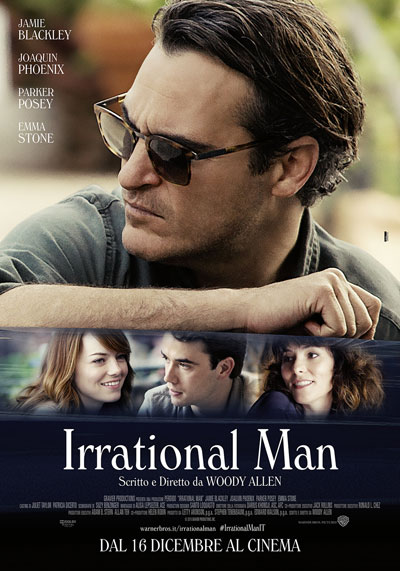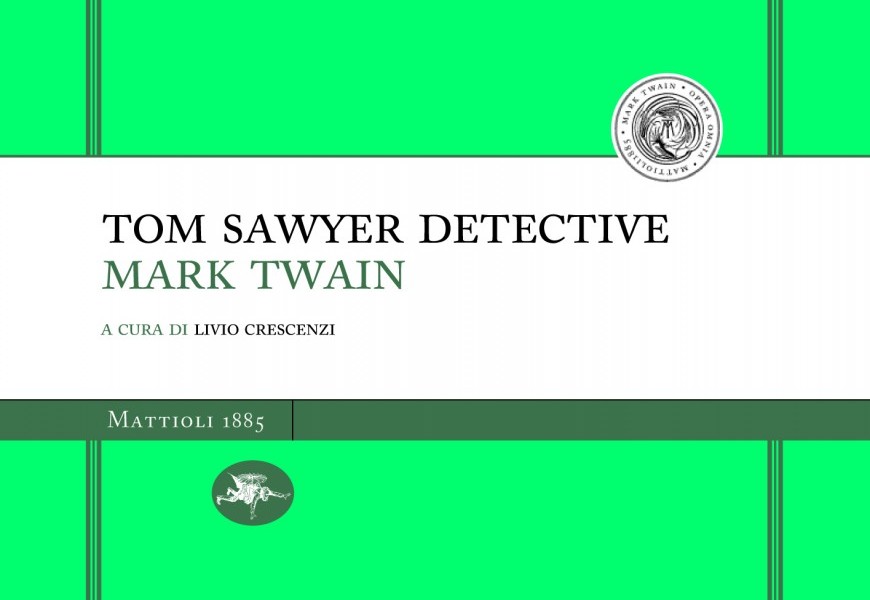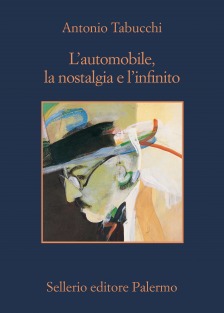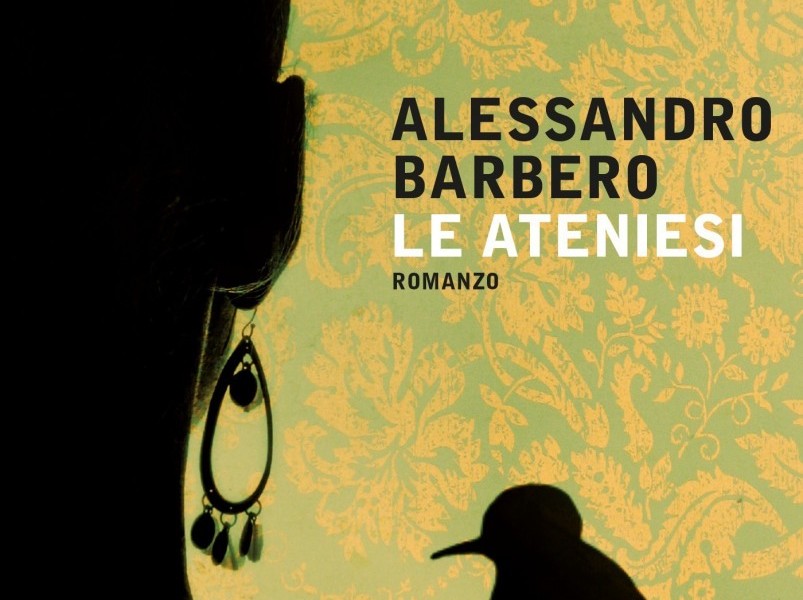È il film più atteso dell’anno, se non di più. Il ritorno della saga cinematografica più amata di tutti i tempi è stato accompagnato da indiscrezioni e mistero, attesa e terrore da parte degli appassionati di tutto il mondo, ansiosi di vedere di nuovo quel mondo cinematografico che più di ogni altro è stato in grado di scolpire l’immaginario collettivo degli ultimi quarant’anni e allo stesso tempo spaventati all’idea di una nuova delusione dopo i prequel usciti a cavallo del cambio di secolo. Ora, il settimo capitolo della saga di Star Wars, Il risveglio della forza, è finalmente arrivato nelle sale.
Siamo circa trent’anni dopo la fine del Ritorno dello Jedi. Dopo la distruzione della seconda Morte Nera, i ribelli hanno istituito una Nuova Repubblica per governare la galassia. Dalle ceneri dell’Impero, però, è sorto il Primo Ordine guidato dal misterioso Leader Supremo Snoke. Per sconfiggere il Primo Ordine, la Repubblica ha bisogno di Luke Skywalker, il cavaliere Jedi che aveva guidato alla vittoria contro l’Impero, ma Skywalker è scomparso da anni. Sulle sue tracce, il Generale Leia Organa invia il miglior pilota della galassia.
Della trama diremo solo questo, che è più o meno quello che compare nei consueti liberatori titoli di testa. Nell’articolo non ci saranno i famigerati spoiler che infestano gli incubi da tastiera di chi ancora non ha visto il film e teme di scoprire troppo e troppo presto. Proveremo a parlare, piuttosto di che cos’è questo Episodio VII.
Tutta la saga di Guerre stellari ha a che fare con il confronto con la figura paterna. Anakin Skywalker è cresciuto senza padre. Quando è stato portato via da Tatooine ha trovato nei Jedi nuove guide con cui si è dovuto confrontare sempre. Prima Obi Wan Kenobi, che lo delude, poi Palpatine, che sfrutta la sua debolezza e il suo bisogno di conferme per farne il suo braccio armato. Dopo di lui, Luke cresce con gli zii sapendo che suo padre è stato ucciso da Vader. Trova una nuova guida in Kenobi, lo vede uccidere davanti ai suoi occhi ancora da Vader, scopre che è in verità suo padre e lo combatte per convincerlo a tornare al lato luminoso della Forza. Entrambi gli Skywalker devono combattere i loro padri (putativi e non) per trovare la loro piena identità nei momenti chiave dei primi sei capitoli. È tutto basato su un’uccisione simbolica del padre come momento di svolta.
Senza dire nulla di quello che succede in Il risveglio della forza, anche questo settimo episodio non è nient’altro che un parricidio. A combattere il padre questa volta, però, sono tutti i fan di Star Wars che si sono ribellati a uno George Lucas che aveva evidentemente perso di vista la direzione esatta quando aveva ripreso in mano il suo giocattolo preferito nel 1999. Si sa, la seconda trilogia non è amata da nessuno, per usare un eufemismo. Troppo lontana dallo spirito iniziale, troppo improntata su una fantascienza irriconoscibile rispetto ai primi tre film, troppo piena di stupide contraddizioni rispetto a quanto detto in precedenza. Sono tre film molto brutti, semplicemente, che hanno avuto comunque una fortuna enorme garantita dal marchio (circa due miliardi e mezzo di dollari incassati in totale dalle sole proiezioni cinematografiche, a cui si devono aggiungere i noleggi e le vendite di VHS e dvd), ma che non hanno appagato nessuno, anzi. Per poter risorgere davvero, la saga di Guerre stellari aveva bisogno di sbarazzarsi del suo creatore.
Lucas negli anni ha sviluppato una visione dell’incredibile universo da lui creato lontana da chiunque lo abbia amato. Sentiva il bisogno di spiegare perché certe cose fossero successe e allo stesso tempo di mostrare a che punto la grandezza tecnologica della sua Industrial Light & Magic fosse arrivata. Il risultato è noto: troppe chiacchiere e un eccesso di computer grafica inutile.
Quando nel 2012 la Disney ha acquistato la Lucasfilm è stato annunciato immediatamente lo sviluppo di una nuova trilogia di Guerre stellari, con una serie di spin-off collegati (sono due, Star Wars Anthology: Rogue One, in uscita a dicembre 2016, e un film ancora senza nome su Han Solo). Il progetto iniziale prevedeva il coinvolgimento di Lucas in fase di scrittura e di sviluppo. In realtà, la sua proposta di sceneggiatura è stata subito bocciata e il controllo è passato completamente nelle mani del regista J.J. Abrams, l’ideatore della serie di culto Lost, già responsabile negli anni passati della rinascita cinematografica del marchio Star Trek.
Abrams è il figlio ideale di una generazione cinematografica che ha in Lucas e Spielberg (e nei film che i due hanno realizzato insieme) i suoi massimi esponenti. È l’erede naturale di un cinema che sa fare grande intrattenimento usando lo spettacolo e le emozioni. Ecco, attraverso Abrams la rimozione del padre Lucas si è completata. Non è la vendita alla Disney che ha fatto perdere a George Lucas il controllo su Star Wars: sono le decisioni di Abrams che hanno restituito la saga al suo pubblico e alla sua vera natura.
Affiancato in sceneggiatura da Lawrence Kasdan, già responsabile dello script di L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, e da Michael Arndt, lo sceneggiatore premio Oscar per Little Miss Sunshine, Abrams ha puntato tutto sulla vera Forza del mondo di Guerre stellari: la nostalgia.
Il risveglio della forza è un omaggio alla grandezza del primo film. Un calco quasi completo, possono dire i più polemici, ai limiti del rifacimento. La verità è che per far ripartire alla grande un universo cinematografico capace di far sognare miliardi di persone negli anni c’era bisogno di un ritorno alle origini, alla semplicità artigianale, all’ironia, alle atmosfere da spaghetti western intergalattico. La trilogia prequel sembra completamente rimossa in questa nuova epoca di Guerre stellari. Insieme al cast originale sembra essere tornato lo stile che aveva reso grande Una nuova speranza e la prima trilogia. Gli appassionati della prima ora troveranno tutto quello che cercano e niente di quello che temono.
È chiaro che dietro all’idea romantica di un ritorno alle origini c’è un preciso calcolo commerciale della Disney, sarebbe da ingenui credere il contrario. La strada della nostalgia che passa per il rinnegamento della trilogia prequel – e quindi per l’uccisione del padre – era quella che garantiva i maggiori e più sicuri ritorni in termini di incassi. Star Wars – Il risveglio della forza è un’operazione commerciale, tra le più grandi mai viste, non solo al cinema. Allo stesso tempo, forse anche per questo, è uno dei film più grandi che si siano mai visti sul grande schermo. Episodio VII è divertimento, emozioni, nostalgia, grandezza, simbolismo semplice, spettacolo. Tutto quello che si chiede al miglior cinema hollywoodiano, in sintesi.
(Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza, di J.J. Abrams, 2015, fantascienza, 138’)