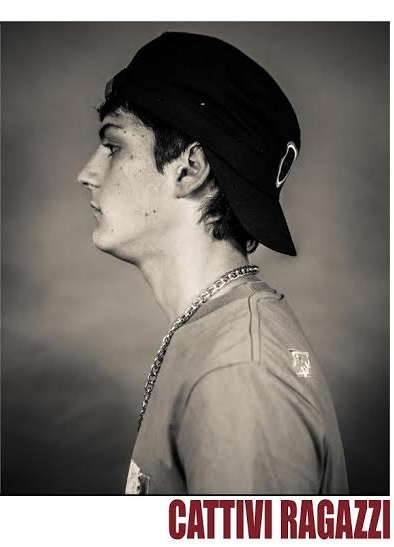Per tutti in città Nebbio era il suonatore, e tutti sapevano che sarebbe bastato un bicchiere di vino per far correre le sue dita sull’organetto.
«Va a prendere lo strumento che stanotte è festa!», gli urlavano al bar Speranza in quelle sere che c’era allegria nell’aria e si capiva che avrebbero fatto nottata.
Nebbio sbuffava e si voltava dall’altra parte. Poi però qualcuno faceva un cenno a Stefania che metteva i bicchieri in lavastoviglie e sbuffava pure lei perché le sarebbe toccata la notte lunga. Di solito era Gaetano a pregarla con il suo sguardo mieloso e le mani giunte: allora lei mollava il canovaccio e si rivolgeva seccata a Nebbio: «Dai ragazzo, non fare il prezioso…»
Quello si girava verso Stefania e spiegava un ampio sorriso da mimo.
«Si può fa… fa… fare!», balbettava soffiando con forza l’ultima sillaba.
Tutti avevano imparato che l’unico modo per fargli fare qualcosa era farglielo chiedere dalla barista. La sera del 27 dicembre Nebbio si alzò e guardò Gaetano con lo sguardo torvo, come se volesse mostrare a Stefania che aveva autorità.
«Beh, forza gio… gio… giovane, mica ci arrivo da solo a casa!»
«Agli ordini, caporale!», disse Gaetano scattando sulla sedia e fingendo un saluto militare.
Vuotò il mezzo boccale di birra e si prese Nebbio sottobraccio dirigendosi verso l’uscita.
Di Nebbio si sapeva poco: che viveva da solo alle case popolari e che suonava l’organetto. Nessuno possedeva altre informazioni sul suo conto: quale fosse il suo cognome e se Nebbio fosse il suo vero nome, nessuno lo sapeva. Riusciva sempre a schivare le domande sulla sua età, che poteva oscillare fra i trent’anni di quando il viso assumeva certe espressioni buffe e i quarantacinque di quando appariva accigliato. Era grassoccio e non molto alto; nel suo vestiario non c’era mai una maglia o un pantalone della taglia giusta, e questo attirava su di lui gli sfottò dei bambini che incrociava per strada.
Quella sera Gaetano, mentre lo accompagnava a casa in macchina, provò a chiedergli qualcosa della sua vita, ma quello taceva o interrompeva a metà la domanda per dare indicazioni sulla strada.
«Lo so, Nebbio, ti ci ho accompagnato cento volte…», era costretto a ribadire.
Fu rapidissimo nel salire in casa e prendere lo strumento. Gaetano, ripartendo, gli domandò a che piano della palazzina abitasse, ma lui fece finta di non sentire ed estrasse l’organetto dalla custodia.
Quella sua riservatezza era spesso argomento di discussione al bar Speranza. Una domenica mattina di poche settimane prima, dopo una nottata trascorsa a bere e cantare, ci si trovò a parlarne all’ora del caffè.
«Con quell’organetto è un maestro», aveva esordito Giovanni riferendosi a Nebbio, mentre con un movimento del dito chiedeva di rinforzare la correzione di Sambuca, «è sprecato!»
Carbellini, il geometra del comune, che ogni volta che apriva bocca sfoderando quel suo vocione pareva che tuonasse all’orizzonte, si chiese cosa facesse per guadagnarsi da vivere.
«So che ha una pensioncina di invalidità», se ne uscì Stefania, che in vent’anni dietro al bancone ne aveva sentite tante.
«Sarà così» aggiunse Giovanni «d’altronde si vede che è un po’…», e picchierellò con un dito sulla testa di Carmine, il figlio della barista, che si divincolò infastidito.
«È possibile che non si sappia nient’altro? Sarà nato da una madre pure lui?», strepitò Carbellini, senza ricevere risposta.
La notte fra il 27 e il 28 dicembre fu una notte di baldoria al bar Speranza. Quando Nebbio e Gaetano tornarono con l’organetto, una dozzina di bottiglie già riempivano di nuovo il tavolo liberato soltanto mezz’ora prima.
«Vi siete dati da fare!», rimarcò Gaetano con un sorriso, e corse ad afferrare il boccale che gli stavano porgendo.
Nebbio scansò con il palmo della mano quello che avevano riempito per lui.
«A Nebbio solo vino, non lo avete imparato!»
Nebbio mandò giù il Lambrusco e attaccò a suonare. Dopo qualche nota, un paio di mani cominciò a battere il tempo e ben presto se ne aggiunsero altre. Giovanni riconobbe la canzone e la cantò fino alla fine, sbagliando miseramente tonalità: «Dammi il tuo bel fazzoletto / In guerra lo voglio portar / che se non muoio sopra al tuo petto / almeno il sangue mi devi asciugar…»
Finito il primo stornello portarono altro vino per Nebbio, e lui lo vuotò tra mani che lo acclamavano. Gaetano fece un cenno a Stefania per fargli intendere che ne preparasse un altro, ma quella lo guardò malissimo e si mise le mani sui fianchi.
«Pago io, lo sai…», la rassicurò Gaetano strizzando l’occhio.
Di solito Nebbio riusciva ad arrivare alla fine di quelle nottate senza che dalle sue tasche uscisse un solo centesimo. Le sue serate al bar Speranza iniziavano con lo stesso copione: girava i tavoli dove si giocava a Scopa, non diceva quasi nulla e osservava i giocatori. Poi qualcuno gli offriva un bicchiere di vino; ma la sua fortuna cominciava per davvero quando gli chiedevano di andare a prendere l’organetto. Per avere il suonatore bisognava pagarlo a suon di bicchierini, questo era chiaro a tutti. Giovanni spesso lo prendeva in giro dicendogli che nelle sue tasche dovesse esserci una vipera o qualche altro animaletto velenoso, visto che aveva paura a metterci le mani dentro. Un giorno, per dimostrare pubblicamente che il suonatore, come diceva lui, fosse un “gran taccagno”, riuscì a convincere Stefania a fargli uno scherzo. La barista disse a Nebbio che nessuno aveva pagato il vino della sera prima e che quindi gli toccava di saldare il conto. Quello si fece rosso come un melograno e in un minuto una grossa chiazza di sudore apparve attorno al colletto della polo striminzita. Se non fosse stata Stefania a parlargli, avrebbe forse capito la burla fin da subito e alzato un braccio per mandare tutti a quel paese. Con lei, però, non voleva fare figuracce: allora col suo balbettare nervoso disse che sarebbe tornato il giorno dopo con i soldi.
«E lo avrebbe fatto di certo, se non gli avessimo detto che giocavamo!», aveva commentato Martelli qualche giorno dopo, quando si raccontava lo scherzo.
«E come?», lo aveva subito incalzato Carbellini «Vendendo l’organetto?»
«Può darsi, per la barista farebbe di tutto».
Erano quasi le due di quella mattina del 28 dicembre e le dita agili di Nebbio riempivano il locale di note allegre mentre altre dita si occupavano di far saltare i tappi delle bottiglie. Qualcuno aveva allineato su un tavolo quelle vuote, che parevano soldati schierati in parata. Solo Nebbio beveva vino, un Lambrusco a buon mercato che Stefania comprava solo per lui, e al quinto bicchiere la mano era diventata più veloce e le gote più rosse. Gaetano aveva chiuso la saracinesca del locale beccandosi il solito sguardo di Stefania, al quale rispose con quel suo sorriso irresistibile da bel ragazzo. Se quella sera l’alcol non avesse indebolito i sensi di gran parte degli avventori, certamente qualcuno avrebbe letto in quel sorriso una complicità non comune. Erano ormai anni che la loro storia andava avanti, e a volte loro stessi si chiedevano come fossero riusciti a nasconderla così a lungo.
«Non m’immagino proprio come reagirebbe mio marito… «aveva detto lei una mattina, dopo che avevano fatto l’amore nel bar chiuso».
«Secondo me sarebbe contento», le aveva risposto serio Gaetano, mentre le accarezzava il viso.
«Ma che dici, cretino!», e gli diede uno schiaffetto sulla testa.
«Dai, parliamoci chiaro, non ti pensa proprio più…»
Il volto di Stefania si fece malinconico.
«Non mi pensa più nessuno, ormai…»
«E io sarei nessuno? E poi hai uno spasimante accanito, Nebbio…», le disse per farla tornare a sorridere.
«Ah, sempre Nebbio, certo che ce lo hai qua!», e gli puntò dolcemente un dito sulla tempia.
La nottata del 28 dicembre filava via trascinata dal ritmo dell’organetto di Nebbio. Verso le tre qualcuno cominciò ad andarsene.
«Bu… bu… buonanotte!», urlava Nebbio euforico a tutti quelli che uscivano.
Col vino e l’allegria era diventato disinvolto e quando non suonava parlava in continuazione. Erano rimasti in pochi nel locale ma ormai cantava solo Giovanni e la sua voce, già poco aggraziata, lo era ancor meno dopo le grosse bevute. Stefania cominciò a mostrarsi seccata per far capire ai rimasti che era ora di andare a letto.
«Io però resto…», le sussurrò Gaetano abbozzando quel sorriso a cui lei non sapeva dire di no.
«Scemo, non se ne parla…», le rispose lei senza crederci.
Cominciava a fare freddo. Stefania aveva spento i riscaldamenti e sperava di mandarli via così, raffreddando il locale, ma quelli si scaldavano bevendo e cantando.
«L’ultima ca…ca… canzone! È festa, è Natale!», gridò Nebbio brioso, sollevando il bicchiere come per prendere la rincorsa e mandarlo giù più in fretta. Poi attaccò con lo stornello più allegro che conosceva: «Per lasciarti solo un fiore / t’ho aspettata quattro ore / per darti un bacio vero / c’è voluto un anno intero…»
All’inizio della seconda strofa il suo bicchiere era di nuovo pieno.
«Benzina al suonatore!», urlò qualcuno.
Soltanto una volta Nebbio aveva bevuto più di quanto fosse in grado di reggere. Una sera d’estate gli avevano fatto trovare una vasca di sangria, e in poche ore non ne era rimasto più nulla. A un certo punto aveva mollato l’organetto e si era incupito guardando Stefania. Lei e Gaetano lo avevano accompagnato sotto casa chiedendogli se dovessero portarlo fin nel letto, ma lui aveva risposto offeso che nessuno lo aveva mai accompagnato dentro casa come un ubriacone.
Ora il freddo lo sentivano anche Nebbio e Giovanni, dopo che Stefania, nel mandare via bruscamente Burani, che da un pezzo dormiva su una sedia, aveva lasciato la porta aperta.
«Forza, il concerto è finito», disse aspramente agli ultimi due rimasti, mentre Gaetano, appoggiato al bancone, guardava divertito la barista strappare l’organetto dalle mani del suonatore.
Davanti alla porta, Giovanni chiese a Nebbio se voleva un passaggio, ma si dimenticò che era uscito a piedi quella sera; Nebbio, che aveva buona memoria e il vino non gliela intaccava affatto, scoppiò a ridergli in faccia.
«Stupido, mi porti in bra… bra… braccio?»
Giovanni si accigliò e lo mandò a quel paese; poi scoppiò a ridere pure lui.
«Ti accompagno io, Nebbio», disse Gaetano sulla porta, mentre si accendeva una sigaretta, «la fisarmonica è pesante».
«Organetto, è un organetto, stupido pure tu!», gridò Nebbio, e di nuovo rise di gusto abbracciando Gaetano.
Stefania, intanto, era uscita sbuffando e disse che con quel baccano la vecchia al primo piano di sicuro avrebbe chiamato i carabinieri. Nebbio si fece serio e disse a Gaetano che non doveva preoccuparsi.
«Va… va… vado a piedi. Fa bene, lo dicono pure i medici».
Fece un pezzo di strada con Giovanni fino ai portici, poi si divisero. Erano le quattro e la notte era fredda e senza luna; nulla si muoveva, e Nebbio mormorò fra i denti che le luci di Natale fanno tristezza quando in strada non c’è nessuno.
Passò sulla piazza e vide che c’era gente. Alcuni ragazzi urlavano appoggiati ai sedili delle loro moto e si passavano una bottiglia. Uno allineò minuziosamente una striscia di polvere bianca sulla sella e, schiacciando deciso una narice col dito, usò l’altra per tirar su la polvere. Accanto a lui una ragazza urlò qualcosa e fece per andarsene, ma quello l’afferrò per un braccio e la sventolò come un palloncino, trascinandola verso di sé. Nebbio passò accanto al gruppetto e fece una smorfia di disgusto quando vide che la bottiglia che si passavano era gin.
Odiava il gin da quel pomeriggio d’estate che al bar Speranza gliel’avevano messo in un bicchiere facendogli credere che fosse acqua: era così assetato che mandò giù senza annusare. Fino a sera fece avanti e indietro in bagno, raccontando che aveva vomitato anche un pezzo di budella.
«L’acqua fa male…», lo canzonarono per giorni.
«Tutti bravi a prendervela con lui, io vi avrei fatto saltare i denti!», lo aveva difeso Gaetano.
Nebbio superò il gruppo e qualcuno prese a urlargli contro, ma lui non si voltò e proseguì dritto per la sua strada. Il ronzio nervoso di una moto rimbombò nella piazza e Nebbio sentì che puntava dritto su di lui. Voltandosi, si trovò davanti un ragazzo che lo superava in altezza di una trentina di centimetri. Era poco più che un bambino, pensò Nebbio, e avrebbe voluto invitarlo a tornarsene all’asilo, ma le pupille dilatate di quello lo stavano fissando in maniera spaventoso, sicché non riuscì a dire nulla.
«Rispondi quando ti chiamano, scemo!», gli urlò il ragazzo, lo stesso che aveva sniffato la polvere bianca sulla sella della moto.
Nebbio lo guardò con la bocca mezza; il ragazzo gridò di nuovo e sembrò che le pupille gli stessero per scoppiare.
«Perché non ti sei girato, eh? Non sei forse lo scemo tu?»
«Ma… vai a dormire!», rispose seccato Nebbio e si voltò per andarsene.
«Scemo, guardavi la mia ragazza! Eh, scemo?»
Qualcuno dal gruppo cominciò a chiamarlo; la ragazza che prima aveva strattonato gli si avvicinò e lo pregò di lasciarlo andare e tornare da loro.
«Fatti i cazzi tuoi! Lo sai chi è questo? Il suonatore, il suonatore scemo!»
«Ma va… va… vaffanculo!», biascicò nervosamente Nebbio.
Quello avvampò e gli si gonfiò una vena sul collo. Diede a Nebbio uno spintone così violento che gli fece perdere l’equilibrio e indietreggiare di una decina di passi prima di franare rovinosamente a terra. Il ragazzo fece in tempo a mollargli un calcio nello stomaco prima che quattro braccia lo trascinassero via urlandogli che non si potevano permettere di farsi beccare dagli sbirri.
Nebbio restò a terra qualche minuto serrando i denti in un ghigno di dolore che sembrava stesse ridendo. Era notte, la gente dormiva, e a lui quasi venne naturale sopprimere le urla che pure gli salivano in gola. Le moto ronzarono all’unisono e Nebbio le sentì allontanarsi verso i portici. Il dolore si attenuò e lentamente si mise in piedi; recuperò l’organetto che, cadendo a terra, aveva perso una dozzina di tasti. Li raccolse a uno a uno e se li ficcò in tasca.
Improvvisamente, scoppiò a piangere. Lacrime grosse come pioggia d’estate gli colavano dagli occhi bagnandogli il collo. Sentì il bisogno di un volto amico e pensò a Gaetano e a Stefania. Si incamminò verso il bar sperando di incontrare Gaetano che faceva la strada a piedi per tornare a casa; oppure di trovare Stefania ancora al bar, che puliva i pavimenti. Sentiva dolore allo stomaco e cercava di spiegarsi il perché di tutta quella crudeltà: stava soltanto tornando a casa, senza dar fastidio a nessuno!
Imboccò un vicolo del corso e appoggiò la mano a un muro per reggersi mentre vomitava. Si riavviò, e anche se si sentiva meglio non riuscì a smettere di tremare. Qualcuno, al sentire quel piagnucolare sommesso, fece capolino da una finestra, ma subito richiuse le imposte farfugliando qualcosa sulle forze dell’ordine che non ci sono mai quando servono.
Da lontano il bar sembrava chiuso, ma avvicinandosi Nebbio vide un filo di luce passare sotto la saracinesca mezza fracassata che Stefania non aveva mai fatto riparare. Picchiettò piano piano e da dentro vennero rumori deboli e nervosi: a Nebbio parve di sentire un grido e pensò dispiaciuto che di sicuro aveva spaventato Stefania.
Soltanto un’altra volta a Nebbio era capitato di tornare al bar chiuso e di picchiare per farsi aprire. Quella notte tutti ballavano come posseduti e qualcuno aveva tirato via Nebbio dalla sedia e lo aveva messo in mezzo. Aveva perso il conto dei Lambrusco e questo lo aiutò a suonare e ballare nello stesso tempo senza difficoltà. Davanti casa, non trovando le chiavi nelle tasche del pantalone, si era convinto di averle perse in quel ballo scemo ed era tornato indietro prima ancora di perquisire il cappotto.
«Quel cretino di Gio… Gio… Giovanni… m’ha tirato a ballare e ho perso le chiavi!», aveva detto quella volta a Stefania, farfugliando mille scuse.
«Sei sicuro? Ho lavato a terra e non ho trovato niente. Hai controllato nelle tasche del giaccone?»
Le chiavi le aveva con sé, e si mortificò per quella figuraccia fatta davanti a Stefania; ma lei lo mandò a dormire sereno dicendogli che non si preoccupasse, che non era successo niente.
Quasi albeggiava il 28 dicembre e Nebbio aspettava invano che Stefania gli aprisse. Dopo un po’ ebbe una crisi e ricominciò a piagnucolare e poi a piangere a dirotto; infine, prese a gridare e a picchiare forte sul metallo freddo della saracinesca.
«Sto male Stefania… per favore! Stefania scusa…»
La donna lanciò in aria la saracinesca e si trovò davanti la faccia sporca e spaventata di Nebbio: si teneva la pancia con tutte e due le mani e un po’ di sangue gli macchiava la fronte.
«Gesù mio, Nebbio, ma che t’è successo?», urlò Stefania.
A quel grido Gaetano, che nel frattempo si era ficcato in bagno, si buttò fuori con la camicia mezza aperta. Quando se lo vide davanti, Nebbio smise improvvisamente di piangere e si staccò da Stefania che intanto lo aveva abbracciato e gli diceva di calmarsi. Gaetano gli sbucò davanti con la faccia di chi ha visto un morto uscire dal loculo e Nebbio replicò con uno sguardo eloquente che esprimeva insieme dolore e delusione. Lui e lei, la saracinesca abbassata, l’esitazione ad aprire: cosa stava succedendo? Il volto di Nebbio si accese di rabbia; nel suo stomaco nacque una nuova amarezza, ben diversa da quella causata dal brutto episodio vissuto.
«Nebbio, che hai fatto?», domandò agitato Gaetano, «Vieni dentro che chiamiamo un medico e parliamo un po’», disse benevolo, perché gli sembrava che Nebbio avesse capito tutto.
Nebbio guardò adirato prima lui e poi Stefania: fece qualche passo indietro continuando a fissarli come si fissa uno scarafaggio sul cuscino. Poi si voltò e cominciò a correre come mai nessuno lo aveva visto fare prima. Gaetano fece per inseguirlo ma Stefania lo fermò sulla porta.
«A che serve? Mica è stupido…»
«Che vuol dire? Non possiamo lasciarlo andare così!», le rispose quasi offeso Gaetano che ora aveva una faccia da cadavere.
«Non dice niente a nessuno, lo so, ma ci sta male lui! Domani ci parliamo… vedi che ora fa giorno…»
La sera dopo Nebbio non si fece vedere al bar, e dopo le otto a Stefania e Gaetano fu chiaro che non sarebbe venuto e si dissero sottovoce che, in fondo, se lo aspettavano. Giovanni e Carbellini si chiesero dove fosse finito il suonatore, ma soltanto quando i bicchieri erano diventati tanti e la voglia di cantare saliva dal fegato alla gola. Gaetano voleva andare alle case popolari a cercarlo, ma Stefania lo sconsigliò perché secondo lei a Nebbio serviva qualche giorno per realizzare ciò che aveva visto; poi, di sicuro, sarebbe tornato. Lui le disse che avrebbe aspettato qualche altro giorno e poi sarebbe andato a cercarlo; per tutta la settimana il suonatore non si fece vedere, e il sabato pomeriggio Gaetano andò a casa sua. Stefania volle seguirlo e lasciò Carmine al bar, dicendogli che non facesse credito a nessuno, specialmente a Giovanni.
Alle case popolari chiesero a un gruppetto di bambini radunati nel cortile dove abitasse Nebbio: quelli prima indicarono l’appartamento, poi aggiunsero che da qualche giorno il suonatore non si vedeva in giro. Gaetano e Stefania passarono mezz’ora davanti alla porta a suonare e bussare e chiamare Nebbio. Gaetano l’ansia non la tratteneva, e allora pensò al peggio perché aveva avuto un amico che si era impiccato a un lampadario dieci anni prima. Gli avevano raccontato di una scena simile a quella stava vivendo: mezz’ora davanti a un portoncino e nessuna risposta dall’interno. Dominato da quel ricordo, cominciò a prendere a spallate la porta mentre Stefania gli urlava di fermarsi, dicendogli che sarebbe stato più ragionevole chiamare i vigili del fuoco. Gaetano non la sentiva e caricava come un montone: il legno mediocre della porta fracassò dopo qualche spinta e per poco non venne giù anche lo stipite. Gaetano corse in tutte le stanze; aprì porte e armadi, si affacciò a tutte le finestre e si chinò a guardare sotto il letto. Stefania, invece, entrando in quella casa buia e silenziosa aveva subito pensato che non ci fosse nessuno.
«Gaetano…», chiamò lei dalla cucina con una strana calma nella voce.
Arrivò col cuore che gli tamburellava follemente in petto e si fermò davanti a Stefania, la quale gli dava le spalle e fissava qualcosa davanti a sé. Gaetano si accostò e guardò pure lui.
Sul tavolo della cucina c’era l’organetto di Nebbio, e accanto una manciata di tasti rotti.
Lorenzo Del Sole (1982) è nato in provincia di Campobasso. È laureato in Lingue e Letterature Straniere e ha conseguito una laurea specialistica in Lingue per la Cooperazione Internazionale e un master in Marketing e Comunicazione. Attualmente vive a Roma dove è impiegato in una società di servizi. Sta lavorando al suo primo romanzo.