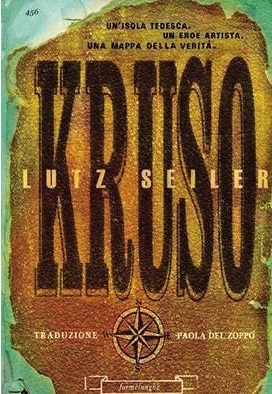Durante le sessioni d’esame universitarie, Lisa andava spesso in biblioteca per consultare vecchi saggi di letteratura che online risultavano fuori commercio. Al bancone dei prestiti leggeva trasversalmente i titoli dei dvd disposti sullo scaffale più vicino. Capitava che allungasse la mano e ne scegliesse un paio;li avrebbe restituiti la settimana seguente.
Un giorno ad attirare la sua attenzione era stato un avviso scritto a penna su un A4. Il foglio era affisso con delle puntine alla bacheca in sughero della sala studio. «Cercasi volontari per letture ad alta voce a pazienti affetti da Alzheimer». Quattro persone interessate avevano aggiunto a penna nome e numero di telefono. Era tornata a immergersi nei suoi studi, ammassando pile di libri sul tavolo. Nel tardo pomeriggio, di ritorno a casa, si era fatta una doccia ed era uscita con Nico. Avevano tirato fino a tardi, in un pub che passava musica rock anni ’80. La notte, poi, aveva faticato a prendere sonno. La mattina dopo la sveglia era puntata presto, la prima lezione cominciava alle 9.
Alle 8.50 era passata in biblioteca soltanto per aggiungere il suo nome alla lista.
«Ci saranno due incontri preparatori, non appena fissiamo le date la chiameremo. Che disponibilità può lasciarci?», aveva domandato Bianca, la bibliotecaria.
«Una volta alla settimana?», aveva domandato lei timidamente.
«Una volta alla settimana andrà più che bene».
I loro incontri avvenivano ormai da sei mesi e mezzo nella sala dedicata alle letture per i più piccoli, ci era voluta qualche settimana perché entrambi mettessero da parte timidezze e premure. Il signor Pascal le sedeva sempre di fronte, al tavolo più lontano della stanza.
«Che storia mi hai portato quest’oggi, Lisa?»
Avevano stabilito di leggere di volta in volta una notizia tratta da un vecchio giornale. Qualche curioso avvenimento che per un motivo o per un altro era passato alla storia. Alla storia con la s maiuscola o a quella spicciola di tutti i giorni.
Il signor Pascal si sarebbe riappropriato di fatti ed eventi che la malattia gli aveva segretamente portato via.
Aveva l’abitudine di ascoltare in silenzio per tutta la durata della lettura, salvo cominciare ad annuire verso la fine del terzo o quarto paragrafo. All’inizio si trattava di cenni incerti, poi, gradualmente, era come se ognuno di quei caratteri riportasse alla sua memoria momenti seminati chissà dove.
«Adesso ricordo…», bisbigliava quando Lisa sollevava gli occhi dalle pagine. «Adesso ricordo tutto».
Allora appoggiava i gomiti sul tavolo e incrociava le mani accavallando una sull’altra le dita spesse e nodose. La notizia gli scavava dentro lentamente, andando a recuperare un nome, un volto, un pomeriggio di settembre di venti o trent’anni prima.
«Sai» cominciava «conoscevo un tale che…»
La biblioteca era un vecchio prefabbricato costruito in riva al Po, a due passi dal centro. Dagli anni ’70 agli anni ’90 aveva svolto la funzione di archivio statale, poi dismesso e trasformato in biblioteca. A Lisa piaceva pedalare lungo il sentiero che costeggiava il fiume, era un percorso che poteva dire di conoscere quasi a memoria, e che apparteneva alla sua infanzia. Da bambina lo attraversava a piedi, stringendo la mano della nonna. A quindici anni, tra le panchine del vecchio parco giochi, si era innamorata di un ragazzo; più tardi, nello stesso parco,aveva passato diversi sabato sera in compagnia dei suoi compagni di liceo, fumando qualche sigaretta e bevendo birra. Ora ci passava per andare all’università, quasi tutte le mattine. Pensava fosse uno di quei luoghi diventati suoi senza far rumore, senza necessità di enfasi.
Il signor Pascal indossava sempre camicie profumate, di colori tenui e Lisa si domandava se avesse una moglie, un figlio, qualcuno che si prendesse cura di lui. Nelle sue condizioni era impossibile immaginare che potesse vivere da solo. Bianca, la bibliotecaria, passava a prenderlo a casa tutti i mercoledì; lui si faceva trovare in strada, di fronte della palazzina signorile in cui abitava, e aveva uno sguardo sempre sperso, come di uomo che porti ai piedi scarpe di una misura eccessivamente grande.
«Da quanto tempo è malato?», aveva domandato Lisa nei giorni precedenti al loro primo incontro.
Bianca non lo sapeva con esattezza. In qualità di bibliotecaria non aveva accesso alle cartelle cliniche degli anziani. Ciò nonostante, una volta, il giovane assistente sociale le aveva descritto i primi sintomi provati dal signor Pascal.
«Chiamò la polizia convinto che ci fossero dei ladri dentro casa. Aveva confuso la propria immagine, riflessa in uno specchio, per qualcun altro. L’hanno trovato mentre vagava inquieto, aprendo e chiudendo le persiane delle finestre».
«Che storia mi leggerai oggi, Lisa?»
«Le ho portato un articolo del ’67».
Quel giorno Lisa lesse la storia del crollo del ponte che collegava Point Pleasant, cittadina del West Virginia, a Kanauga, nell’Ohio. L’incidente causò quarantasei vittime, due delle quali non furono mai trovate. L’articolo era datato qualche settimana dopo la caduta e metteva la storia in relazione a uno strano fenomeno che si era verificato nei mesi precedenti. Nella zona limitrofa al luogo della tragedia, era stata più volte avvistata una figura misteriosa, a metà strada tra un uomo e un uccello. L’uomo-falena, così era stato ribattezzato, era comparso e scomparso in più occasioni, salvo poi andarsene, per sempre, dopo l’incidente.
Quando Lisa terminò la lettura il signor Pascal socchiuse entrambi gli occhi.
«Mi ricordo di quel giorno, sai? Conoscevo un uomo, un tale originario di Napoli. Si era sposato a novembre, mi aveva invitato alla cerimonia. La sposa era così minuta che per cucire il vestito la sarta aveva preso le misure sulla sua figlia più piccola. I due avevano programmato il viaggio di nozze per dicembre, avrebbero percorso gli Stati Uniti da est a ovest. Questo tale diceva di aver attraversato il Silver Bridge appena un paio di minuti prima. Raccontò di aver sentito il boato del crollo spegnersi dietro di lui, a due chilometri di distanza. Disse che nei giorni seguenti, di sera, la gente si sarebbe incantata osservando le acque del fiume tingersi di tratti argentei. Erano i pezzi di metallo e di vetro rimasti incastrati. Ne portarono a casa uno e lo misero sotto teca. Era il loro trofeo. Da quel giorno, ogni mattina, la sposa passava un panno morbido sul vetro affinché la polvere non si depositasse. Chissà» disse il signor Pascal riaprendo gli occhi «chissà cosa resta… E dell’uomo-falena si è più parlato?»
«L’articolo non lo dice, non lo so. Se le interessa nel weekend farò una ricerca su internet».
«Oh no, non ti scomodare. Per come la vedo io, fu soltanto un tentativo di sfuggire al dolore. Il mostro, come tutto il resto, sarà scomparso col tempo, succede sempre così…»
A volte il signor Pascal pronunciava frasi che, estrapolate dal contesto, sembravano caricarsi di un significato lontano.
«E poi così non ti darò da fare, hai già questo buffo impegno settimanale. Leggere a un vecchio notizie senza valore».
Un giorno Lisa si era intrattenuta qualche minuto in più con Bianca, la bibliotecaria.
«Il signor Pascal è in grado di ricordarsi un sacco di cose», le aveva rivelato entusiasta. «Non è vero che non ha memoria. Quando leggo un articolo non passa neanche un minuto e ha già cominciato a raccontare…»
Bianca aveva alzato le mani al cielo. «Vorrà dire che questi incontri stanno fruttando dei buoni effetti…», le aveva risposto sorridente, senza smorzare il suo entusiasmo.
Lisa era iscritta al primo anno di magistrale. Si era laureata qualche mese prima in Lettere moderne, con una tesi su Dino Campana. Il giorno della proclamazione – le ore precedenti alla discussione, ma soprattutto quelle che erano seguite – si erano trascinate in un lungo e faticoso riflettere. Aveva da sempre poca confidenza con i cicli che si chiudevano e in quella situazione avvertiva un peso più forte del solito. La laurea la costringeva a guardare fuori dalla porta la vita che si incanalava davanti ai semafori. A domandarsi cosa sarebbe successo dopo, dopo ventidue anni passati a trascrivere in bella copia istruzioni per l’uso, prima di prendere il volo per davvero. E ripensava a quanto fosse diversa l’immagine che si era fatta di quel momento. Per anni, si era soffermata davanti alla cornice che ritraeva i suoi genitori da giovani, con addosso la toga e il tocco, neolaureati, gli occhi pieni di curiosità. Per anni aveva creduto che la parte più bella della loro vita fosse iniziata quel giorno. Ma in trent’anni le cose erano cambiate e per lei era diverso. Temeva che buttarsi nel mare aperto avrebbe significato lasciarsi alle spalle la sensazione di stringere tra le dita una certezza. Aveva la certezza che le piacesse quello che studiava e aveva la certezza del palazzone fatiscente dell’università che sapeva accoglierla la mattina,con i suoi finestroni squadrati dietro ai quali la città si spezzava in innumerevoli prospettive. Aveva la certezza della vista che si ammirava dalle scale arrugginite del sesto piano. Aveva la certezza del bar che aveva raccolto l’ultimo giro di ripasso prima di ogni esame, e delle macchinette del caffè che, settimanalmente, mostravano la scritta «Fuori servizio», dopo aver ricevuto i suoi cinquanta centesimi. Aveva soprattutto la certezza che fino a quel momento, in un certo qual modo, le tappe fossero state stabilite dall’alto. Così non sarebbe stato più.
Il signor Pascal oscillava tra momenti di estrema lucidità a frequenti prese di distanza dal mondo. Un pomeriggio, alzatosi per andare al bagno, era entrato nella sala di studi storici e si era arrampicato in cima a una delle scale a pioli assestata a un ripiano.
«Presto, nasconditi!», le aveva gridato in un soffio di voce quando lei, non vedendolo tornare, si era messa a perlustrare la biblioteca stanza per stanza, ritrovandoselo a due metri da terra.
Dopo aver ridisceso le scale, affaticato, si era ammutolito come un bambino a cui avessero appena mostrato che le ombre misteriose che vede proiettarsi sulla parete si dissolvono non appena viene accesa la luce.
«Non mi capite», aveva detto il signor Pascal. «Mi preoccupo solo per voi».
Una volta Lisa gli raccontò di un esperimento condotto a Varazze nel 1971, con l’obiettivo di creare luoghi adatti alla proliferazione della fauna marina. L’articolo celebrava la scelta di gettare in mare, una sopra l’altra, carcasse di vecchie automobili, e raccontava nei dettagli il modo in cui i fatti si erano svolti. In tono enfatico, sottolineava i benefici che il gesto avrebbe riscosso sui pesci, quasi un sodalizio uomo-animale di cui chiunque, negli anni a venire, avrebbe potuto far vanto.
Quando terminò la lettura Lisa sorrise. «Stanno ancora ringraziando», disse.
«Chi?»
«I pesci! I pesci di tutto il mondo. Ancora oggi pare che si organizzino in visite guidate subacquee per celebrare il miracolo che è stato compiuto in loro onore».
Il signor Pascal accolse l’ironia. «Erano altri tempi, dopotutto. Ed è bello vederti sorridere per fatti che un tempo abbiamo preso così sul serio».
«Lei dice che un giorno, ripensando a oggi,qualcuno farà altrettanto?»
Il signor Pascal dapprima annuì, poi si fece serio e scosse la testa.
«Non ti sto dietro Lisa, mi confondo…»
C’era questa possibilità, che le cose, a volte, potessero sfuggire di mano. Lisa aveva l’impressione che parlare del passato – immergersi in storie vere o presunte tali – rendesse il signor Pascal improvvisamente lucido, più forte della sua malattia. Bastava poco, poi, un accenno di troppo, un tuffo nel presente, e così spesso i confini della sua percezione tornavano sfumati. Allora, egli si sentiva disorientato, seduto nella grande stanza di un luogo sconosciuto, di fronte a una giovane donna di cui ricordava appena il nome.
Dopo la laurea Lisa aveva fatto domanda in quattro case editrici per l’assegnazione di uno stage. Da tre di queste non aveva ricevuto alcuna risposta ed era probabile che la sua lettera fosse scivolata dalla buca delle lettere al cestino della carta. La quarta casa editrice le aveva fissato un colloquio. Il giorno prestabilito si era presentata puntuale, venendo a conoscenza degli altri tre candidati. Uno per volta erano entrati in una stanza e avevano risposto a una serie di domande riguardo a questa o a quella esperienza. Poi erano stati congedati con una stretta di mano, in attesa degli esiti. Da allora non aveva più avuto notizia, si sforzava di pensare che non le importasse più di tanto.
Al netto dei fatti, poi, c’era il signor Pascal,che riusciva a trasformare ogni notizia in una storia singolare e appassionata – la descrizione di un vecchio amico perduto, di una primavera che non aveva fatto fiori, di un comune nel grossetano che registrava all’anagrafe soltanto figli maschi.
«Ti hanno poi presa per quel posto al bar?», le chiese lui un giorno, prima che lei cominciasse a leggere.
«Intende lo stage? Non mi hanno più detto nulla».
«Pazienza», le disse lui. «Ne troverai uno migliore, sono sicuro… In cosa ci lanciamo oggi?»
Lisa aprì la borsa e la appoggiò sul tavolo «è la storia di una quercia millenaria».
«E parliamo del?»
«2004».
«Dieci anni fa».
«Undici».
«Undici» ripeté lui, annuendo con la testa. «Sono pronto».
«Il titolo è “Salvata la quercia millenaria tanto cara a Ovidio”».
Era accaduto in Abruzzo. Il caso di una quercia di oltre duemila anni salvata all’ultimo minuto dal braccio metallico di una gru. Un centro benessere di grande lusso che per poco non aveva vinto l’eterna lotta contro madre natura. L’albero aveva radici lunghe centinaia di metri e si trovava in un’area apparentemente nascosta, che per secoli l’aveva reso sconosciuto ai più. Era necessario inerpicarsi per un ripido colle, arrivare in cima e poi ridiscendere in direzione del mare. Per questo, per secoli e secoli,raggiungere la quercia aveva significato fede e fatica. La leggenda voleva che ai suoi piedi le persone avessero depositato centinaia di migliaia di racconti. Dai miti antichi del Peloponneso, ai proverbi in latino rustico e consumato. E poi racconti d’amore e racconti di battaglie, ninne nanne e filastrocche. Storie, storie, storie. Nessuno aveva mai smesso di raccontare storie.
«Conoscevo questa leggenda», disse il signor Pascal quando Lisa alzò gli occhi dal foglio «ma per molti anni non ho creduto alla sua esistenza. Nella mia testa si trattava di un mito, di quelli che si tramandano di generazione in generazione. Ma ho amato una donna, tanti anni fa, una donna che era promessa a un altro uomo. L’ho amata con discrezione, facendo attenzione che il nostro legame non inficiasse mai la sua libertà. Abbiamo soggiornato per molti anni nella sua casa estiva. Abitava proprio lì, a Querceto sul mare. Una mattina mi svegliò presto e mi portò ai piedi del colle. Ricordo la fatica di quel cammino, il percorso arso dal sole che sembrava farsi sempre più ripido. Dalla cima, guardando il mare, era possibile scorgere anche la costa iugoslava. E poi la discesa insidiosa, le pietre che si sbriciolavano sotto i nostri piedi. Mi disse che voleva narrare alla quercia la nostra storia, che qualcuno l’avrebbe conservata per sempre: era la sola dignità che potevamo permetterci. Sulla via del ritorno capii che la nostra relazione sarebbe presto terminata. Infatti passò appena un anno e non ci vedemmo più».
Mentre parlava, Lisa provò a immaginare il signor Pascal da giovane, trenta o quaranta anni prima. Pensò a un uomo nel pieno degli anni. Riuscì a vederlo mentre camminava, la pelle arrossata dal sole, una vita – la sua, quella di tutti – passata ad affrontare la salita del momento. Che volto aveva la donna che lo accompagnava? Qual era il colore dei suoi occhi? Lisa questo non poteva saperlo.
Un pomeriggio le arrivò una mail dalla casa editrice: lo stage era stato assegnato a lei. Il messaggio annunciava che il lavoro sarebbe cominciato la settimana seguente, e che l’avrebbe occupata tutti i giorni, per quattro mesi.
Il suo primo pensiero andò al signor Pascal, che inevitabilmente non avrebbe più potuto vedere. Sarebbe restato un solo incontro, poi qualcuno – una giovane donna come lei, un ragazzino o un uomo in pensione – avrebbe preso il suo posto: le cose, che lo si voglia o no, vanno avanti.
Chiamò Bianca per darle la notizia. La donna si congratulò senza cogliere la sua malinconia.
«Oggi non le ho portato niente signor Pascal», disse Lisa sedendosi al tavolo.
«Sono contento che ti abbiano preso al bar. Ero sicuro che prima o poi sarebbe successo. E poi quest’oggi sono io ad averti portato una cosa».
Mentre parlava allungò a Lisa un pacchetto avvolto nella carta di una rivista. Lisa ci trovò dentro un ciondolo in madreperla a forma di stella. Lo prese tra le dita e lo portò al collo.
«Oh la ringrazio davvero», disse sorpresa. «Lo conserverò con cura, sarà il nostro ricordo. Come quel pezzo di metallo e di vetro che i due sposini napoletani tenevano sotto teca…»
Il signor Pascal scosse piano la testa, disorientato.
«Di cosa stai parlando, Lisa? Non conosco nessuno che…»
«Non si preoccupi», disse lei alzandosi in piedi per salutarlo «non ha importanza…»
Sulla via del ritorno, lungo il fiume, Lisa sentì a ogni passo i rintocchi del ciondolo sulla pelle.
Virginia Giustetto (1992), nata e cresciuta a Torino, è laureata in Lettere Moderne e sta terminando la specialistica. Nel 2014 si è diplomata alla Scuola Holden in Storytelling. È attualmente finalista al Premio Chiara Giovani 2015 e sta scrivendo il suo primo romanzo.
Immagine tratta da: www.roberthannaford.com.au