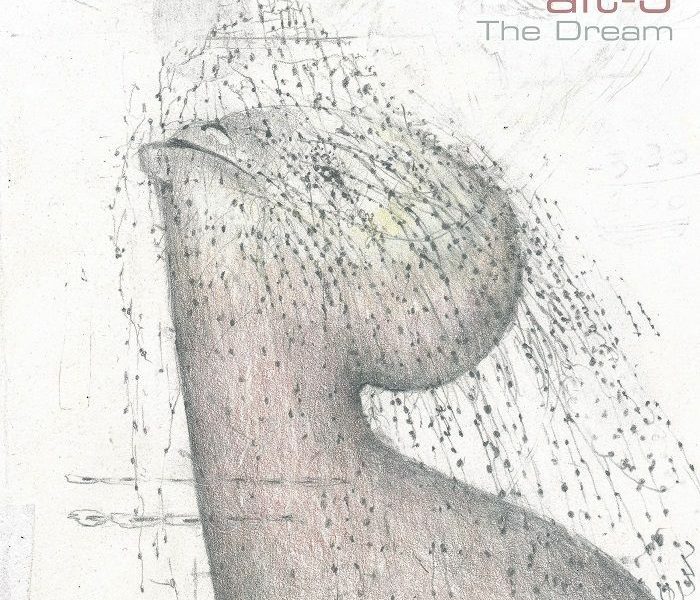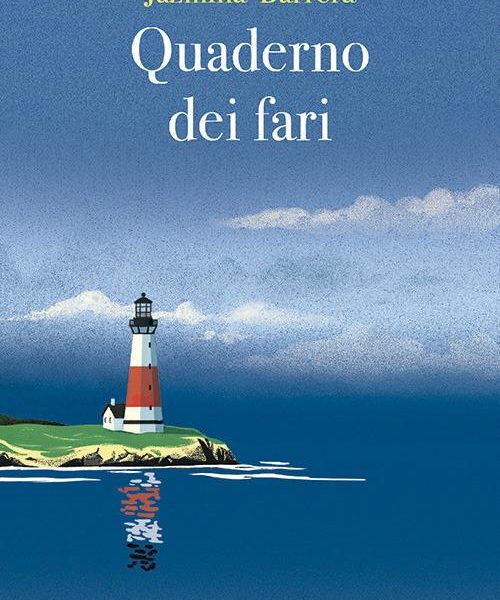Quali libri ci ricorderemo ripensando a questo 2021?
Il secondo anno dall’inizio della pandemia di Covid-19 ha visto l’assegnazione, rigorosamente online, del Premio Nobel per la Letteratura allo scrittore e romanziere tanzaniano Abdulrazak Gurnah, fino al mese scorso pubblicato in Italia da Garzanti (a dicembre è uscito per La nave di Teseo Sulla riva del mare); per quanto riguarda il Premio Pulitzer, la vincitrice è stata la scrittrice e poetessa statunitense Louise Erdrich con il romanzo Il guardiano notturno (titolo originale: The Night Watchman), pubblicato in Italia in autunno da Feltrinelli.
In bilico fino alla fine e con esiti niente affatto scontati sono stati invece i due premi letterari più importanti a livello nazionale: il Premio Strega è stato vinto da Emanuele Trevi per Due vite (Neri Pozza), mentre il Premio Campiello è andato a Giulia Caminito per L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani), affiancata da Daniela Gambaro, vincitrice del Campiello Opera prima con Dieci storie quasi vere (Nutrimenti).
Ancora buone notizie dal fronte degli esordi narrativi, numerosi e di qualità: a cominciare dal pluripremiato Lingua madre di Maddalena Fingerle (Italo Svevo – già Premio Calvino 2020), per continuare con L’arte di legare le persone di Paolo Milone (Einaudi), Sangue di Giuda di Graziano Gala (minimum fax), Isla bonita di Nicola Muscas e Bravissima di Paola Moretti (66thand2nd – entrambi provenienti dalla raccolta di racconti Per rabbia o per amore, curata da effe proprio per 66thand2nd), Tutti gli appuntamenti mancati di Alice Zanotti (Bompiani), Chi se non noi di Germana Urbani (Nottetempo), Splendi come vita di Maria Grazia Calandrone (Ponte alle Grazie), Il primo che passa di Gianluca Nativo (Mondadori), La casa delle madri di Daniele Petruccioli (TerraRossa), Uccidi l’unicorno di Gabriele Sassoni (IlSaggiatore) e la raccolta di racconti di Francesca Mattei Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa (Pidgin), solo per citarne alcuni.
Ma per tonare alla domanda di apertura, vi proponiamo quindici titoli (cinque di narrativa italiana, cinque di narrativa straniera e cinque di saggistica) che pensiamo possano aggiungersi a quelli sopra citati e che rappresentano secondo noi le proposte più interessanti dell’anno.
Le ripetizioni di Giulio Mozzi (Marsilio)
All’inizio della narrazione il protagonista Mario sembra guidato dalla volontà di tracciare una narrazione coerente di sé stesso, di una vita comune e per molti versi non invidiabile, ma basta un profumo incontrato durante una passeggiata a rimettere in moto la sua memoria, dando l’avvio al racconto di fatti realmente accaduti, o rivoluzionati dagli anni e dalla dimenticanza, o persino inventati di sana pianta; persone senza volto, luoghi, cose e sentimenti assopiti tornano come fantasmi nel presente. In questo bestiario umano ciò che emerge è un inossidabile lavorio dell’inconscio, che si affanna, nell’insensatezza dilagante, per fare chiarezza tra doppie o triple vite, e scene di violenza fulminante, stratificando la materia narrativa ed esasperando le derive psicologiche.
Storia aperta di Davide Orecchio (Bompiani)
Ripercorrendo la parabola di Pietro Migliorisi – alter ego del padre dell’autore e di molti uomini di quella generazione –, Davide Orecchio compie un’indagine storica e insieme esistenziale sul Novecento italiano, procedendo dal fascismo alla guerra in Etiopia, dalla Resistenza alla militanza nel Partito comunista. Il metodo narrativo è quello tipico dello scrittore: ibridare in una miscela apocrifa lo scrupoloso studio delle fonti all’invenzione letteraria.
Libro del sangue di Matteo Trevisani (Atlantide Edizioni)
Matteo Trevisani riceve una mail con in allegato un albero genealogico che preannuncia la sua morte imminente. Comincia così un racconto in bilico tra realtà e magia – una sorta di “autofiction fantastica” – che si interroga sul significato del tempo e sui lasciti, e le ferite, della famiglia. Dopo Libro dei fulmini e Libro del Sole, Trevisani continua a esplorare i suoi temi prediletti, le sue ossessioni: la genealogia, la magia, il valore dei simboli e dei riti.
Urla sempre, primavera di Michele Vaccari (NN Editore)
Un futuro cupo, dominato da una dittatura di anziani, e un passato alternativo, in cui risiedono le radici del tracollo. E poi, finalmente, la rivolta: lo spunto di Michele Vaccari è quello di costruire un racconto epico intorno all’idea che le nuove generazioni abbiano diritto a costruirsi il proprio destino. Urla sempre, primavera si muove ai confini tra distopia e ucronia, fantascienza e romanzo storico; è una radiografia dell’Italia di oggi, devastata ma con in grembo il seme del cambiamento.
I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni (Sellerio)
Protagonista del romanzo d’esordio di Bernardo Zannoni è Archy, una faina, che affrontando una serie di tragiche peripezie si confronta con la spietatezza del mondo e l’inevitabilità della morte. L’impianto esopico della “favola di animali” fa così da sfondo a una storia esistenzialista con al centro tre temi: Dio, la crudeltà, il destino.
Piranesi di Susanna Clarke (Fazi Editore)
Un labirinto sterminato di vestiboli, scalinate, stanze piene di statue dall’aspetto indecifrabile: la Casa è l’unico mondo che Piranesi ricordi di aver mai conosciuto, e che condivide con un solo altro, enigmatico, abitante. Eppure nella Casa cominciano a manifestarsi i segni di una presenza terza: una speranza di novità o una minaccia per la loro pace? Il romanzo di Susanna Clarke è una favola borgesiana lucida nella sua visionarietà, che mette in scena meraviglie e pericoli dell’immaginazione umana.
Cronorifugio di Georgi Gospodinov (Voland)
Cosciente che il passato è l’ultimo baluardo di felicità quando la memoria comincia a declinare, Gaustìn, amico al contempo reale e immaginario del protagonista, crea dei cronorifugi, delle cliniche per anziani in cui è possibile tornare a vivere come in epoche passate. Questi luoghi attirano però presto anche persone sane, così che ognuno comincia a scegliere in quale momento vivere per sfuggire alla propria realtà, portando a un collasso della nozione collettiva del presente. L’opera di Gospodinov, vincitore del Premio Strega Europeo 2021, si muove tra il romanzo politico, quello apocrifo-autobiografico e il saggio narrativo, ed è un monito all’Europa delle nostalgie, che cerca una sicurezza impossibile rinchiudendosi in un passato mitizzato quanto irreale.
Quando abbiamo smesso di capire il mondo di Benjamín Labatut (Adelphi)
L’opera di Labatut, ibrida e ambiziosa nel suo tentativo di mescolare saggistica, biografia, fiction e contraffazione storica, pone il lettore davanti ad alcune delle più importanti scoperte scientifiche degli ultimi secoli, mettendo in luce la violenza e l’ossessività che accompagnano il genio e i pericoli, spesso intuibili solo da pochi, che si celano dietro una sempre migliore comprensione, e un maggior controllo, della materia.
Tre anelli di Daniel Mendelsohn (Einaudi)
Il grande critico Erich Auerbach, l’arcivescovo francese François Fénelon e lo scrittore W.G. Sebald: tre uomini in esilio, le cui vite e peregrinazioni si intrecciano a quelle dell’autore, che attraverso di loro racconta anche uno dei topoi più antichi della letteratura occidentale: la maturazione attraverso il viaggio, la narrazione ad anello e la divagazione come tentativi di comprendere e dare senso al mondo.
Mandibula di Mónica Ojeda (Alessandro Polidoro Editore)
Un’adolescente si ritrova legata in una capanna, rapita da Clara, sua insegnante in un liceo privato femminile. È il punto di arrivo del rapporto sempre più stretto e morboso tra un gruppo di ragazze, fatto di storie di terrore, giochi violenti e prove di iniziazione. Mónica Ojeda, con una lingua densa e immaginifica, porta alle estreme conseguenze tutta la noia, l’energia e la brutalità dell’adolescenza.
Killer High di Peter Andreas (Meltemi)
Il 2021, inaugurato dal successo su Netflix di una docu-serie come SanPa, che ha cercato di riportare a galla il rimosso di uno Stato che negli anni Ottanta si è trovato a far fronte a migliaia di giovani devastati dal consumo di eroina, e terminato con la raccolta di oltre 600mila firme per il referendum per la legalizzazione della cannabis, è un altro anno in cui abbiamo sentito parlare moltissimo di droga.
Purtroppo le occasioni di dibattito – pur con meritevoli eccezioni – si riducono spesso al siparietto fra Stanis e René nella serie Boris («Ma quando mai uno nella vita usa la parola “droga”, scusa? Tu usi la parola “droga”? “Dammi la droga”, “Sono fatto di droga…” Dai René!»). Eppure sapere di più sulle droghe, sulle dinamiche storiche che stanno dietro a diffusione, consumi e mercati, può aiutare a comprendere meglio questioni fondamentali per l’economia e la politica internazionale.
In questo senso è utile e prezioso Killer High, da poco uscito per Meltemi, in cui il politologo Peter Andreas ripercorre il ruolo delle sostanze psicoattive – pesanti o leggere, lecite o illecite, naturali o sintetiche – nei conflitti armati. Da vino e guerra nell’antichità a cocaina e controinsurrezione negli anni più recenti, passando per caffeina, tabacco, oppio e amfetamine.
Un testo ricchissimo e a tratti sorprendente, per esempio quando spiega che la droga di guerra più diffusa storicamente è l’alcol, a lungo usato sia «come integratore liquido di coraggio sia per aumentare le entrate destinate alla guerra attraverso la tassazione», o che le metamfetamine hanno avuto un ruolo determinante nei blitz nazisti della Seconda guerra mondiale. O ancora quando racconta le guerre commerciali che la Gran Bretagna combatté nell’Ottocento per imporre alla Cina l’importazione di oppio indiano, oppure i disastri – soprattutto in Messico – della guerra alla cocaina scatenata dagli Stati Uniti a partire dall’amministrazione Reagan.
Un libro di storia stupefacente, è proprio il caso di dire.
L’altro mondo di Fabio Deotto (Bompiani)
Il fenomeno Greta Thunberg e il rinnovato attivismo green – vero o, più spesso, presunto – di governi e imprese ha imposto finalmente all’attenzione generale il tema inesorabile della crisi climatica. Non è facile orientarsi nella discussione, fra transizioni ecologiche complicate, conferenze internazionali strombazzate, paradigmi di sostenibilità d’impresa e millenarismi da catastrofe inevitabile. Alla base c’è soprattutto la difficoltà culturale di concepire in concreto quali conseguenze il cambiamento climatico avrà o sta già avendo sulle nostre vite. Perché ci siamo svegliati così tardi? E perché anche oggi, di fronte a una minaccia ormai riconosciuta, ci rifiutiamo di mettere in discussione stili di vita e sistemi economici palesemente insostenibili?
L’altro mondo di Fabio Deotto è un tentativo, brillantemente riuscito, di rispondere a queste e altre domande, in un pianeta che cambia mettendo a rischio la civiltà umana per come la conosciamo. Un viaggio-reportage nei luoghi in cui il riscaldamento delle temperature sta già dispiegando i suoi effetti: dalle Maldive, «paese con la data di scadenza», a Miami Beach, dove le case costiere sono state rialzate di un metro, con conseguenze a catena sul tessuto socioeconomico della città; dalla Louisiana in cui interi paesi finiscono sommersi ma non tutti gli abitanti accettano di trasferirsi altrove, a Venezia, con le sue incerte strategie di adattamento all’acqua alta; dai luoghi delle sempre più frequenti “migrazioni climatiche” al villaggio di Babbo Natale in Lapponia, in cui ogni anno la neve si fa attendere qualche giorno in più.
Il grande pregio dell’inchiesta narrativa di Deotto è la capacità di raccontare come le persone affrontano la crisi climatica quando le loro vite ne sono travolte, e così di riflettere sui limiti cognitivi, culturali e biologici che impediscono a chi invece non ne è ancora stato investito di agire contro il riscaldamento globale.
L’acquario di quello che manca di Enrico Ghezzi (La nave di Teseo)
«Blob non è mai stato una trasmissione elegante. Forse è stata scambiata per eleganza quella specie di freddezza chirurgica […] del puro montaggio, che rende più selvaggio il nichilismo, più astratta la comicità, meno corporeo il tutto, perché più ancora che sui corpi degli attori televisivi ci illudiamo di lavorare sulla tv come corpo e sul corpo della tv», scrive Enrico Ghezzi in uno dei testi raccolti nel bellissimo L’acquario di quello che manca, curato da Aura Ghezzi e Alberto Pezzotta e appena uscito per La nave di Teseo. «Comunque noi siamo con i bambini, ringraziamo per l’eleganza, ci scusiamo per vomiti e puzze, ma con loro diciamo “Dammene troppa”».
E “dammene troppa” (sottinteso la marmellata: è la parafrasi di un aneddoto di Chamfort in cui un bambino chiede così alla mamma) è espressione ricorrente nel libro, tanto che avrebbe potuto essere un titolo alternativo – come ricorda anche l’editore Elisabetta Sgarbi che per prima, venticinque anni fa, iniziò a mettere insieme il florilegio degli scritti del padre di Blob e Fuori orario.
Restiamo nella metafora per dire che siamo davanti a un irresistibile barattolo di marmellata per cinefili: Zibaldone stracult di 700 pagine, che raccoglie interviste, rubriche, poesie, appunti sparsi e persino riproduzione di fax di una delle menti più geniali della nostra epoca italica.
Il potere segreto di Stefania Maurizi (Chiarelettere)
Il potere è «tanto più efficace quanto meno è visibile alle parti in causa e agli osservatori», scriveva il sociologo politico Steven Lukes, e sulla tensione implacabile tra democrazia e segreto Norberto Bobbio ha lasciato pagine memorabili. La vicenda di Julian Assange, troppo a lungo dimenticata (almeno in Italia) e riemersa nelle ultime settimane dopo una sentenza dell’Alta corte britannica che apre alla sua estradizione negli Stati Uniti, è emblematica di questa tensione. La colpa del fondatore di WikiLeaks, che negli USA rischia una condanna all’ergastolo? Avere inventato un nuovo modo di fare informazione, diffondendo grazie alla Rete migliaia di documenti coperti dal segreto di stato, nei casi in cui quest’ultimo non era usato per proteggere la sicurezza dei cittadini ma per occultare crimini.
Da undici anni Assange, a cui si devono alcune delle più terribili rivelazioni sulle guerre americane in Iraq e Afghanistan (massacri di civili, torture, scandali…), vive da prigioniero per aver squarciato il velo del potere segreto su cui si fonda l’impero americano. E Il Potere segreto è proprio il titolo di un libro recente, e davvero illuminante, dedicato al caso Assange: un libro che «fa arrabbiare», come scrive Ken Loach nella prefazione.
L’autrice è Stefania Maurizi, giornalista che ha pubblicato in Italia i principali documenti segreti di WikiLeaks, da anni impegnata con le sue inchieste nella battaglia per salvare Assange e i suoi giornalisti. Come dimostra in ogni sua pagina, il caso WikiLeaks trascende la libertà di un uomo, per quanto geniale, coraggioso e ingiustamente vessato: è in gioco il futuro del giornalismo e del suo ruolo fondamentale per la democrazia. Perché la verità e la possibilità di raccontarla sono l’unico strumento con cui contrastare il dominio di chi decide guerre, colpi di stato, assassinii, e influenza elezioni e governi (in particolare i nostri), al riparo da qualunque responsabilità pubblica.
Milano sotto Milano di Antonio Talia (minimum fax)
Da sempre Milano è città di paradossi. Capitale morale o «città degli untori», come la definì il grande Corrado Stajano? Motore economico del paese o specchio delle disuguaglianze che lo attanagliano? Global city vivibile e culturalmente vivace o riserva dell’ipocrisia borghese imbruttita e inaccessibile ai non ricchi? Avamposto di una rivoluzione verde, come pretende il sindaco Sala, o piuttosto del greenwashing politico, come accusano i suoi detrattori?
Comunque la si pensi, Milano è il principale centro economico d’Italia. Prima del Coronavirus il Pil viaggiava al doppio della velocità e gli investimenti diretti esteri affluivano copiosi; oggi il capoluogo lombardo resta ben integrato nei mercati finanziari internazionali e nelle catene globali del lavoro, ma dalle macerie della pandemia comincia a emergere qualche lato oscuro. Per chi preferisce scavare anziché far finta di non vedere, l’inchiesta di Antonio Talia Milano sotto Milano è una lettura imperdibile, capace di aprire le porte – come mai era stato fatto prima – di un mondo sommerso nel quale vecchie bande locali e ’ndrine protagoniste della globalizzazione criminale si incrociano con nuove organizzazioni di tutti i continenti, professionisti del riciclaggio, spietati affaristi immobiliari e un sottobosco di avvocati, amministratori e politici.
Mentre l’economia si riprende dopo la pandemia e i tassi di omicidi e altri reati continuano a calare, a Milano il culto del denaro (e dell’immagine pubblica) spinge molti insospettabili a condurre doppie e triple vite. Dopo aver letto questo libro, sembrerà ancor di più città dei paradossi.