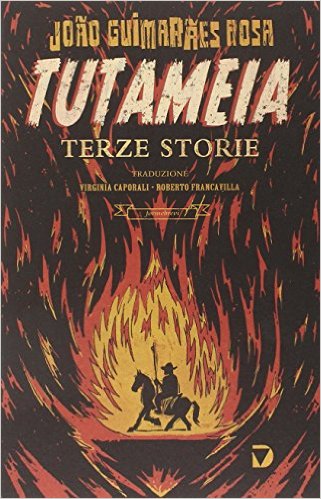Già dopo poche pagine, attraversate le prime sezioni di I costruttori di vulcani (Luca Sossella editore, 2014), tutte le poesie (1975-2010) di Carlo Bordini, nonostante la sua opera si immagina in costante elaborazione, emerge l’immagine di un poeta diviso, capace della più profonda depressione e subito dopo di una gaiezza quasi adolescenziale, nell’assorto specchiarsi di una presenza sconosciuta a se stessa.
Per ritrovarsi, il poeta fa affidamento sulla somatizzazione più che sull’autobiografia, descrivendo le varie fasi di una malattia che impersona come un ruolo o una ragione personale, e che estende anche al mondo circostante; la morte e l’idea vagante del suicidio stanno sulla faglia di contatto e giustificano la contraddizione di un io sospeso: «una persona amo sopra tutte le / altre / amo sconfinatamente me stesso […]» (p. 32); «io mi odio al punto, / che odio chi mi ama» (Odio, p. 44). Questi due frammenti in rapida sequenza sarebbero in contraddizione se la prima delle poesie citate non si sciogliesse continuando in questo modo: «non sono chi credete / questo è un nome che / mi hanno appioppato / non so chi sono / comunque mi amo», con quel lungo ed eloquente spazio grafico fra il conclusivo «comunque» e il «mi amo», meno reciso, evidentemente, di quanto deve apparire.
Il fatto di non poter credere del tutto alla propria esistenza né tanto meno alla propria identità e alla propria discendenza, al punto da voler chiamare il vecchio numero di casa per parlare con il se stesso di vent’anni prima e fare due chiacchiere di circostanza (Poesia scritta di notte, p. 31), ha però la capacità di rompere una impasse apparentemente fatale nella sua radicalità: nella latenza dell’uno e dell’altro polo il poeta costruisce la sua casa.
Inchiodato alla sua indefettibile debolezza interiore Bordini finisce per farne l’apologia, declinandola sul piano continuo della spiritualità e della materia, dall’infanzia all’identità sessuale, tutte cose colpevolmente create all’ultimo momento (insieme alla morte) da Dio e dalla cricca dei suoi aiutanti/disturbatori ingegneri del cosmo (Poesia demente, p. 120).
Dall’altra parte della fame, il poeta ha orrore della distruzione che comporta il vile atto della nutrizione, e per esprimere il profondo schifo e il profondo terrore di un esercito di stomaci che digeriscono il mondo, la sua poesia retrocede alla parodia di una petulante voce materna che ingiunge al figlio di Mangiare (questo il titolo della sezione che comincia a p. 71). La sostanza, anche quella economica («mangia mangia / Lo stipendio», p. 98), si pone dunque al centro di un horror pleni che può essere riscattato solo dalla pre-vita, dalla debolezza dei secoli, dalla mollezza del sedimento:
Se non fosse stato debole non sarebbe potuto nascere,
né farsi penetrare dal sole. Se la tempesta
non l’avesse sbattuto non si sarebbe frantumato e non avrebbe
raggiunto piano piano la palude, coi suoi simili frantumati,
per farsi penetrare dal sole.
Così nacque la vita. Dalla polvere, dalla
catastrofe. Dal frantumarsi e dai detriti
frantumati. Così nacque la forza. Dalla
debolezza, dall’argomentare della
debolezza. Dal suo accettare di farsi
penetrare dal sole.
(da Polvere, p. 134)
La maturità di Bordini si gioca sul prodigio di un tono familiare e di uno stile discorsivo e narrativo orchestrati in scene in cui si conducono i momenti dell’orrore e del terrore esistenziale come se fossero piccole feste, riunioni collettive in cui amici e parenti si stringono intorno al suicida fallito che spiega placidamente i motivi del suo gesto, mentre sembra spirare un paradossale vento di fiducia e di rigenerazione sociale e personale (Fine della tragedia, p. 146-7); è sullo scampato pericolo, sul dopo la catastrofe che Bordini ragiona con pazienti elenchi di cose e di motivi, con pensieri semplici e affilati, menando una lirica che non può non essere del quotidiano, dell’effimero, della dolcezza fredda e diffidente, se davvero può essere ancora. Bordini guarda il mondo come un bambino, intellettuale e incasinato, si rivolge all’albero che ha ucciso per stampare l’ultima variante del suo lavoro «inutile, o, comunque, evitabile», (p. 158) si siede insieme al suo lettore davanti alla tv e commenta l’ingiustizia delle cose che passano sullo schermo.
Amico
ho visitato un amico che stava morendo.
mi perdonò di essere vivo. mi sono accorto
che m’ero sempre vergognato. lui invece mi spiegò
che non era una colpa. non l’avevo fatto apposta, io.
mi spiegò che essere vivo non era una colpa. non facevo male
a nessuno. ma ci volle lui per spiegarmelo. a lui ho creduto.
mi spiegò che se facevo male non era con intenzione. mi perdonò.
mi consolò. sei simpatico, mi disse, anche se non stai morendo. nella
vita avrai tante cose belle, piacerai alle donne. mi fece far pace
con la vita, come si fa con una fidanzata riottosa.
(p. 199)
È nella faticosa conquista di sé, nella pace con la vita che si fa vedendo un amico che muore, che l’autore matura il suo più profondo senso di condivisione. Rivolto col pensiero all’intero genere umano, il poeta di La genesi di un pensiero (p. 261 e ss.) ha i suoi capisaldi nella conservazione della natura e nell’eterna simpatia per le vittime, gli ultimi, gli esclusi, anche al di là dei semplici diritti umani, come dimostrerà l’ultima provocazione prima delle Effimere conclusive. Il poeta misura su di sé l’entropia, si dibatte pensando che il mondo così com’è non può andare avanti, è atterrito e sollevato dall’idea della fine collettiva, confronta i titoli di giornale col suo senso di colpa e di nuovo è sospeso fra la fiducia verso i movimenti utili e necessari, e gli inganni dei potenti e delle classi dominanti, una sintesi storica sembra irraggiungibile.
Dall’eterno ritorno al suo vizio assurdo (Suicidio, p. 310) Bordini si concede molte vite, una serie di esistenze fredde e crudeli, in cui l’io recitante può ammettere senza troppi fronzoli di vivere senza che per lui sia possibile fare il bene degli altri. Il meglio della sua tecnica è espresso in certi (anti-)apologhi fulminanti in cui lo vediamo, ora, alle prese con la maturazione del trauma, prima e durante lo sbaglio che lascerà sulla vecchia carcassa della sua anima ammaccata una nuova microfrattura, un’intolleranza, una stranezza, una crisi di nervi. L’esistenza non può non essere il campo privilegiato di questo infastidito e un poco settecentesco avventuriero del dolore, che torna con la memoria a tutti i momenti in cui ha amato perdere, fallire, fare e farsi del male perfino, nell’imperativo assurdo e straniante di non essere umano.
Microfatture
L’idea della catastrofe, una catastrofe silenziosa,
appena avvertita, ma inevitabile.
Oppure le microfratture psichiche,
le microfratture di un’anima.
La mia anima è piena di
microfratture. Sono i piccoli traumi nascosti,
dimenticati, che tornano ogni tanto, quando l’anima è sotto sforzo,
quando non te ne accorgi. Dentro sono franato tutto. Non me ne accorgo,
ma lo sono. Magari quando attraversi una strada e un rumore ti fa rabbrividire,
quando tremi alla pronuncia di un nome, quando
hai un improvviso soprassalto di insicurezza. Le microfratture
sono le telefonate e gli appuntamenti che ti snervano,
improvvisamente,
l’andare in una stanza e chiedersi: che ci sto a fare,
ecc. ecc.
tutto un elenco dei nervosismi, dei soprassalti, delle cose che ti feriscono,
e le minuzie che ti snervano, ecc ecc
il cervello che funziona troppo,
(p. 313)
Solo alcune parole sullo straziato pugile sentimentale di Strategia, la breve sequenza uscita in prima edizione da Savelli nel 1981 e qui posta nella seconda metà del volume, in cui l’autore, all’apice della maturità, offre la sua cosa all’apparenza più adolescenziale, un corpo a corpo apertamente amoroso che racconta un lungo e complicato rapporto sentimentale, un «Rosa fresca aulentissima finito male» (p. 10) e scritto per non impazzire, come ricorda Francesco Pontorno nella sua introduzione.
Rinuncio per ora ad approfondire i motivi metrici, che pure sarebbe vantaggioso indagare nello specifico. Soltanto un cenno alla varietà della voce, che dal frammento di pochi versi può arrivare all’estensione del poemetto e ancora del discorso-fiume organizzato in capitoli, come nel caso di Pericolo (p. 222 e ss.). Si segnala la grande libertà con cui l’autore estende il suo strumentario di effetti grafici (passaggi in corpo maggiore, spaziature o interlinee doppie, sottolineature, a capo marcati) nel tentativo di accentuare o meglio indirizzare il tono della lettura, ma anche per assecondare un moto di ribellione e provocazione contro la gabbia testuale, a tal proposito si può confrontare la poesia tu sei la mia (p. 376) che lambisce il margine inferiore del foglio, quasi a oltrepassarlo.
Dal 1975 al 2010, e dal 2010 al 2014 con la nuova ristampa, il tutto-Bordini, che nella fascetta Guido Mazzoni definisce «uno dei libri più importanti usciti in Italia nel XXI secolo», è l’occasione per incontrare e conoscere la voce di un divino dilettante, positivamente sospeso sulle potenzialità del mezzo, avanguardista, informale, sperimentatore e comunicativo nel senso pieno, come l’ultimo geniale Sereni (quello di La poesia è una passione? e Un posto di vacanza) quasi imbarazzato davanti alla cronaca della propria e dell’altrui vita, perplesso e corroso dal senso di colpa, ma anche orgoglioso, rifugiato dentro il tic delle lettere come nella camera separata della sua odiata/amata esistenza.
Come dice Roversi nella prefazione, I costruttori di vulcani, rivissuto e ricostruito in occasione dell’accorpamento di tutte le raccolte, è un fiume, lo scorrere dalla fonte al mare di una massa liquida a volte impetuosa a volte in rigagnoli, in molte occasioni, e per lunghissimi tratti, insabbiata sotto la superficie del suolo.