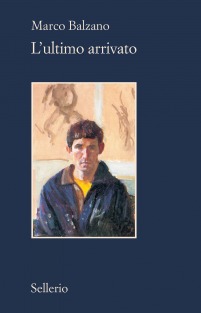Proprio in occasione di una recensione che scrissi per un altro libro di Enrico Macioci, lo scrittore che ne curò la pubblicazione mi consigliò di omettere questo particolare, che Enrico e io siamo amici da anni. Ebbene, ora che di anni ne sono trascorsi altri, non mi sento più di avallare tale scelta, anzi, come pensavo allora, penso oggi sia bene chiarire certe dinamiche per garantire al lettore la massima trasparenza. E mi sembra pure il caso di precisare il perché dell’intervista che segue: ecco, questa intervista serve a capire chi c’è dietro il libro di cui si parlerà, Breve storia del talento (Mondadori, 2015), e non perché si debba leggerlo, a questo scopo, infatti, può pensarci il testo stesso, dove, sono certo, ognuno di voi potrà ritrovare qualcosa della sua infanzia, adolescenza, vita.
Cos’è il talento, Enrico? E, visto che ci siamo, cos’è per te il talento in letteratura? – Domande con cui in questi mesi ti avranno assillato.
Il talento è la combinazione di tre fattori: un dono innato, ciò che Hillmann chiama «ghianda»; l’ambiente esterno (famiglia, circostanze, vicissitudini ecc.); il carattere. Se questi tre fattori si combinano in maniera favorevole il talento sboccia, se ciò non accade il talento può non sbocciare mai, e il mondo è pieno di talenti mai sbocciati.
Pensiamo a Mozart, forse la più compiuta apparizione di talento artistico di cui abbiamo notizia: nasce con doni irripetibili, ma pure con un padre musicista che lo sprona sin dalla più tenera età e per giunta in un’epoca d’oro per la musica classica e in un Paese all’avanguardia musicale come l’Austria; a tutto ciò aggiunge una dedizione e un impegno straordinari, per cui dai cinque ai trentacinque anni d’età (quando muore) non fa altro che comporre e suonare, suonare e comporre, regalandoci capolavori su capolavori. Però domando: se fosse nato in una famiglia musicalmente ignorante, avremmo avuto il Mozart che conosciamo? Ne dubito (Hillmann obietterebbe che la ghianda sceglie prima di nascere dove nascere, io non so cosa pensare). Se invece fosse nato in una tribù primitiva avremmo avuto il Mozart che conosciamo? Sicuramente no. Aggiungo che a volte il talento si manifesta in condizioni avverse, ma se uno va a ben guardare esse risultano spesso necessarie al manifestarsi di quel particolare talento, che magari è un talento “per opposizione”: pensiamo a tanti artisti ribelli venuti fuori da famiglie perbeniste e borghesi. In un certo senso, potrei riassumere, io ho “fede” nel talento, e cioè credo che nella maggior parte dei casi esso, se è sufficientemente forte, sappia trovare la propria strada. Magari però sbaglio, perché il talento resta comunque in larga parte un mistero.
Per ciò che riguarda il talento letterario il discorso è il medesimo. Aggiungo una considerazione che ho avuto modo di verificare sulla mia pelle. Il talento è il risultato ma anche la causa dell’impegno che un individuo profonde nel coltivarlo. Voglio dire che se hai molto talento per qualcosa è probabile che ti spacchi la schiena in quel qualcosa, se invece ne hai poco risparmierai la tua schiena per altre e più proficue attività. Il talento per lo scrivere è al tempo stesso un vampiro e una fonte: succhia energie che però restituisce in termini di ciò che amo chiamare centratura. Se scrivi un brano davvero bello, e cioè davvero rispondente al tuo suono, alla tua tonalità interiore, stai meglio, occupi uno spazio più sensato nel mondo, esisti di più, sei più reale. Avere talento per lo scrivere significa trovare le parole più prossime alla propria verità, che rimane sempre irraggiungibile.
Bene, abbiamo rotto il ghiaccio, veniamo al tuo Breve storia del talento. In esso, a mio avviso, possiamo trovare non tanto la genesi, quanto i primi passi, il processo di maturazione del talento, e poi, in un secondo momento, i frutti che maturano o meno nella vita adulta: era così che immaginavi il libro quando l’hai iniziato? Cosa ti ha portato, dopo La dissoluzione familiare, verso un’opera che potrebbe essere definita “romanzo di formazione”?
Quando ho iniziato il libro non avevo la più pallida idea di dove andare a parare, come sempre mi accade. Sentivo solo nei polpastrelli e nella testa vibrare un’armonia, l’armonia del magnifico Questo bacio vada al mondo intero di Colum McCann che avevo appena letto; una malinconia soffice ma feroce per tutto ciò che nella vita va perduto. Un simile stato d’animo deve avermi condotto verso il mondo dell’adolescenza, credo. E di lì in poi ha avuto il suo peso Stand by Me di Stephen King, che è una gemma e di cui una frase non a caso compare in esergo. Ma non pensavo a un romanzo di formazione, e non credo che Breve storia del talento lo sia. È piuttosto un romanzo di “sformazione”: cosa accade quando non sappiamo, o possiamo, o vogliamo dare retta alla nostra vocazione, al nostro daimon? Ecco di che parla Breve storia del talento, suppongo. E si badi: la figura di Michele vale per quasi tutti noi, perché quasi nessuno di noi sa davvero cosa desidera, dal momento che quasi nessuno di noi sa davvero chi egli o ella sia. Tutti crediamo di credere o non credere un sacco di belle faccende, ma pochissimi riescono a discernere la proiezione dal proiettore, il pensato dal pensante. Credo che questo problema rappresenti uno degli snodi di Gli increati di Moresco, fra l’altro.
Sullo scarto rispetto a La dissoluzione familiare. Quel romanzo era troppo folle ed estremo per avere un futuro, e per giunta lo scrissi in condizioni psichiche irripetibili (post/terremoto, post/primo figlio, post/lettura elettrizzante di Infinite Jest). Si tratta di un romanzo kamikaze: si dà fuoco mentre grida ciò che ha da gridare. Ma io non sono un kamikaze e volevo continuare a scrivere. Ho dunque intrapreso una nuova fase di cui Breve storia del talento è solo il primo passo e che, dopo circa tre anni e parecchi altri scritti (per ora – e forse per sempre! – inediti) ritengo a propria volta conclusa. Cosa verrà dopo? Chi lo sa. Potrebbe venire di tutto, compreso il silenzio.
Dato che ben conosco la tua passione per Rimbaud e la tua straordinaria prolificità nella scrittura, qual è il tuo rapporto con il silenzio? Perché l’hai tirato in ballo? E che relazione c’è, a tuo avviso, tra lo scrittore e il silenzio?
Beh, per quanto possa far sorridere, io ho già taciuto come scrittore fra i 14 e i 27 anni: un’eternità! Si può dire che la mia vicenda letteraria si divida finora pressoché a metà fra il parlare e il tacere, e ne accenno più volte in Breve storia del talento. Ma anche da bambino, prima di tacere, ero molto prolifico. Ho sempre oscillato e oscillo fra l’abbondanza e il digiuno, forse spinto dal tormento (di certo non solo mio) di non essere abbastanza bravo da “meritare” di scrivere, da un senso d’inadeguatezza e mediocrità.
Il caso-Rimbaud è naturalmente assai più complesso e paradigmatico. Paradigmatico perché col suo brusco silenzio marchia la storia della poesia, infliggendole una ferita ancora immedicata (ci hanno provato tutti a suturarla, poeti, filosofi, psicologi, critici: la ferita sanguina sempre). Credo che uno dei motivi per cui Rimbaud non venga riconosciuto apertamente e da tutti per ciò che è, ovvero il più importante soggetto lirico della modernità nonché l’autentico fondatore della stessa, consiste nel fatto che inquieta troppo. Baudelaire è molto più rassicurante, è un Leopardi più nuovo e più canaglia, ma Rimbaud… Anni fa un giovane ricercatore di letteratura francese dell’università di Pescara mi confidò di ritenere Rimbaud ben più grande di Baudelaire, ma di studiare Baudelaire perché Rimbaud lo spaventava. Mallarmé parla con timore di Rimbaud. Valéry ne è stupito, offeso e atterrito. Tutti i poeti ne sono atterriti, e a buona ragione, perché avvicinarlo e affrontarlo con radicalità e coerenza, seguirlo lungo la sua strada impervia e incendiata, significa affrontare l’abisso del silenzio. Che fare dopo? Proseguire? Saltare? E se sì, come? Dove? Ma rileggiamo quel miracolo che sono le Illuminazioni, scritte fra il 1872 e il 1874, quando da noi furoreggiava Carducci; e poi sento ancora parlare d’avanguardie…
La relazione fra lo scrittore e il silenzio dunque potrebbe essere questa: il silenzio racchiude ciò che separa lo scrittore dalla propria perfezione. Il silenzio però sta dopo la perfezione, e quindi la faccenda diventa paradossale e inattuabile. Nel momento in cui uno scrittore raggiunge la propria perfezione, tace. Ma poiché di rado la raggiunge, non tace quasi mai. «Sono pronto per la perfezione» scrive Rimbaud nella Saison, subito prima di tacere; ma lui era diverso. La perfezione, in linea di massima, non appartiene al nostro mondo, e come tutte le cose estranee ci terrorizza. Il nostro mondo è vecchio, storto, sbagliato, squallido e anche crudele, ma noi crediamo di conoscerlo, e in qualche maniera ci tranquillizza. Nulla ci spaventa più del cambiamento, e il silenzio di Rimbaud è davvero un atto diverso, uno di quei rari scarti assoluti dalla norma, un deragliamento reale e concreto (di qui si spiega il mito cui anche Étiemble dové inchinarsi) innestato nel corpo vivo della pratica poetica, un novum che dobbiamo ancora comprendere e sviluppare.
Chiami in causa il concetto di perfezione e mi viene spontanea una domanda provocatoria, pericolosa, e difficile anche, dalla quale però sono certo saprai cavartela: tu, Enrico, a che punto senti di essere nel fulmineo o lento cammino verso la perfezione? E dove collocheresti Breve storia del talento? Poi, ti interessa la perfezione come traguardo?
Tolstoj in uno dei suoi diari scrisse: «Non disperare di diventare perfetto». Ma io non sono Tolstoj. In realtà credo che la perfezione oggettiva in arte non esista; nemmeno la Divina Commedia o Re Lear sono opere perfette, perché rimane sempre la possibilità di fare meglio, un margine ulteriore, anche se è difficilissimo che accada. Esiste invece una perfezione soggettiva e cioè – per rimanere in ambito letterario – a un certo punto uno scrittore o una scrittrice producono un’opera che costituisce il massimo possibile delle loro qualità espressive e intellettive. Amo parlare in tal caso di “stato di grazia”. Mi viene in mente Il grande Gatsby di Fitzgerald, Revolutionary Road di Yates o Amabili resti di Alice Sebold, solo per rimanere ai nostri tempi. Opere che si stagliano sul resto della produzione dell’autore come vette innevate e lucenti. Tutto ciò è magnifico ma anche insidioso perché in qualche modo, credo, va a creare una barriera, un ostacolo: il futuro è già qua e tu non puoi far altro che peggiorare. Puoi provare a reinventarti ma non è detto che ci riuscirai. Fitzgerald per esempio non ci riuscì; pubblicò Il grande Gatsby a 29 anni e morì a 44 senza più riavvicinare quel livello sublime. Produrre un’opera perfetta è un po’ come suicidarsi, artisticamente parlando. So di manifestare una concezione apocalittica, ma tant’è.
Breve storia del talento, come già spiegavo prima, fa parte d’un percorso di svolta impostomi da La dissoluzione familiare, che ho pubblicato nel 2012 ma che avevo già sostanzialmente terminato a giugno del 2010. Non che quell’opera fosse perfetta, ma esigeva un cambio di rotta di cui Breve storia rappresenta l’inizio. E poi anche questa fase finirà – forse è già finita; e ne seguirà un’altra che comincio a intravedere.
Infine si sarà capito che io non aspiro razionalmente alla perfezione, dato che ne ho un concetto così castrante; però quando sei al lavoro è un altro paio di maniche; lì ti trovi davanti all’opera da creare e ce la metti tutta, t’impegni come se non ci fosse un domani. Anche perché nessuno ti assicura che un domani in effetti ci sia. Per cui riassumendo: no, non aspiro alla perfezione; sì, la cerco.
Rileggo l’intervista e credo sia proprio il caso di chiuderla qui, che ne dici, Enrico? Vorrei ancora sapere solo altre due cose: 1) Come sta andando Breve storia del talento? sei soddisfatto?; 2) Cosa ti aspetti dal futuro e cosa stai facendo per andare incontro al futuro che desideri per te?
Breve storia del talento sta andando abbastanza bene. Mi stupisce l’interesse che sta suscitando tramite i social network o il semplice passaparola, e mi stupisce che tante donne lo leggano e lo amino a dispetto dell’apparente tema calcistico. Del resto si sa che il novanta per cento dei lettori è costituito da donne. Io questo romanzo l’ho ripudiato nell’attimo stesso in cui l’ho finito, ma non posso che accudirlo e augurargli ogni bene. In fondo sono suo padre, e come molti padri sono indulgente, a tratti vile e fazioso.
Dal futuro mi aspetto cose nuove, anzi, inaspettate. A parte la salute mia e dei miei cari, forse ciò che desidero è una rivoluzione, un nuovo modo di stare al mondo prima che il mondo crepi, che scoppi come una pallina da tennis in un forno. Una rivoluzione non sanguinaria, perché tutte le rivoluzioni sanguinarie (ovvero la pressoché totalità) instaurano ciò che avevano preteso di distruggere. Sì, mi aspetto un rivolgimento epocale, di portata grandiosa, che cambi il mondo e l’uomo. Ci vuole, è tempo. Mi scuserai per la modestia delle mie aspirazioni.

(Enrico Macioci, Breve storia del talento, Mondadori, 2015, pp. 156, euro 17)