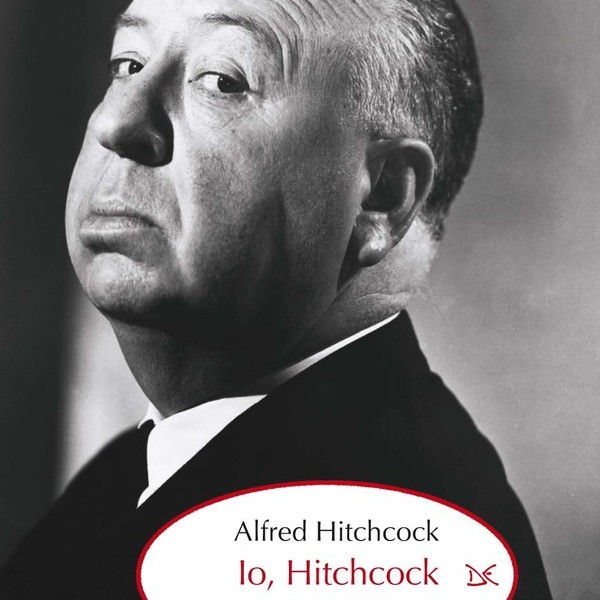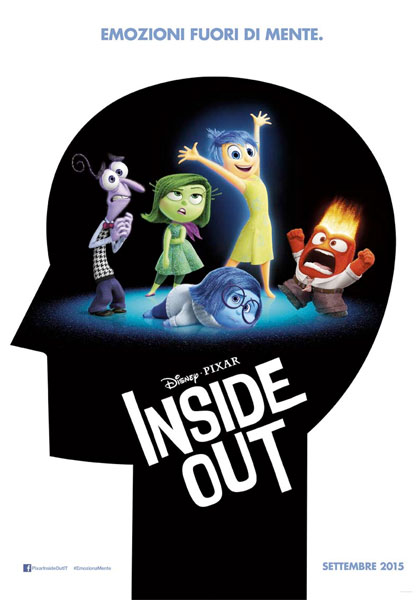Solo poche righe per raccontare quanto l’incontro con la poesia di Marco Giovenale, e poi con lui in persona, durante una lettura al teatro Palladium che mi ha convinto a vincere la timidezza e avvicinarmi, sia stato un piccolo shock. Come gli chiederò ingenuamente in un’aula deserta dell’Università Roma Tre dove mi ha raggiunto giorni dopo per una “chiacchierata per conoscersi”, l’impressione che viene dalla lettura di qualunque sua cosa (e la bibliografia è lunga e articolata) è quella di una lontananza profondissima, un affondo in avanti che lascia la stragrande maggioranza dei lettori ancora impegolati in un Novecento vischioso, irrisolto, immaturo, arteriosclerotico, mentre qualcuno ha attraversato i confini del “dopo la lirica” e ragiona sulla strada da fare. Corrado Costa, Giuliano Mesa, Carlo Bordini, questi alcuni dei nomi da fare in maniera più urgente per ripercorrere tutto d’un fiato la seconda parte del secolo ed arrivare a noi, o meglio a lui, Marco Giovenale; alla rottura della voce come senso a una sola dimensione, al superamento delle colonne d’Ercole che sono nella nostra testa, senza abbattere le quali, forse, non è più possibile seguire da vicino la poesia e capire la realtà.
La prima cosa che ti vorrei chiedere è come sei diventato poeta, quando ti è venuta in mente questa cosa, quali sono le tue “origini”.
Come mi è capitato altre volte di scrivere, per un periodo abbastanza lungo quando ero ragazzino, parliamo dei 13 o 14 anni, in verità la propensione era precisamente verso la prosa, in particolare verso il racconto breve. Ho sempre letto moltissimo perché in famiglia si leggeva molto, papà in particolare era appassionato di fantascienza e di libri gialli, però sono entrato in rapporti più o meno adiacenti a quelli per poi trovarmi in testi di Borges, Cortázar, e quindi in verità, in un contesto che è novecentesco in una maniera che già scardina tutta una serie di topoi di narratività classica.
Ti sei formato già sul “post”.
Sul post, sul dopo, su quello che in qualche maniera fa saltare i cardini, e questo doppio scardinamento, da una parte del genere, perché poi alla fine certe letterature sono laterali (la fantascienza…), e una narratività come quella inventata da Cortázar, mi hanno portato già sulla cattiva strada, in particolare Borges e poi Montale sul fronte della poesia, perché avevo da ragazzino una forte ostilità (considerandola una cosa un po’ effeminata, démodé) verso la poesia. Il mondo in cui io crescevo nei primi anni ’80 con una serie di altri interessi, era un mondo non impoetico ma di più, estraneo. Ricostruendo a posteriori, molto probabilmente si vivevano in quegli anni ’70 – inizio ’80, tutta una serie di mutamenti linguistici fondamentali, di cui poi ho scritto variamente in rete negli ultimi anni, a proposito dell’idea di “cambio di paradigma”, “spostamento dell’asse di ricezione” del fatto letterario da parte dell’intera società, non soltanto del suo segmento accademico, quindi diciamo che, a 15 o 16 anni, la grande letteratura, e i nomi di Borges, di Montale soprattutto, ed Eliot ancora di più, mi hanno riconciliato con la poesia perché me ne mostravano un volto tutt’altro che idillico, se pensiamo solo a La terra desolata. L’idea di fondo era che si potesse fare scrittura anche attraverso esperienze non proprie, quindi non tramite trascrizione, o in un rapporto (presunto) uno a uno col mondo, ma proprio attraverso un rapporto deviato, laterale, critico, conflittuale, e poi con parole di altri, come accade in tutta la costruzione di The Waste land. E di lì tutta una serie di tentativi di avvicinamento alla diagonalità della scrittura, al dire non diretto, non banale, non sfrontatamente narrativo e lirico, e tutta una serie di conseguenze che arrivano agli anni recenti. Due tentativi di scrittura un po’ più cristallizzata sono usciti, in maniera del tutto per me perdibile, negli anni ’90, però la prima opera che considero sensatamente proponibile a un pubblico è Curvature che esce nel 2002 per La camera verde, alla non più giovanissima età di 33 anni.
Leggendo alcune tue cose, come ad esempio Numeri morali, ho avuto l’impressione che tu e la tua esperienza siate estremamente avanti, al di là, oltre, e ovviamente tutto questo è basato sulla percezione della tradizione, tu stesso parli di Montale. Questa che forse è solo una mia impressione viene soprattutto da alcuni espedienti retorici che tu usi e sui quali ti chiederei qualcosa, soprattutto l’interruzione logico-sintattica della frase, la frase non è più al centro di quello che tu scrivi a vantaggio di parti più piccole, sintagmi che a volte sono giustapposti, invertiti, insomma, come componi? Come scrivi?
Il discorso forse si può biforcare, vero è che tante scritture ho affrontato nel tempo, e alcune in parallelo ancora ne porto avanti, alcune si interrompono altre proseguono come un filo d’acqua molto tenue, e altre invece diventano fluviali, ed è il caso della prosa, della “prosa in prosa”, di Numeri morali, e di altre che usciranno. Mentre invece il versante poetico, intendendo con poetico ciò che fa ancora riferimento a tutta una serie di clic, meccanismi e modalità compositive retoriche novecentesche va nettamente restringendosi nel tempo, e adesso diciamo che forse si chiude anche. Quindi è difficile dire come compongo, nel momento in cui c’è una raggiera di possibilità.
Quali sono i fronti?
I fronti possono essere quello più propriamente definibile poetico, quello che cioè fa capo a testi come La casa esposta, Criterio dei vetri, Delvaux, Soluzione della materia, che è una sorta di scrittura come direbbe Kasey Silem Mohammad in senso critico, handwritten, scritta a mano: ci può essere un foglio di carta e la penna, oppure il testo digitato al computer, ma sempre e comunque sulla base di una serie di flashes, momenti che sono sì di esperienze individuali, ma che vengono totalmente riscritti, ricodificati, sovrascritti, da una serie di impossibilità retoriche, di autointerdizioni rigidissime che non possono non esserci, per esempio l’insofferenza violenta nei confronti dell’iperbato, dell’inversione, dell’enfasi. E quindi una scrittura che, come giustamente hai notato tu, a volte si permette addirittura di spezzare la frase in uno o più punti (dove diversamente produrrebbe un certo tipo di senso per tradizione già testato), a rischio di compromettere la tessitura sintattica stessa, a rischio di compromettere non il senso ma il significato della frase. In verità poi interviene quell’altro controbilanciamento, il contrappeso che è l’apertura di credito e fiducia nei confronti del lettore, che non considero un lettore che deve semplicemente eseguire una partitura sintattica che io gli devo in maniera più o meno gigiona servire su un piatto d’argento, ma è in grado di fare quei salti logici che il testo in qualche maniera implica. E quindi mi trovo a segmentare il testo, a spezzarlo in punti significativi, in punti che poi creano dei picchi fono-semantici ricchi, carichi di aperture. Cecilia Bello Minciacchi più volte ha parlato di anfibologie come aperture di testo a 360 gradi che implicano addirittura due, tre, quattro significati contemporanei tutti quanti spendibili dal lettore nella produzione di senso. Questo per la poesia. Per la prosa il discorso cambia completamente, nel senso che a volte ci sono materiali riportati, e l’organizzazione dei materiali avviene secondo un’altra griglia di sofferenze e autointerdizioni. Poi ci sono testi ancora differenti, come le Ossidiane per esempio. Addirittura nelle Ossidiane arrivo a una non sopportazione di microstrutture della frase, avverbiali, quindi non più al livello alto della retorica, ma a quello anche minimo del conversare comune.
Quindi una tua marca individuale è l’idiosincrasia, l’ipersensibilità. Ti potrebbe calzare?
Idiosincrasia, insofferenze frontali nette.
Sospendiamo un attimo e leggiamo una poesia da Shelter (Donzelli, 2012):
Dietro la parola della porta
finisce la proprietà.
Non è esatto, allora la porta
è socchiusa, un poco oscena.
È l’ovale spesso:
spia dal vetrino fissato
alla carta come un dubbio, alla strada,
a ogni variazione della strada
e ne torna, fatta dubbio, lei
stessa – nel
suo abito larva avorio, largo,
rivolge, riavvolge fra le mani
oggetti che la balaustra copre
e da qui non si vedono
ma sicuramente ci saranno.
Questa è una poesia sulle poesie? C’è la parola, la proprietà…
Io in realtà la vedevo più come una sorta di separazione materiale. Questo è il tentativo di annotazione corsiva, violentemente veloce, di una separazione tra interno e esterno ma reale, concreto, non a caso fa parte della raccolta Shelter che significa riparo, rifugio, ma anche prigione, perché da una parte ci si rifugia, ma dall’altra si sta dietro la porta dove finisce la proprietà e dall’altro lato c’è la strada, e ci sono le variazioni della strada. Questa donna che torna nel suo abito-larva-avorio, riavvolge fra le mani degli oggetti che per noi che guardiamo da fuori la balaustra copre. Daccapo qui siamo di fronte a un quadretto non oleografico, che è quello di un rientro in un luogo chiuso di una persona che sta muovendo delle cose fra le mani, e mi tornano in mente tante figure di folli dostoevskijani che devono trafficare con le mai fra le cose. In realtà è giustissima questa osservazione sul fatto che la proprietà è anche la proprietà di linguaggio, un’altra delle cose che la follia fa perdere, e la porta si riduce a una sorta di parola.
Leggendo Shelter ho pensato che una cosa che manca, e forse arriviamo alla prosa, è l’io. E ci sono invece molti “loro” anche sottintesi. Questo mi ha dato l’idea che tu cerchi una specie di freddezza forse dovuta anche alle tue idiosincrasie.
Una notilla ex post. In Shelter non ci sono riferimenti diretti a lui, però dopo il 2001 sicuramente è stato molto forte il dialogo con Giuliano Mesa, ed il suo libro che io preferisco si intitola I loro scritti, uscì per Quasar e adesso è raccolto con le altre poesie da La camera verde. I loro scritti, una deviazione verso una voce collettiva che cerca però di non essere enfaticamente collettiva, politicamente sparsa su una moltitudine a cui comunque l’autore dà voce. Forse ciò che banalmente non esiste e continua a essere una costruzione reimpalcata davanti i vari teatri del mondo, è appunto la costruzione del “moi” dell’io lacaniano, come oggetto coeso, come figura che nello specchio si vede intera e che quindi ci fa gioire, e dovrebbe secondo noi far gioire tutti perché vedono la nostra integrità, cosa che comunque non è. E questo, a volte, sparso e sperso, per rubare un’espressione della Rosselli, nei testi, anche in chi non usa grammaticalmente l’io, è perfettamente tangibile, plasticamente formato, perché il lettore, ma questo è un problema anche mio, si vede fatto oggetto di un interesse di specchio da parte dell’autore, l’autore nel lettore cerca una sottolineatura dei propri a capo, delle proprie rime, della giustezza dei propri rimandi semantici, e questo chiaramente ci riporta alla prosa. La prosa è veramente, al contrario del “moi”, il soggetto di un inconscio, questo flusso che esplode, un cursore spostato da un autore che è – lui per primo – travolto, fermo in blocchi trasmissibili agli altri, ma sempre empirico, sull’orlo del fallimento.
Bisogna ammettere che uno scritto di prosa in prosa chiede molto al lettore, rispetto al mercato che c’è intorno. Come porsi nei confronti di chi vuole, cerca o subisce, convinto di averlo scelta, una lettura in cui c’è un autore che fa tutto perché il lettore pensi il meno possibile? Come ci si pone davanti a chi dice: «Io queste cose non le capisco, per me non hanno senso»?
L’iniziativa che si inventò Giuliano Mesa alla fine degli anni ’90, Àkusma, per raccogliere voci di autori diversissimi fra loro intorno a un’idea di ascolto reciproco (perché alcune poetiche rigidamente normative avevano scavato dei solchi tra autori che invece singolarmente erano più che disposti ad interscambi e dialoghi), portò a un convegno a Bologna e poi a un’antologia con lo stesso nome pubblicata da Metauro nel 2000. Giuliano volle riavviare una serie di incontri sotto la stessa sigla qui a Roma, e ne facemmo una decina circa, e ascoltammo le voci più diverse tra loro. Una delle cose che faceva Giuliano, e che più spesso ha fatto in passato anche indipendentemente da Àkusma, era organizzare letture in luoghi non deputati alla lettura, spesso a lui è capitato di fare delle letture in un bar, di confrontarsi con le persone le più semplici. Giuliano era di estrazione popolare e ha sempre parlato a tutti con la sua scrittura assolutamente complessa. Quello che a me sembra è che con l’esecuzione vocale del testo anche chi è più distante dalle modalità della complessità avverte la presenza di alcune linee che lo catturano, e di altre che lo respingono. Sono stato giorni fa a Bologna con Michele Zaffarano che ha letto una sequenza in modo quasi meccanico, e una ragazza è intervenuta dal pubblico dicendo: «Leggere così mi dà qualche difficoltà perché io starei per trovare una linea di senso, però la sua lettura mi fa sentire di fronte a un ostacolo». Ebbene, in verità è questo essere posti di fronte a un ostacolo a produrre quello scalino ulteriore che alcuni lettori possono trovare sulla strada, in senso positivo: da quell’inciampo possono rintracciare il senso del testo e della ricerca, nel testo che stanno affrontando e in altri ancora. Da una parte sono d’accordo con modalità di lettura in cui si mantiene questa comunicazione di una non transitività immediata, con momenti di interruzione, in un altro senso penso che l’articolazione sonora crea come delle legature, delle ricostruzioni di senso che aiutano invece il lettore a gettare un ponte laddove ci può essere un a capo, o a far avvertire un ritorno di suono laddove questo ritorno ha un significato che diventa immediatamente evidente. Questo per tutta una serie di testi. Ci siamo trovati al Palladium per la lettura dei testi di Oggettistica, testi molto recenti miei. Penso che in quei testi lì veramente ci sia una transitività totale, a me è sembrato che i testi passassero, anche non essendo compiacenti verso il gusto del pubblico, spero. Erano testi in parte paradossali. Se vogliamo pensare a un’eco per quelle pagine posso pensare a Christophe Tarkos, autore di ricerca, i cui testi sfido chiunque a trovare incomprensibili: perfettamente transitivi ma perfettamente spiazzanti. Mi auguro di trovarmi indegnamente in quell’onda lì.
Il nocciolo della risposta è la presenza, la lettura: bisogna esserci di persona, non è un ufficio a perdere.
Quando sono testi scritti sì. Se un certo tipo di contesto culturale effettivamente cambia, potrà anche cambiare la percezione del lettore. Se il mondo editoriale, ma tutto il mondo, continuerà a inclinare verso forme specifiche di romanzo, là è evidente che le generazioni che si susseguiranno saranno sempre estranee a… ma non dimentichiamoci che è successo tante volte.
Facciamo pubblicità a tre autori che scegli tu.
Sicuramente quest’ultimo libro di Nathalie Quintane, Osservazioni, tradotto da Michele Zaffarano per Benway Series. Stringhe di frasi facilissime a dimostrazione che si può costruire un testo con elementi quasi infantili, facendoci riflettere sulla leggerezza delle esperienze più banali. Un altro libro è aria (comunione) di Mario Corticelli (IkonaLíber), un libro spiazzante perché parla dell’aria ed è in realtà una riflessione sul potere e sulla violenza introiettata da noi tutti nel respirare quest’aria di questo scorcio di inizio secolo. E poi Carlo Bordini: tutto quello che si trova in giro va acquistato e letto. Se dovessi aggiungere un quarto nome direi tutto quello che si può trovare di Corrado Costa, perché a mio parere è il nome da fare per pensare a che cosa sarebbe veramente potuta essere la scrittura in Italia se non ci fosse stato quell’imbuto che ha ingoiato anche fisicamente molti autori interessanti all’abbrivio fra anni Ottanta e anni Novanta.
*
senza titolo
un elicottero abbastanza sicuro.
anche la rete della pellicola, meglio se dentro, è sicura.
il museo è sicuro, e la settimana.
sono sicuri i ricavati, è sicuro il tiraggio.
l’autunno, di solito, anche se ci sono delle variazioni, è sicuro.
i locali notturni sono sicuri.
il respingimento, il battito dei gatti, anche:
sicuri.
l’immaginazione è sicura.
l’ascolto è sicuro.
la linea è sicura.
c’è un posto sicuro.
il monitoraggio dell’area è sicuro.
i materiali sono sicuri, se ne siamo sicuri.
l’iban è sicuro perché serve solo per ricevere soldi.
è sicuro il lunedì, anche il martedì, si direbbe.
è sicuro l’inizio, in sostanza è sicura la fine.
la religione sotterranea è piuttosto sicura, e quella aerea.
la pratica è sicura.
il mouse è sicuro.
gli impiegati sono sicuri.
sono sicure le proporzioni.
la sicura è sicura, lo dice il nome.
lo stroboscopio pure, lui è sicuro.
come l’oscilloscopio.
il fumo è sicuro.
è sicuro il calcestruzzo.
come sono sicuri i punti cardinali, il sud.
la baia è sicura.
la polizia è sicura sempre.
la lucentezza è sicura.
il compressore è sicuro.
il ladro è sicuro, siamo sicuri.
per le stesse ragioni è sicuro il gioco.
il cavo è sicuro.
la musica è sicura.
[da Exit, 2013]
Marco Giovenale lavora a Roma come editor, traduttore indipendente, lettore per case editrici; e, talvolta, libraio freelance. I suoi libri di poesie più recenti sono Shelter (Donzelli, 2010), Storia dei minuti (Transeuropa, 2010), In rebus (Zona,collana Level 48, 2012; con i testi vincitori del Premio Antonio Delfini 2009 e altri inediti) e Delvaux (Oèdipus, 2013). Una bibliografia – con otto ossidiane inedite – è Tagli / tmesi (La camera verde, 2013). Le sue pagine web principali sono Slowforward e Differx.
Foto di copertina di Dino Ignani.