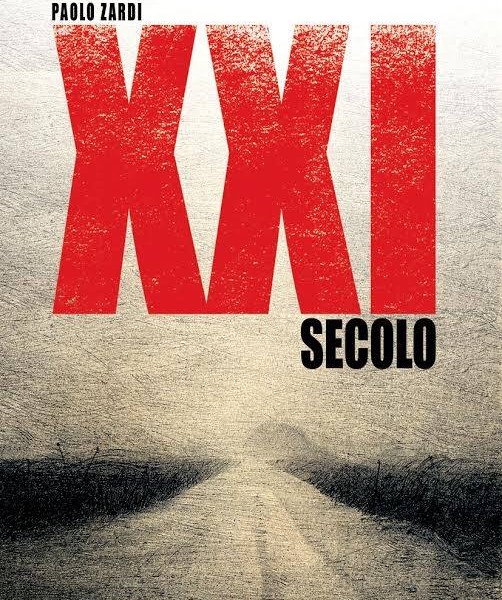C’è un altro lato degli Stati Uniti, lontano dalle grandi città, dalla cultura di New York e dalla frenesia di Miami, dalle spiagge della California e dalla mondanità di Los Angeles. C’è un altro lato degli Stati Uniti che è diverso anche dalle comunità rurali del Mid-West, dalle sette religiose e dalle villette a schiera dei sobborghi. È un lato in cui si raccolgono le persone che non entrano nei centri commerciali, che non mangiano nei fast food o nei diner, che non accendono mutui per comprarsi casa, che non consumano. È un lato che Roberto Minervini ha trovato nella Louisiana del nord, nel paesino di West Monroe, dove il 60 per cento della popolazione non ha un lavoro e vive alla giornata, dove i bianchi sono poveri e formano una schiera immensa di sottoproletariato galleggiante, di vite tentate e speranze anestetizzate. È il mondo del cosiddetto white trash, quell’immondizia bianca marginalizzata dalla società che si reinventa ogni giorno come comunità per poter sopravvivere.
Mark produce metanfetamine che vende in giro per la città. Non è quello che vorrebbe fare, ma non può fare altro. Lavorando a giornata in una discarica si becca venti dollari per spaccarsi la schiena. Lui china il capo, ringrazia, poi torna nella sua casa mobile con la fidanzata Lisa a drogarsi e sintetizzare altri cristalli. È già stato in carcere, per due anni e mezzo, e il suo desiderio nella notte di Natale, mentre cena con la sorella e il nipote che si drogano insieme, è quello di non tornarci, almeno finché sua madre, malata di cancro, non sarà morta. Allora sì, che verrà il momento di scontare quello che deve scontare, di smetterla per sempre con le siringhe e le pipe di vetro e di ripartire lontano da West Monroe e da tutto. Perché lì non c’è niente per lui, per Lisa e per tutti gli altri. Per gli anziani che si sentono abbandonati dopo aver combattuto guerre che neanche capivano. Obama ha fallito, ha ingannato tutti, anche la gente di colore. Ora si spera in Hillary Clinton, perché tanto era lei a comandare anche quando il marito era presidente. Forse con lei arriverà un momento migliore. Se Mark, Lisa e i loro amici si sentono abbandonati e trovano l’unico rifugio nella droga e nell’alcol ci sono quelli che non si arrendono, che si organizzano in gruppi paramilitari e prendono le armi per prepararsi alla rivoluzione, a combattere quando arriverà il momento in cui il governo verrà a togliere la loro libertà.
Dopo la trilogia sul Texas formata da The Passage, Low Tide e Stop the Pounding Heart, Roberto Minervini si è spostato in Louisiana su suggerimento di uno dei protagonisti del suo film precedente. È stata proprio la miseria, ad attirarlo, il senso di abbandono e di isolamento di un mondo marginale e distante dall’immaginario statunitense. Dalla Bibbia alle metanfetamine, dai rodeo agli addestramenti paramilitari, Minervini racconta una realtà completamente diversa, un livello di disperazione e anarchia che non è immaginabile nella più grande democrazia del mondo. Quello che colpisce di Louisiana – The Other Side è la capacità che ha avuto Minervini di sparire dal racconto, di mostrare senza un punto di vista, di far dimenticare ai protagonisti (persone vere, non attori, storie vere, non scritte a tavolino) e agli spettatori che ci sia una telecamera a filmare quello che succede. I suoi film riescono a fondere insieme la verità del documentario con la costruzione e il montaggio propri della finzione. Con un lavoro lento e prolungato, sviluppato nell’arco di quattro anni, Minervini è riuscito prima di tutto a inserirsi nella comunità di West Monroe per conquistare la fiducia di Mark, di Lisa e di tutti gli altri, per poi riuscire a mantenere la naturalezza assoluta dei suoi protagonisti anche nel momento in cui ha tirato fuori la macchina da presa. E allora noi lo vediamo, davvero, questo white trash nella sua miseria. Vediamo Mike che inietta metanfetamina a una spogliarellista incinta nel bagno fetido del locale in cui lavora, alcolizzati senza denti che fanno male alla nipotina per giocare, una banda di uomini armati crivellare di proiettili una macchina con a bordo la maschera di Obama. Mai, neanche per un momento, c’è condanna o derisione o denuncia.
L’intenzione di Minervini non era quella di fare un film politico, ma Louisiana lo è diventato. La vita “dall’altra parte” di West Monroe chiama in causa continuamente la politica. I paramilitari vogliono difendere l’ideale americano da un’America che lo ha dimenticato. Sognano e progettano un ritorno a un’organizzazione sociale elementare per non dover rispondere a nessuno, vogliono legalizzare la libertà. I tossici, gli alcolizzati che girano intorno a Mark, vogliono un mondo in cui non essere schiavi di nessuno e in cui la libertà torni davvero a essere libera.
Senza giudicare, ma dividendo Louisiana in due parti (la prima su Mark, la seconda sui paramilitari), Minervini lancia un implicito confronto su quale rifugio sia migliore, se quello della dipendenza o quello dell’esaltazione violenta della vita. Non gli importa di dire cosa sia meglio, gli importa solo di ricordare che quei mondi esistono.
(Louisiana – The Other Side, di Roberto Minervini, 2015, film documentario, 97’)