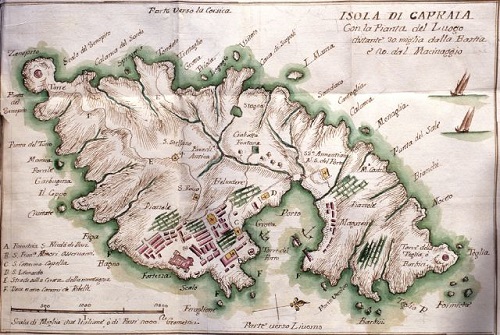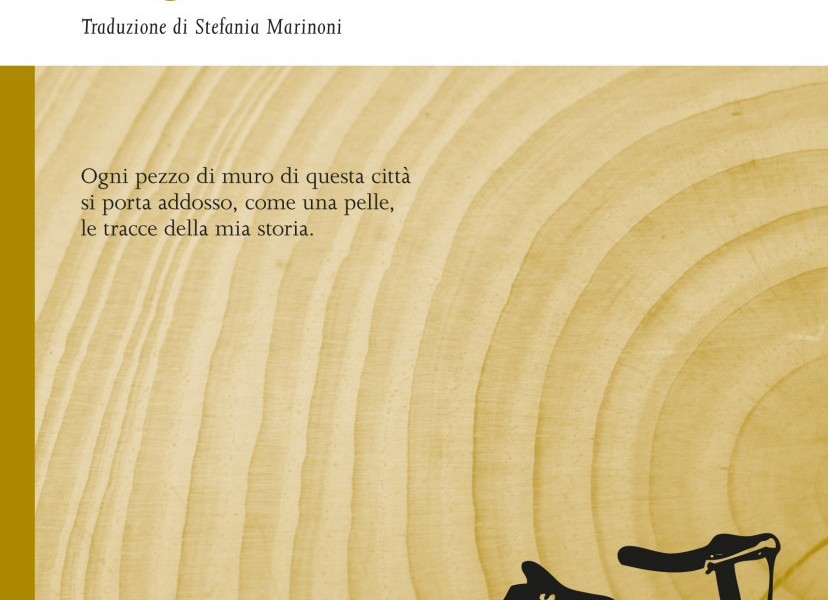«In ogni lingua che conosco, e anche in quelle che non conosco, il nome di Giuda è diventato sinonimo di traditore. E forse anche sinonimo di ebreo. Per milioni di cristiani ogni ebreo porta in sé il marchio infamante del tradimento».
Non sempre una storia per essere considerata d’impatto deve rispondere all’ovvietà di formule prestabilite che definiscono ogni questione lasciata aperta durante la narrazione; partendo da questo punto di vista Amos Oz mette insieme un libro che esiste e si completa nell’irrisolto, che non vuole fornire risposte ma tende a concentrarsi sul passato e sulle possibili variabili di un seguito rimasto scoperto.
Nello specifico si concentra sulla complessa figura di Giuda Iscariota suggerendo un’analisi insolita, e volutamente non risolutiva, sul suo presunto tradimento nei confronti di Gesù; Oz infatti definisce le azioni di Giuda come il più grande atto di fede e di amore verso un uomo che non crede in se stesso, che vacilla mentre cerca di compiere il suo destino. In fin dei conti dunque è stato Giuda a “creare” il figlio di Dio, il primo a credere nell’immortalità di Gesù tanto da favorirne la morte per dimostrarlo.
«Chi è pronto al cambiamento […] chi ha il coraggio di cambiare, viene sempre considerato un traditore da coloro che non sono capaci di nessun cambiamento, e hanno una paura da morire del cambiamento e non lo capiscono e hanno disgusto di ogni cambiamento».
A esercitare un perfetto contrasto con questo concetto saranno i protagonisti del romanzo, cristallizzati in uno spazio-tempo inaccessibile e a tratti irreale.
In Giuda (Feltrinelli, 2014), infatti, fin da subito si avverte una forte sensazione di estraneità: del lettore che non riesce fino in fondo a immergersi ed empatizzare con i caratteri asciutti dei personaggi e degli stessi personaggi che conducono una statica esistenza periferica, come se fossero avvolti da uno spesso strato di tacita arrendevolezza.
Primo fra tutti il protagonista Shemuel Asch che rinuncia agli studi – e in particolare alla sua tesi Gesù visto dagli ebrei giunta ormai a un punto morto – a causa dell’improvviso dissesto economico della sua famiglia e della parallela separazione con la sua ragazza Yardena, deciso ad andarsene da Gerusalemme senza avere una meta o una prospettiva ben precisi.
Sarà un insolito annuncio affisso nella bacheca dell’Università a incuriosire Shemuel e trattenerlo in città: alloggio gratis e una paga ragionevole in cambio di alcune ore serali di conversazione con un colto settantenne invalido ma generalmente capace di badare a se stesso.
Shemuel quindi si ritrova a vivere in vicolo Rav Albaz 17 nella casa dell’intellettuale Gershom Wald e dell’enigmatica e affascinante Atalia Abrabanel, ma chi siano e cosa facciano queste due misteriose figure inizialmente non ci è dato saperlo e anche dopo aver disposto tutte le carte in tavola e aver delineato i loro profili resteranno impenetrabili.
Quel che si sa per certo è che Shemuel, nella claustrofobica mansarda di Rav Albaz, dovrà fare i conti con altri traditori o presunti traditori del passato, con un amore non corrisposto, con le controversie del cristianesimo e degli ebrei, con un anziano attaccato alle parole più che ai ricordi e con la propria solitudine che trascinerà con sé anche quando sarà inevitabilmente lontano.
«Tu presto te ne andrai per la tua strada e sentirò un po’ la tua mancanza qui, soprattutto nelle nostre ore, quando la luce cala in fretta e la sera penetra nelle ossa. Io vivo qui da un addio all’altro».
Non è sicuramente un libro dalle soluzioni facili, ogni argomento toccato tende a sfumare tra le pagine invece di essere sviluppato e la trama è tutt’altro che definita; eppure questo romanzo apertamente irrisolto contiene qualcosa di estremamente più importante: la possibilità di una via di fuga.
(Amos Oz, Giuda, tra. di Elena Loewenthal, Feltrinelli, 2014, pp. 329, euro 18)