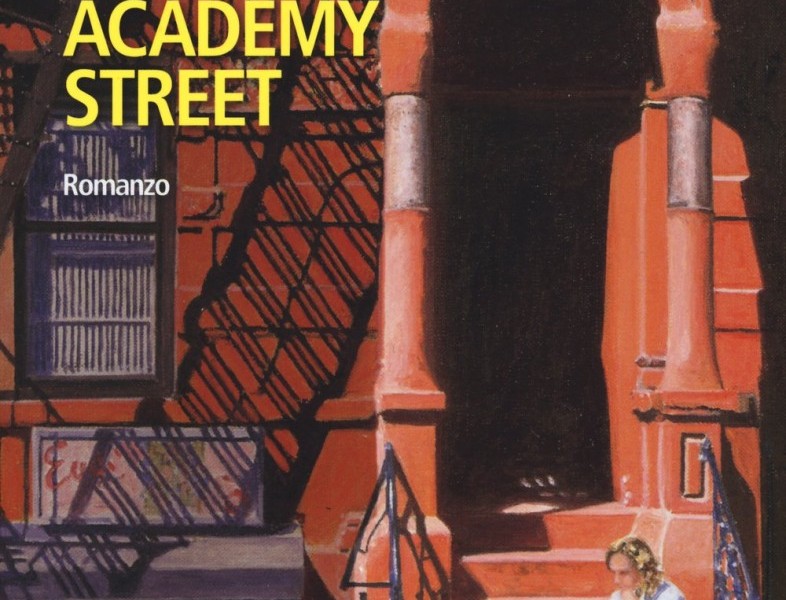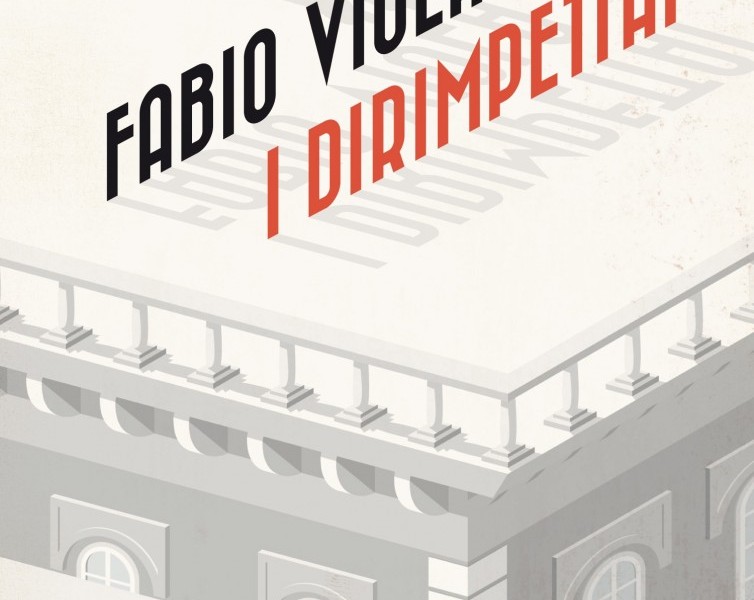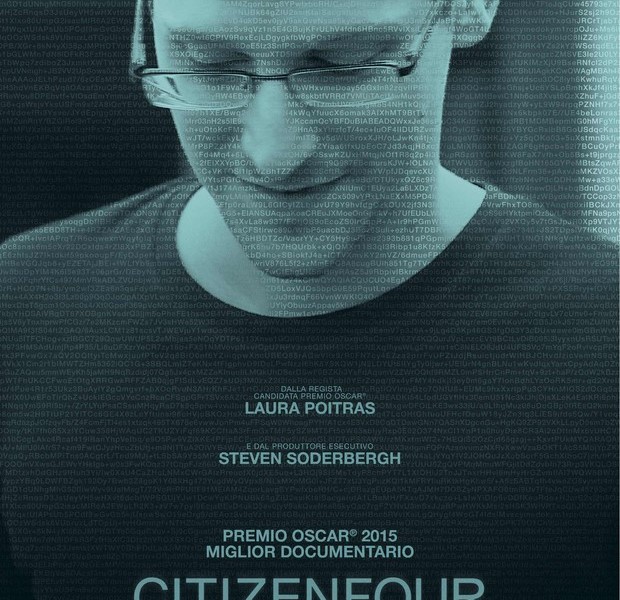La compagnia Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa è nata dall’incontro di Marco Isidori con l’attrice-docente Maria Luisa Abate nel 1983, a Torino, ed è stata ufficialmente fondata nel 1984 da Marco Isidori, Daniela Dal Cin, Maria Luisa Abate e Sabina Abate, a cui successivamente si aggiungono Lauretta Dal Cin e Ferdinando D’Agata. Dopo quattro anni di assenza dai palcoscenici capitolini torna a Roma per presentare un sorprendente Edipo Re, realizzato in coproduzione con la Fondazione del Teatro Stabile di Torino.
Nella traduzione del regista Marco Isidori le suggestioni della scrittura sofoclea vengono ibridate e disciplinate, così come nella trasposizione scenica, a quelle hölderliniane dell’Edipo il Tiranno. Dichiara, infatti, Isidori: «Hölderlin, insieme naturalmente con la profonda maestria sofoclea, è il mentore della versione marcidoriana della tragedia in questione: non ci siamo serviti direttamente della traduzione che Hölderlin fece del capolavoro sofocleo, però, anche se assai discosta da questa, la nostra “riscrittura” dell’Edipo è stata spiritualmente influenzata dall’esito del gigantesco lavoro di sonda che il poeta tedesco ha dedicato all’originale dettato greco». E ancora: «Abbiamo sottoposto il testo a una sorta di aratura tragediografica che ne riducesse l’apparato mitologico e permettesse la germinazione spontanea di una struttura verbal/letteraria iperaccentuata su un versante di sbilanciamenti continui e intenzionalmente provocati, pervenendo così ad un amalgama sonoro vorticante, che soprattutto andrà ad interessare la parte corale dell’esperimento in atto, servendo in questa maniera la nostra concezione fortemente fonematica del processo di comunicazione teatrale».
Protagonista la scenografia di Daniela Dal Cin che è valsa a questa produzione la candidatura al Premio Ubu 2012. Una sorta di ziqqurat attrezzato con passaggi segreti, botole, piattaforme e troni semoventi, che si fondono con geometrica perfezione con le coreografie curate al millimetro che gli attori eseguono rendendo viva la scena e fondendosi, viceversa, con essa. La peste tebana sembra contagiare anche lo spettatore attraverso l’impressione virulenta che fa la pittura primitiva che ricopre le pareti della macchina teatrale, la morte e il deserto dell’anima garriscono al vento fin dall’inizio nella rappresentazione degli animali morti esposti come bandiere attorno alla piattaforma, e bastano pochi oggetti per far emergere dal coro Tiresia, Creonte, il Servo e il Messaggero, rispettando la tradizione che vuole il corpo sociale greco inserito di diritto nelle vicende mitico-politiche della città stato.
Nel giudizio sull’operazione dei Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa non c’è via di mezzo: o la si odia o la si ama. Perfettamente coerente con le promesse registiche, la messa in scena improntata allo studio fonetico del testo, lascia all’inizio spiazzati e costringe a un doppio livello di ascolto, per gustare la musicalità del verso e per ricavarne il senso, presupponendo, quindi, la conoscenza della vicenda sofoclea da parte di un pubblico che si vuole colto e avvezzo alle intemperanze del teatro non convenzionale. Lo spettatore non partecipa emotivamente al dramma del sovrano inviso agli dei, piuttosto, nella condizione della Giocasta ingabbiata in pesanti e metalliche ali di farfalla, non è posto nella condizione di elevarsi al di sopra dell’ingombrante significante.
Edipo Re
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
Drammaturgia e regia: Marco Isidori
Scenario e costumi: Daniela Dal Cin
Con Marco Isidori, Lauretta Dal Cin, Maria Luisa Abate, Paolo Oricco, Stefano Re, Valentina Battistone, Virginia Mossi