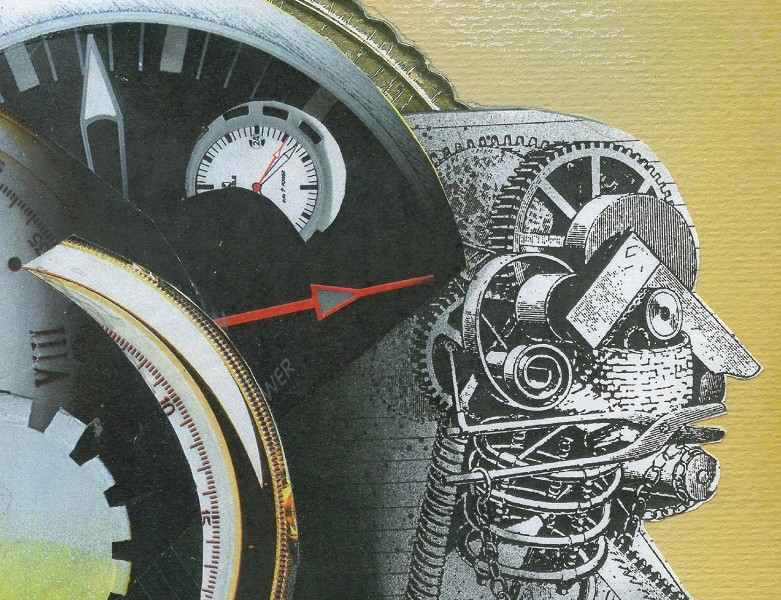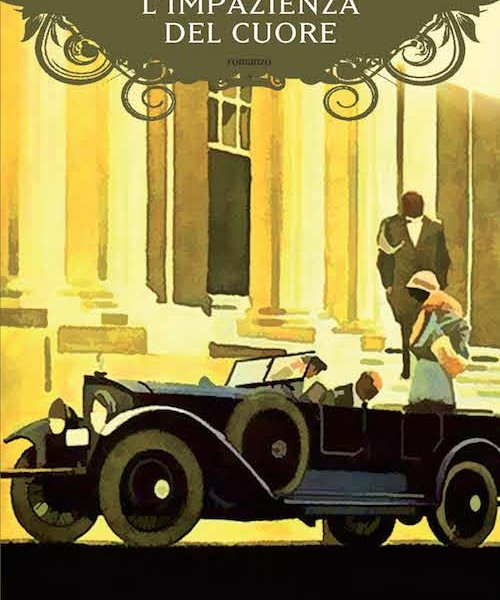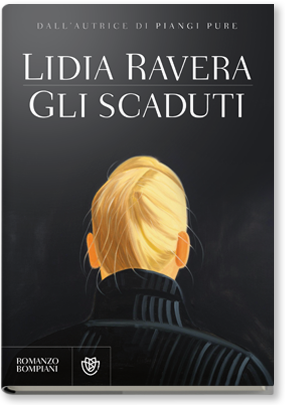L’appuntamento è alle 11, davanti al portico d’Ottavia. Ho inseguito Jhumpa Lahiri per giorni e lei questo non lo immagina nemmeno. Prima alla Casa delle Letterature; poi a Libri come, dove ho giusto il tempo di scambiarci due parole e ottenere il suo contatto e-mail; infine alla Dante Alighieri, qualche giorno prima. Finalmente riesco a incontrarla per l’intervista. Chi mi ha parlato di lei me l’ha descritta come una persona timida, a tratti persino schiva, dai modi e dal portamento eleganti. Da parte mia non credo di spiccare per socievolezza o loquacità, ma sono curioso di vedere che cosa ne verrà fuori. Appuntamento al portico d’Ottavia, dunque: so che è il suo monumento preferito a Roma, ma anche una delle similitudini che più ama fare riferendosi all’italiano, lingua che ha deciso di studiare in modo tenace, dopo essersene innamorata una ventina di anni fa, e dalla cui esperienza è nato In altre parole (Guanda, 2015), una sorta di educazione sentimentale all’italiano.
Dopo esserci presentati, infatti, mi racconta del perché si senta così legata a questo luogo: «Ho sempre visto il portico d’Ottavia sorretto dalle impalcature, sin dalla prima volta che sono venuta a Roma e abitavo poco distante da qui. Credo che senza, crollerebbe; nonostante sia un’ostruzione, l’impalcatura aggiunge alla rovina un attributo commovente. Quando scrivo in italiano mi sento un po’ così, sorretta dalle persone che mi seguono, che leggono i miei scritti, che mi correggono e mi danno consigli: senza di loro forse crollerei».
Al momento di decidere dove andare per iniziare l’intervista, azzardo una passeggiata fino a San Callisto e un caffè al bar della piazza, per mostrarle uno dei pochi luoghi con ancora intatta la propria aurea di autentica romanità, lei però preferisce avvicinarsi alla biblioteca dove lavora abitualmente. Ci incamminiamo per i vicoli del Ghetto e dopo pochi minuti siamo seduti nella saletta interna di un bar, in via dei Funari.
Mi è capitato di incontrare altri autori internazionali, da Peter Cameron a Valeria Luiselli; ho parlato con importanti scrittori italiani, senza la minima titubanza, ma l’idea di intervistare Jhumpa Lahiri mi innervosisce un po’. Sarà per il Pulitzer assegnatole nel 2010, sarà per la classifica di Forbes che la annovera tra le narratrici più influenti del panorama contemporaneo, o per quel suo essere all’apparenza impermeabile; ho portato con me una copia di un libro di J.R. Wilcock, La sinagoga degli iconoclasti, da regalarle per rompere il ghiaccio. Ho sentito infatti, durante una delle sue presentazioni, che ha un interesse per quegli autori che decidono di scrivere in una lingua altra rispetto alla propria lingua madre – nomina Conrad, Nabokov, Beckett, persino Cioran – e Wilcock, che ha abbandonato lo spagnolo per scrivere in italiano, è un altro esempio sublime. Jhumpa mi chiede perché questo scrittore abbia scelto proprio l’italiano. Le cito le parole di Wilcock: «Ho scelto l’italiano per esprimermi perché è la lingua che più somiglia al latino […] Un tempo tutta l’Europa parlava latino, oggi parla dialetti del latino: la passiflora in inglese si chiama passion-flower, per me le due sono la stessa parola». So che anche lei ha studiato latino, mi sembra colpita, e io sono pronto per iniziare l’intervista.
Jhumpa, nel libro parli di esilio, di allontanamento dall’inglese, di un tentativo di fuga attraverso la lingua italiana. L’impressione che ho avuto, soprattutto quando citi Storia di una capinera di Verga, è che questo tuo cambiamento di lingua e di paese – l’autrice vive in Italia stabilmente ormai da quasi tre anni – sia in realtà una sorta di ritiro spirituale.
Io non sono religiosa, però sì, è vero, c’è una dimensione spirituale. Storia di una Capinera mi ha colpito molto, come anche un romanzo di Dacia Maraini basato sulla vita di Santa Chiara di Assisi (Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza, Rizzoli, 2013, ndr): mi ci sono ritrovata perché, anche lì, c’è l’idea di allontanarsi per poter raggiungere una parte più profonda dentro di sé, per vivere senza il peso del possesso – possedere una cultura, un’identità. O meglio, il desiderio di possesso rimane ma è diverso, è più profondo.
Sono iscritta a un sito dal quale ogni giorno ricevo per e-mail una nuova parola italiana. Questa mattina mi è capitata una parola che mi ha colpito molto: asintotico. [Prende il cellulare e mi legge la definizione: «Detto di ciò che tende ad avvicinarsi sempre più a qualche cosa senza mai raggiungerla o coincidere con essa». Sorrido perché mi stupisce sempre la modalità con cui certe parole acquisiscono un valore diverso per l’uno o per l’altro individuo]. Questa è la parola perfetta per me, definisce la mia condizione esistenziale, perché c’è tutto lo sforzo della mia giovinezza di diventare americana, di sentirmi accettata, normale. Questo sforzo enorme, alla fine, è rimasto un desiderio inappagato: rimango sempre sospesa e non mi è possibile tutt’oggi identificarmi con quella cultura. Con l’italiano è diverso, essendo una scelta mia, mi angoscia di meno, non c’è un’aspettativa che io diventi italiana, è impossibile, ed è altrettanto impossibile diventare una scrittrice italiana, perché non mi interessa. Quindi mi sono liberata della fantasia di potermi trasformare completamente.
Esilio, allontanamento, ritiro. Metamorfosi. Da scrittrice di successo in inglese ad apprendista in italiano: citi spesso Ovidio e ho letto che Le metamorfosi è uno dei libri che più ti hanno cambiato e ti hanno fatto riflettere.
Ho letto Le metamorfosi per la prima volta venticinque anni fa, in latino e ne sono rimasta ammaliata. Nel mio libro cito la storia di Dafne e Apollo, di come la ninfa si trasformi in albero per fuggire dal dio. Nel mio caso però la metamorfosi non è completa: posso scrivere in italiano ma non posso diventare una scrittrice italiana. Penso a Pessoa e alle quattro versioni di se stesso. Forse quello che sto facendo con l’italiano è simile a ciò che ha fatto lui: non posso diventare un’altra scrittrice, ma forse è possibile esserne due.
Ho scritto un discorso per una laurea che riceverò questo mese a Siena, in cui faccio riferimento al concetto di innesto: un processo, una creazione per far nascere una nuova varietà, un nuovo ramo, attraverso un inserimento. Trovo questa parola bellissima per riflettere sul viaggio linguistico che ho intrapreso.
[Le squilla il cellulare, si scusa, mi dice in fretta che potrebbe trattarsi dell’agenzia immobiliare, col marito stanno pensando di comprare casa a Roma. Un altro passo, dopo il trasferimento in Italia nell’estate del 2012, in pieno agosto. Le sorrido perché percepisco la sua emozione, il suo entusiasmo, benché contenuto. Mi viene in mente una frase di Pavese, altro autore a lei caro, decido di citarlo].
«Amare è desiderio di conoscenza». Il tuo desiderio di conoscenza dell’italiano ha, in effetti, alcuni tratti tipici del sentimento amoroso: il colpo di fulmine a Firenze nel 1994, la prima volta che arrivi in Italia; poi la relazione a distanze quando torni a New York, con le lezioni private; i ritorni e le delusioni, le ossessioni; infine questa sorta di amore materno, delicato e protettivo quando decidi di trasferirti definitivamente nel nostro paese.
Sì, c’è un’evoluzione in questo mio amore. All’inizio, nel 1994, ho provato un desiderio forte di ascoltare la lingua, provare a capirla; poi pian piano è venuto tutto il resto. Nel 2004, dieci anni dopo, ho iniziato ad approfondire, volevo imparare l’italiano almeno in modo elementare. Infine la terza fase, qui in Italia, in cui ho un incontro quotidiano con la lingua, un altro tipo di amore, meno romantico, perché fatto anche di delusione, di sofferenza, di giorni in cui niente va bene, faccio mille errori, mi sento frustrata. Sono venuta qua per avere un rapporto reale con la lingua e il paese. Senza una conoscenza della lingua tu non puoi comprendere un nuovo paese, una nuova cultura, resti sempre fuori, ai margini.
Inoltre, la cosa più interessante dell’italiano è che esiste principalmente in Italia, non si muove facilmente, non è come lo spagnolo o come l’inglese. La lingua italiana rappresenta veramente i suoi abitanti, ecco perché l’altro giorno un signore alla Dante Alighieri mi ha chiesto: «Ma perché ha deciso di studiare la nostra lingua?» Eppure non sentirai mai un americano dire: «Perché tu studi la nostra lingua?» Perché l’inglese è più in astratto, è una lingua ma non è necessariamente un’identità. Invece in Italia è così.
Prima il bengalese come lingua della famiglia, poi l’inglese come lingua matrigna, adesso l’italiano. Che cosa pensi che voglia dire appartenere a una lingua?
Me lo sono chiesto spesso e sinceramente non lo so. È una cosa che viene dall’eredità? Dal sangue? Dall’uso? Dall’amore? Ci sono tanti motivi per appartenere a una lingua. Inoltre la concezione che si può avere di essa è diversa per ogni persona. Mi ricordo di una signora che sempre alla Dante Alighieri insisteva a dire che la lingua madre ti coccola. Penso che questo in realtà sia una sorta di visione mitica: non sempre la lingua madre rappresenta un nido.
Io adesso mi sento radicata a Roma grazie ai legami che sono riuscita a creare e che mi portano completamente in un’altra direzione, per cui sono cambiata come persona. Il fatto di non appartenere a una cultura in particolare, né a quella indiana né a quella americana, sicuramente ha reso più facile questo cambiamento, anche se rimane un atto angosciante.
E in parte anche un atto di umiltà? In qualche modo rinunci all’autorità acquisita in una lingua che ti ha dato la notorietà.
C’è una nuova dipendenza in questo mio percorso: ogni cosa va controllata, corretta, riscritta e ricontrollata da una serie di persone. Mi sento sempre una studentessa e devo accettare questa condizione. Ma mi interessa molto il processo che si innesca: concepisco un testo, lo scrivo in italiano, faccio vedere questo testo a qualcuno, poi c’è un dialogo. Io scrivo in italiano per tanti motivi, ma il motivo principale è poter vedere tutti i miei errori, è proprio attraverso questa “impalcatura” che riesco ad approfondire maggiormente la mia scrittura. La dipendenza mi fa crescere, letteralmente. Ogni tanto penso: come mai faccio questa cosa? Soprattutto quando vedo un testo come questo [mi mostra dei fogli stampati con dei commenti a margine]: ci sono delle ingenuità, come, per esempio, «utilitari» al posto di «funzionali». Questi commenti mi servono per riflettere sulla lingua: qual è la differenza fra utilitario e funzionale? Attuando questo processo, entro in un’altra dimensione dell’apprendimento, più profonda.
E riguardo al tuo stile in italiano? Cosa rimane di te come scrittrice di lingua inglese?
Beckett diceva che la decisione di scrivere in francese gli derivava dal desiderio di liberarsi del proprio stile. In italiano in realtà io ho un altro stile, più semplice, meno grazioso, di cui però non sono consapevole. Non riesco a costruirlo, perché è come se fossi cieca, non riesco a cogliere l’effetto di quello che scrivo, devo rinunciare all’autorità che invece ho in inglese.
Guardare al proprio stile è un po’ come guardarsi in uno specchio: uno può uscire la mattina senza specchiarsi; oppure stare davanti allo specchio per dieci minuti e controllare il proprio aspetto prima di scendere in strada. In italiano scrivo “senza guardarmi allo specchio”, senza un momento per riflettere sullo stile: oggi ho messo questo, ieri un’altra cosa e il senso cambia di conseguenza. Ovviamente bisogna seguire delle regole: se fa freddo metto un cappotto, se fa caldo esco in camicia.
Adesso inoltre devo affrontare la traduzione di In altre parole e trovo la cosa molto interessante per via del confronto tra la voce della mia traduttrice e la voce del mio italiano tradotta in inglese. È una cosa incredibile scoprire una nuova voce dentro di sé.
Spengo il registratore. L’intervista è terminata. È quasi un’ora che siamo seduti al bar e io non me ne sono quasi accorto. Mentre usciamo, mi racconta del viaggio che farà in Sicilia con la famiglia, per le vacanze di Pasqua. Penso alle rovine che troverà laggiù. Ci salutiamo con una stretta di mano davanti al portone del Centro Studi Americani: lei scompare nella penombra del cortile, io mi avvio in direzione di Largo Argentina. Ripenso al portico d’Ottavia, alle rovine della Sicilia, a questo nostro paese che continua ad affascinare chi viene da lontano, nonostante si regga ormai solamente su eterne impalcature.