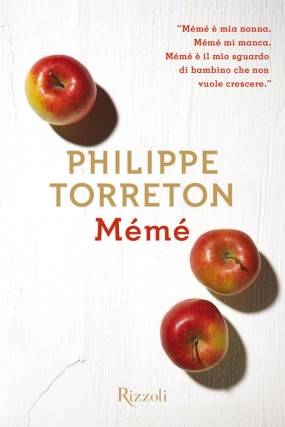Un bravo scrittore russo che ammira senza riserve un narratore e drammaturgo fra i più grandi della sua terra (e non solo). Bunin racconta Čechov, l’uomo soprattutto, di cui fu amico e discepolo attento e sensibilissimo. Come del resto lo era l’autore del Gabbiano, che diceva di esser freddo solo nell’esercizio artistico. Laddove la freddezza è possibile intenderla come un sacrosanto fastidio per certi modi posticci, leziosi in ciò che solitamente chiamiamo stile – lo si evince dalla lettura diretta delle sue opere e dalle note sparse nel volumetto dell’amico scrittore (e premio Nobel) ora tradotto da Adelphi, A proposito di Čechov.
La letteratura, per Čechov come per ogni vero scrittore, si misura con la verità che è in grado di sopportare – verrebbe da dire, avendo parafrasato Nietzsche, e contrariamente al cliché dell’inetto, che il solo Übermensch possibile sia lo scrittore nell’esercizio delle sue funzioni. Ma l’uomo Čechov era (e le pagine di Bunin che radunano ricordi privati, riflessioni letterarie e commenti a narrazioni altrui – vedremo: sorprendenti – non lo smentiscono) l’opposto di un esagitato Zaratustra, afflitto piuttosto da una «congenita malinconia» (addirittura i compagni di scuola lo consideravano «un tontolone»), ma forte abbastanza da ritenere irrinunciabili alcuni modesti ma sani proponimenti come quello di «non umiliarsi allo scopo di suscitare la compassione altrui». Gli studi di medicina e la saltuaria professione di medico, secondo Bunin, aiutarono Čechov a rafforzarne il carattere e a comprendere gli esseri umani. Il bambino era già peraltro sopravvissuto a un padre manesco e a una miseria sempre incombente, sicché poi l’uomo si dimostrò sufficientemente forte nel sostenere prima – e molto presto – la famiglia, e più tardi ancora il peso di una malattia invalidante che non gli impedì di sottoporsi a una dura disciplina: lavoro, lavoro, lavoro. Čechov mostra al riguardo la ferma determinazione dei grandi. «Se si ha un qualche talento, allora lo si coltivi, sacrificandogli ogni altra cosa». Lo scrittore non deve mai smettere di scrivere (ma aggiungeva che il «sacro fuoco» dell’arte in lui ardeva sempre sì ma un po’ svogliato, «senza fiammate e crepitii»). Un po’ lo pensava anche Bunin che mise insieme questi frammenti poco prima di morire; viste le precarie condizioni di salute, si fece aiutare dalla moglie. Čechov era morto da quasi mezzo secolo e se la memoria di Bunin funzionava abbastanza da ricordare conversazioni più o meno intime, momenti mesti o slanci di buonumore, non di poco rilievo per scrivere il libro – pubblicato postumo – fu il soccorso che ricevette dalla lettura dell’epistolario del grande maestro. Per intensa che fosse, la loro amicizia restò sufficientemente discreta perché il capitolo del grande amore impossibile per la scrittrice Lidija Avilova lo cogliesse di sorpresa. Bunin ne viene a conoscenza leggendo le memorie della donna – la meraviglia lo spinge ad affrontare questa prova anche per dare il giusto peso all’uno e all’altro, a mezzo secolo dagli eventi. E a far vivere per i lettori una storia d’amore molto vagheggiata, tanto clandestina quanto impensabile.
(Ivan Bunin, A proposito di Čechov, trad. di Claudia Zonghetti, Adelphi, pp. 223, euro 14)