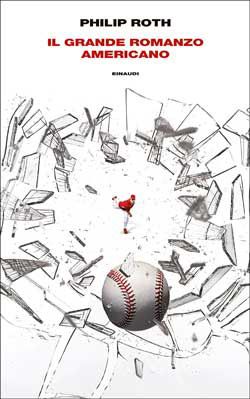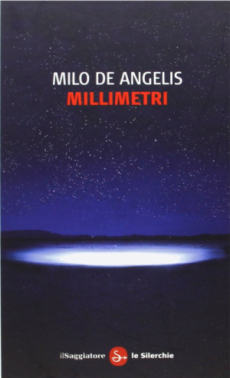Einaudi ripubblica, con la nuova traduzione a cura di Vincenzo Mantovani nella collana Supercoralli, Il Grande Romanzo Americano di Philip Roth, opera del 1973.
Parlare di cos’è il Grande Romanzo Americano attraverso lo sport che universalmente definisce la storia e la cultura degli Stati Uniti: il baseball. Nel 1952 Bernard Malamud scrive Il migliore, dove il baseball è il destino perennemente avverso attraverso la storia di Roy Hobbes, uno che ha tutte le caratteristiche per diventare il miglior giocatore di sempre, ma che non ce la farà. Per Paul Auster, in Sunset Park, è l’eredità culturale che viene tramandata da padre a figlio. In Underworld di Don DeLillo, la pallina lanciata durante la leggendaria partita tra i Giants e Dodgers, nel fuoricampo che darà la vittoria ai Giants, e che finisce nelle mani di Martin Cotter, sarà il filo conduttore di quello che probabilmente è uno dei più importanti romanzi del dopoguerra: passerà di mano in mano, sarà venduta, persa, comprata. Ma anche Fante o Kinsella useranno il baseball come pretesto. Lo stesso Roth, con il suo “svedese” Saymour Levov, anni dopo, nel 1997, se ne riapproprierà.
È chiaro che questo sport ha un significato così profondo per quello che rappresenta l’esistenza, il senso, l’immagine stessa degli americani, che fare un raffronto con qualcosa che ci è più familiare può sembrare scontato. Qui in Italia è e sarebbe il calcio a essere raccontato e a raccontare la storia e la cultura, ma in maniera comunque differente: salvo rare eccezioni – come Le cinque poesie sul gioco del calcio di Umberto Saba, il quale comunque si approccia a questo sport in maniera piuttosto casuale, oppure Pasolini, che vedeva il calcio come ultima rappresentazione sacra della nostra società. Negli Stati Uniti lo sport fa parte degli aspetti più intimi della cultura, in maniera trasversale, fino a rientrare nella letteratura stessa – cambiando sport, basti pensare al peso specifico del tennis in Infinite Jest di David Foster Wallace.
Se a questo, poi, aggiungiamo un gigantesco complotto comunista, delle chiacchierate con Ernest Hemingway e che a scriverlo è uno degli autori contemporanei più importanti, ecco che Il grande romanzo americano non sarà il più grande romanzo americano di sempre, ma probabilmente il più grande romanzo in cui si parla del Grande Romanzo Americano. E bastano solo le prime due parole del libro per capire con cosa abbiamo a che fare: «Chiamatemi Smitty» rimanda immediatamente al «Chiamatemi Ishmael» di Herman Melville nell’incipit di Moby Dick.
Word Smith è un ottantenne ex cronista sportivo e grande amante dell’allitterazione e della parola in generale (la scelta del nome non è casuale: wordsmith può essere tradotto come “cesellatore di parole”), cosa che gli ha permesso di scrivere i discorsi di quattro Presidenti degli Stati Uniti, convinto di essere l’unico a ricordarsi della Patriot League, terza lega americana dopo l’American e la Nation, che secondo il suo parere è stata cancellata dalla memoria e dagli annali perché diventata apertamente un’organizzazione anti-americana, cosa che lo farà sembrare pazzo alla Hall Of Fame di Cooperstown quando ne parlerà.
L’ex cronista sportivo decide così di scrivere l’ultimo anno dell’esistenza della Lega attraverso la storia dei Mundys di Port Ruppert, ai quali, nel 1943 viene tolta la possibilità di giocare in casa: il loro campo, infatti, è stato concesso all’esercito come base per le truppe che si accingono a salpare verso l’Europa.
I Mundys sono una squadra sgangherata, piena di senza tetto, con un battitore senza un braccio, ubriaconi, giocatori nani, animata dall’unico giocatore che abbia mai provato ad uccidere l’arbitro. Accompagnati da Word Smith e costretti a giocare sempre in trasferta – aspetto che delinea un’altra grande caratteristica del mito americano, quella degli americani come grande popolo di migranti , i Mundys, in questo continuo peregrinare, vengono usati da Roth per descrivere le grandi psicosi, le follie, le esagerazioni degli Stati Uniti, ma soprattutto la grande ansia di trovare il Grande Romanzo Americano, e il Grande Romanziere Americano, che possa marchiare a fuoco sulla pelle della storia la cultura di un popolo in perenne ricerca di sé.
(Philip Roth, Il Grande Romanzo Americano, trad. di Vincenzo Mantovani, Einaudi, pp. 418, euro 21)