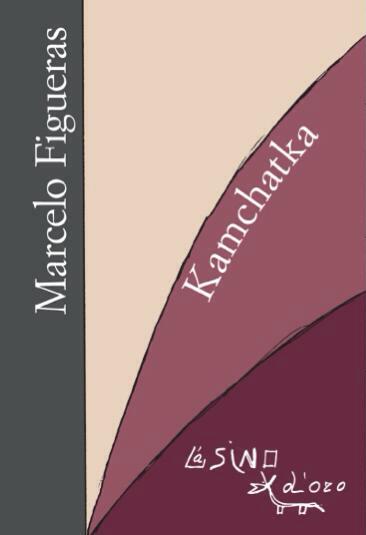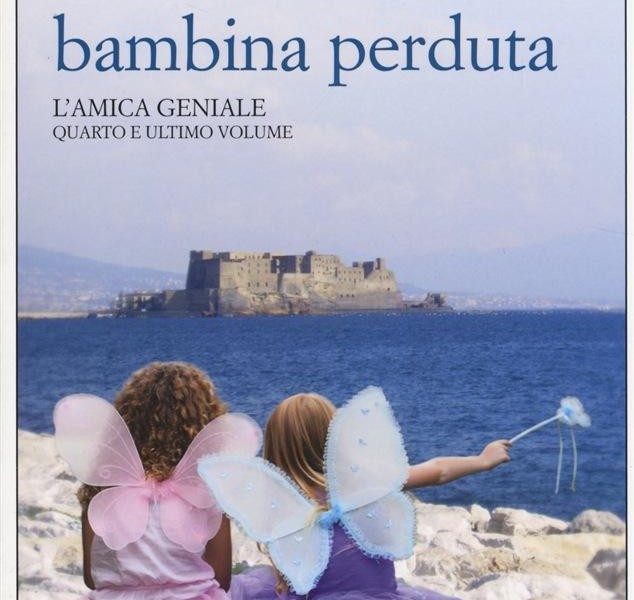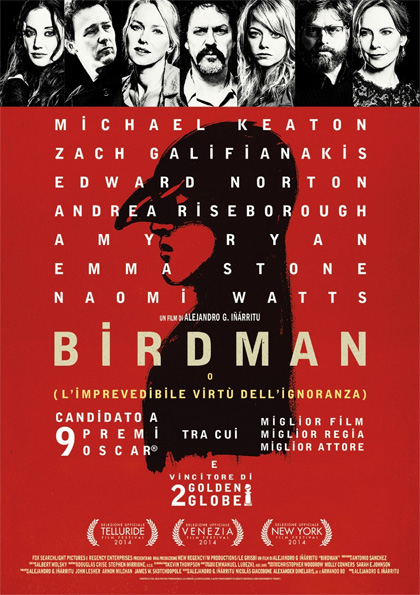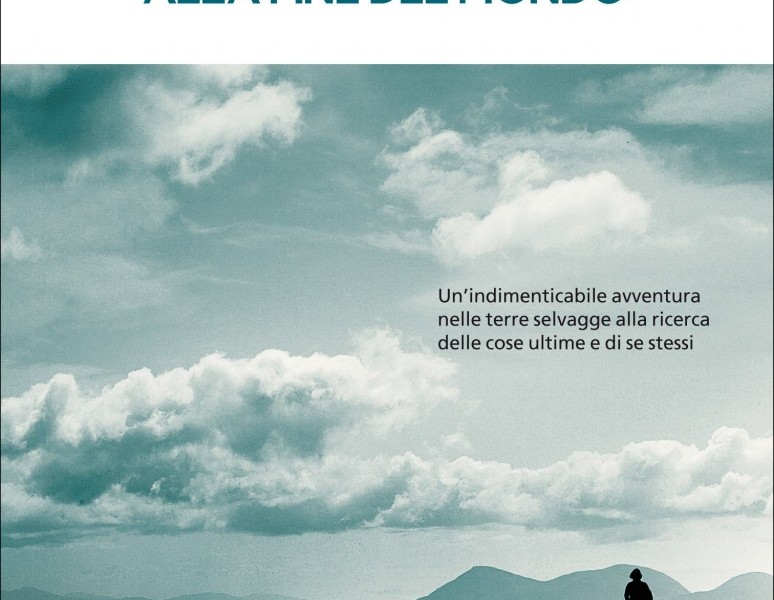Non solo ponte tra la grande letteratura americana e l’Italia ma anche testimone e animatrice dei fermenti culturali del secolo scorso.
Fernanda Pivano è un mondo che si squaderna davanti ai nostri occhi per abbracciare tutte le discipline creative dell’umano talento fino a toccare le più remote plaghe: dall’arte alla musica, dal giornalismo alla scienza, dall’architettura alla società, dalla letteratura al cinema, la danza e il teatro.
Medaglioni (Skira, 2014) è un viaggio spazio-temporale attraverso i ritratti di vite descritte con pennellate d’acquerello, ma per nulla sbiadite, di illustri personalità del Novecento.
Giudizi in presa diretta, pareri insofferenti alla prudente cerimonia, aneddoti ironici, pettegolezzi e divertissement animano il gran teatro della lettura di questo libricino.
Leggendo Medaglioni, ho pensato che avrei voluto essere quel lapis rosso brillante dal tratto morbido che Fernanda Pivano all’Hotel du Cap di Saint-Tropez donò a Pablo Picasso per firmare autografi e stupirmi del contrasto stridente fra la grandezza dell’artista, icona della pittura moderna, e il suo dimesso e grottesco aspetto fisico: «un uomo basso e tarchiato, vestito in calzoni da marinaio e casacca a fiorellini degni di Musset».
O magari avrei voluto essere la protagonista di un fumetto di Andrea Pazienza, «precoce interprete di un mondo acido e sballato» degli anni Sessanta di cui ha interpretato «l’anima carnevalesca, poetica, dissacrante», il «James Joyce del fumetto», come lo definì Tondelli.
Ma forse ancora di più mi sarebbe piaciuto venire servita con mandorle al burro e ciliegie arrosto dal cameriere giapponese di Peggy Guggenheim per poter anche io con Fernanda provare quel «sollievo ora e sempre ogni volta che uscivo per qualche minuto dalle insidie del nostro terribile provincialismo italiano» e venir dilettata dallo humour della famosa mecenate e collezionista d’arte, «immortale dea dell’art painting e dell’espressionismo astratto dell’inafferrabile Jackson Pollock, protagonista degli amori di Samuel Beckett e di Marcel Duchamp, regina per sempre dello charme senza confini di Max Ernst», il pittore e scultore dagli occhi «più belli della storia della pittura contemporanea».
Poi ho pensato che avrei voluto confondermi tra il pubblico dei concerti, mostre e conferenze che, nella Torino degli anni Quaranta, immancabilmente presenziava Felice Casorati e riconoscere quel «sorriso cordiale» che Dondolo, questo il suo soprannome «per via del’atteggiamento che Casorati assume davanti a un quadro da giudicare», dispensava a tutti e venire impressionata, come la ragazzina Fernanda, dai suoi stivali oppure mimetizzarmi fra i suoi allievi perché «era chic potersi incontrare con lui per cinque minuti».
Avrei voluto poi intrufolarmi nello studio di via Margutta a Roma del pittore Renato Guttuso «pieno di ragnatele e quadri incominciati» o magari fra gli invitati delle favolose feste dello scrittore e fotografo americano Carl Van Vechten nella New York degli anni Venti, lasciandomi affascinare dalle decorazioni esoteriche in chiave esotica alle pareti e abbacinare dalle «vetrine illuminate soltanto nell’interno che contenevano maschere teatrali cinesi o scarpini da ballo thailandesi».
Fernanda Pivano serve fette di vita, vive storie essendo geograficamente sempre da un’altra parte. Incontri memorabili da Michail Gorbacëv a Marlon Brando, da Moravia, «violentissimo nella sua irruenza», a Carla Fracci, da Renzo Piano, «grande maestro contemporaneo di arte e vita» a Giovanni Agnelli.
Infine ho riflettuto che non basterebbe una vita per ripercorrere tutti i territori dell’arte, la scienza e la società esplorati da Fernanda Pivano e mi sono detta che, sì, anche io avrei voluto essere Fernanda Pivano.
(Fernanda Pivano, Medaglioni, a cura di Enrico Rotelli, Skira, 2014, pp. 160, euro 15,50)