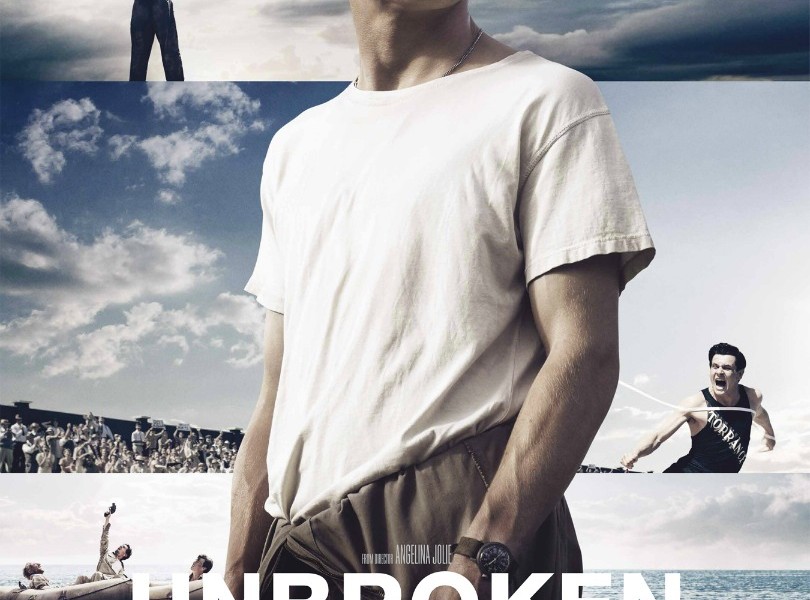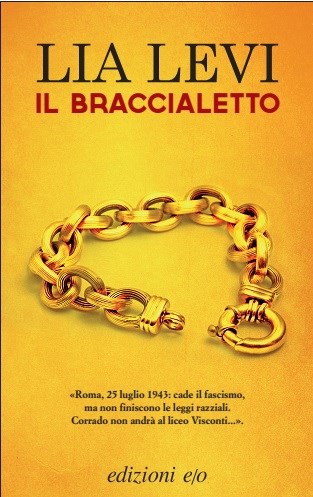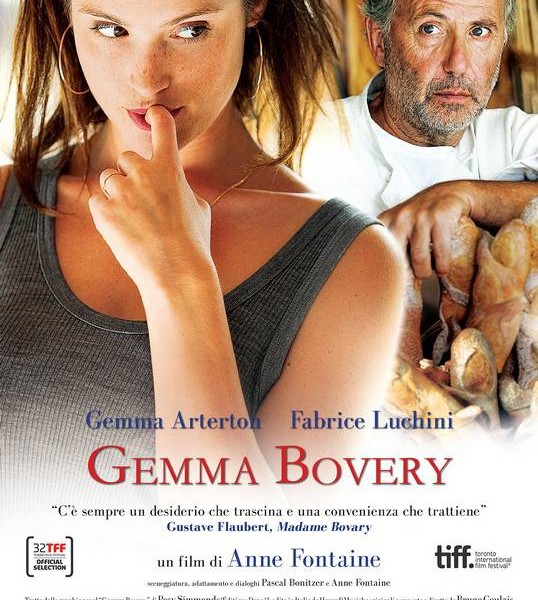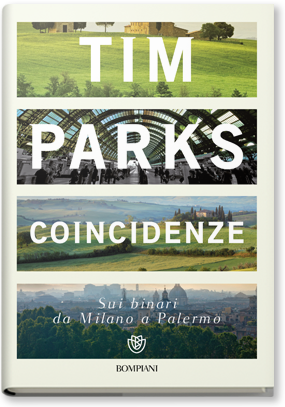Non sono avvezza alle scommesse; diciamo che in tanti anni non ci siamo mai sedotte.
Le lascio sempre pencolare per qualche altra mano, più rapace, più furtiva, meno intenta a soppesare.
Eppure stavolta ho l’impulso sbilanciato, pronto a proclamare che il libro impigliato in questo articolo sia tra i migliori del 2015. E scriverlo a febbraio trasuda un po’ d’azzardo. Quindi vale la pena dell’impronta.
Titolo vagamente veterotestamentario: Le dodici tribù di Hattie (Einaudi, 2015), dell’esordiente trentanovenne Ayana Mathis. Strampalata fila indiana quella occhieggiante in copertina; un cordone di altezze e di passi che sguscia sul retro e impalma ogni lato del volume.
Hattie è la Madre della Storia e il motore del suo “popolo”. Una stirpe di capitoli e di figli snocciolati lungo sessant’anni di vita americana. Arriva a Philadelphia nel 1923 Hattie, ed è leggera come un arbusto, ma ci pensa lo stupore ad ancorarla al suolo. Stranamente in quella città la sua pelle non graffia come in Georgia, i marciapiedi non sputano sulle sue scarpe e non s’inclinano per disarcionarla tra i grugniti della strada.
A Philadelphia Hattie e sua sorella non sono poi così negre.
Sembra un altro mondo, ma i suoi quindici anni durano poco. Lei è bella, come una donna con più stagioni in tasca e August la agguanta senza troppe attese. Basta un po’ di sudore e le riempie pancia di due gemelli fragili. L’inverno è iniquo lì al nord e quei minuscoli polmoni si sfarinano sotto le sue preghiere.
I piccoli le muoiono addosso, cosparsi di lacrime e rimedi di senape. Da quel giorno Hattie non sarà più la stessa e a raccontarla ci pensano i suoi figli.
Ognuno di loro è un soggetto narrante, uno scorcio da cui osservare la grande madre, la sua forza distante e inconoscibile. Hattie viene scrutata da dieci sguardi diversi (i nove figli sopravvissuti e la nipote Sala) eppure resta sempre un oggetto misterioso. Viso fiero, neanche un granello di dolcezza, schiaffi e fatica per farli crescere bene. Orgogliosa e severa, incapace di sorridere. Ma d’altronde: «Hattie sapeva che i suoi figli non la consideravano una donna buona – forse non lo era, ma quando erano piccoli non c’era stato tempo per i sentimenti. Aveva negato loro qualcosa di vitale, ma che bene poteva fargli passare le giornate a dare baci e abbracci, se non c’era niente con cui riempirgli lo stomaco? Non capivano che tutto l’amore che aveva dentro era servito a sfamarli, vestirli e prepararli ad affrontare il mondo. E il mondo non li avrebbe amati; il mondo non sarebbe stato buono».
Non è facile il suo pianeta. Di madre prematura, moglie costretta, amante sfortunata. E la scuola della durezza è l’unica in cui possa insegnare.
I suoi figli sono un impegno continuo, uno sciame di vita che non può controllare e il dono di Ayana Mathis è di trattare ogni capitolo come un romanzo autarchico, un sistema d’incontri e relazioni. Perfettamente autonomo eppure interconnesso.
Hattie resta il denominatore comune delle loro lingue; li attrae e li atterrisce. È l’esempio da cui si sentono braccati, perché da August hanno incassato solo qualche canzone per addormentarli e ben poche certezze nel salvadanaio.
Quello stesso sangue si declina ogni volta naturalmente in modo sempre unico. Ciascun membro della tribù ha un suo puntuale colore di voce e di cuore. Ognuno ha un fantasma con cui convivere: Floyd e la vergogna di amare altri uomini, Cassie e la pazzia che la umilia davanti a sua figlia, Franklin e il suo matrimonio lasciato marcire lontano da lui, Bell e la solitudine che la sfianca sul letto più della tubercolosi.
La povertà è una compagna costante per quella famiglia, bussa ogni giorno più spesso dell’alba, ma non sa sfregiarne la dignità. Hattie la porta cucita nel petto, negli occhi impietosi, nell’asprezza del suo mestiere.
Nel cielo di donna che inghiotte e sopporta e la cui ribellione è destinata ad appassire tra due sbuffi di pentole. C’è l’America del profondo Sud a invecchiare con lei, quel ventre diffidente da cui non si è mai staccata e che le pulserà dentro come un richiamo.
La sua storia è quella di chi combatte al margine, perché almeno a quello può appigliarsi per resistere. E da vicino quel microcosmo straborda di colori; un incarnato non è più ugualmente scuro, ma diventa cannella o caramello o addirittura mandorla e l’intero ecosistema afroamericano è un pentagramma di carne e battaglie innominate che si spostano dal fondo e conquistano la scena.
Facile rintracciare l’eco del Premio Nobel Tony Morrison, di Kathryn Stockett nel suo celebre The Help o di Andrew Sean Greer nell’incantevole opera La storia di un matrimonio.
Ma è più facile ancora arrendersi al romanzo, marciare dietro Hattie. Diventare la tredicesima tribù.
D’altra parte la mia scommessa è sempre valida. Ne riparliamo a dicembre.
(Ayana Mathis, Le dodici tribù di Hattie, trad. di Giovanna Scocchera, Einaudi, 2015, pp. 290, euro 21)