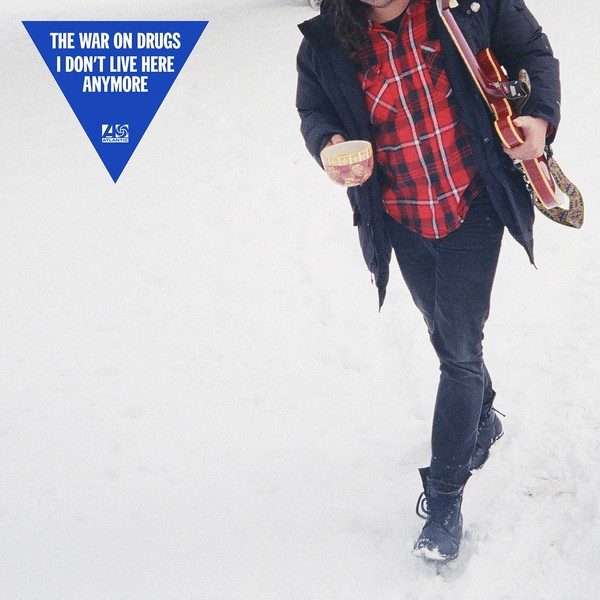Nelle numerose indagini circa l’origine, il significato e la distribuzione delle fiabe popolari sono state adottate di volta in volta prospettive diverse, corrispondenti a specifici indirizzi disciplinari (mitologico, antropologico, psicanalitico, semiologico, storico-geografico). Il denominatore comune di tutti questi studi risiede nel concetto di repertorio fiabesco, per cui ogni fiaba sarebbe costituita da unità semantiche minime e costanti in continua circolazione.
Con il proposito di rintracciare la forma prima di tali elementi minimi, la scuola storico-geografica (o “finnica”) ha lavorato a una classificazione sistematica del folklore favolistico-fiabesco, come illustrato da Stith Thompson ne La fiaba nella tradizione popolare (Il Saggiatore, 1967). Alla base di questo progetto tassonomico giace la distinzione tra il “tipo” di una fiaba, il racconto completo e autonomo, composto da uno o più motivi la cui combinazione risulta grossomodo immutabile (ad esempio, il tipo della volpe, o del gatto, che si finge morta) e il “motivo”, l’elemento più piccolo di una fiaba, riguardante un personaggio, un oggetto, un’idea oppure un singolo episodio che contribuisce alla progressione narrativa (come ad esempio il motivo di Belfagor, il diavolo spaventato da una moglie bisbetica).
La trasformazione delle fiabe
Nel passaggio da una forma a un’altra o nell’ambito dei vari rifacimenti letterari gli elementi fiabeschi possono subire una serie di alterazioni, più o meno stabili, che Vladimir Propp descrive, riferendosi però a una sola particolare tipologia di fiaba, ne La trasformazione delle favole di magia del 1928. Tali modificazioni rispondono ai fenomeni di abbreviazione (se cioè la forma originaria viene ridotta o se dal suo insieme viene estrapolata una sola componente); amplificazione (quando il testo base viene ampliato e arricchito di particolari); deterioramento (qualora la base originaria sia privata del suo solito referente semantico); processualità (nel caso di intensificazioni o attenuazioni nelle azioni compiute dai personaggi della fiaba di partenza); sostituzioni o assimilazioni di vario tipo (storico, religioso o squisitamente letterario).
Il concilio infernale, la moglie bisbetica e il contadino astuto
Uno dei casi più esemplificativi riguardo ai concetti di repertorio e di modificazione degli elementi fiabeschi è costituito dalla Favola di Belfagor di Niccolò Machiavelli, pubblicata postuma a Firenze nel 1549. L’intreccio della storia ruota attorno alle peripezie dell’arcidiavolo Belfagor, il quale, in seguito alla delibera dell’assemblea dei demoni infernali presieduta da Plutone, è inviato sulla terra munito di centomila ducati per la durata di dieci anni, allo scopo di verificare la condizione degli uomini sposati; proprio a causa della moglie, tuttavia, egli finisce vittima degli usurai e per salvarsi, fuggito dal tetto coniugale, stringe un patto con un contadino che dopo essersi spacciato per esorcista lo sconfigge in astuzia, costringendolo a fare rientro nell’Ade.
È utile, di nuovo a proposito di unità semantiche minime e variazioni testuali, considerare che l’impianto narrativo di questo testo novellistico (i cui precedenti sono stati individuati e ampliamente discussi dalla critica) si struttura sulla successione di più motivi che, quantunque tradizionali, vengono modificati (anzi, spesso attualizzati) dall’autore con puntuali riferimenti alla storia politico-sociale fiorentina.

Il primo motivo, di eco mitologica, rappresenta l’episodio introduttivo del concilio dei diavoli (speculare al tradizionale concilio degli dei superi), chiamati a giudicare la veridicità dell’accusa mossa dalle anime dannate che attribuiscono alle mogli la responsabilità della propria sorte infernale. Plutone, loro sovrano, presiede il consiglio sostenendo che, affinché il regno sia ben amministrato e tenuto in buona considerazione, il potere assoluto del capo deve sottomettersi alle leggi e quando necessario interloquire con gli altri dignitari (N. Machiavelli, Favola di Belfagor, a cura di P. Stoppelli, Mondadori, 2021, p. 5, corsivo mio):
«Ancora che io, dilettissimi miei, per celeste disposizione e fatale sorte al tutto irrevocabile possegga questo regno, e che per questo io non possa essere obligato ad alcuno iudicio o celeste o mondano, nondimeno, perché gli è maggiore prudenza di quelli che possono più sottomettersi più alle leggi e più stimare l’altrui iudizio, ho deliberato essere consigliato da voi come in uno caso, il quale potrebbe seguire con qualche infamia del nostro imperio, io mi debba governare».
In una tale drammatizzazione del consesso infernale, cui concorre anche il lessico adottato, spicca pertanto l’immagine di Plutone quale principe perfetto di un regno ideale, democratico e non dispotico, la cui rappresentazione determina un ribaltamento del normale sistema assiologico.
La progressione narrativa (Belfagor arcidiavolo inviato sulla terra, nei panni di Roderigo di Castiglia, per verificare la credibilità della suddetta accusa) si sviluppa invece attorno al motivo del demonio che sperimenta la cattiva natura delle donne. L’argomento è conforme ai moduli tipici della tradizione antifemminile e antiuxoria; il nucleo fondamentale di questo episodio corrisponde pertanto al tipo della moglie bisbetica, frequente nella favolistica ma anche in altri generi letterari ‒ valga il celeberrimo esempio offerto dal teatro shakespeariano.
La riproposizione del motivo misogino nella Favola passa però attraverso il parallelo contrastivo tra la superba e insolente moglie di Belfagor, Onesta, e il «bellissimo, umano, liberale» (p. 9) Roderigo, il quale ha eletto Firenze, «atta a sopportare chi con arti usurarie esercitasse i suoi danari» (p. 8), la città più idonea all’impiantarsi di un diavolo sulla terra. Quando pertanto allo spessore psicologico aggiunto del protagonista (non più raffigurato in termini tipologici, come la tradizione prescrive, bensì caratterizzato dalla policromia dei sentimenti che ne motivano scelte e comportamenti) si contrappone il prototipo della cattiva moglie, esso non ricorre in ossequio al convenzionale motivo antiuxorio; al contrario, la descrizione di Onesta mira a individuare nella donna una rappresentante di quella città contro la quale Machiavelli vibra una mordace polemica socio-economica, valida anche rafforzare il capovolgimento assiologico della sequenza iniziale: all’Ade “repubblicano” corrisponde infatti una Firenze “infernale”.

Il terzo motivo, di matrice medievale, riproduce l’accordo stipulato tra il demonio e l’uomo (tradizionalmente un medico) che vestirà i panni dell’esorcista: il contadino Gianmatteo del Brica, infatti, accetta per denaro di nascondere Roderigo dagli usurai che lo inseguono oltre i confini fiorentini. In cambio, Belfagor si impossesserà di due donne perché il contadino possa esigere un compenso per esorcizzarle.
L’originale identificazione del ruolo dell’esorcista con il personaggio del villano sembra essere un’innovazione se non prettamente machiavelliana, quantomeno fiorentina (recenti studi ipotizzano infatti la presenza di una comune fonte fiorentina, oggi perduta, per la Favola di Machiavelli e per quella di Giovanni Brevio); la grande novità apportata in questa parte della storia afferisce però alla caratterizzazione dei personaggi e si evince dalla rappresentazione del terzo impossessamento demoniaco: quando infatti Gianmatteo, chiamato alla corte francese dal re Ludovico VII, fallisce nel tentativo di persuadere Belfagor ad abbandonare il corpo della principessa, nella logica narrativa della Favola il deciso rifiuto del diavolo non viene ricondotto, come di consueto, alla sua proverbiale slealtà ma, anzi, al suo rispetto della parola data: il debito da lui contratto con il contadino è infatti già stato saldato con quanto guadagnato tramite i due precedenti esorcismi ed egli non ha più nulla a pretendere dal demonio.
L’espediente adottato dal contadino per vincere sul demonio (convincerlo cioè che sua moglie sia in procinto di raggiungerlo in modo da indurlo immediatamente alla fuga), infine, non mira a rimarcare la carica antiuxoria, bensì a confermare il capovolgimento assiologico iniziale (M. Picone, Lettura intertestuale, Carocci, 1998, p. 190):
«Contro la malvagità della moglie e l’astuzia del contadino, […] Belfagor, anche quando fa il diavolo e non l’uomo, è un perdente. È questa in fondo la morale tutta terrena che Machiavelli ricava dalla sua Favola: una morale che si addice perfettamente alla tesi ironica di un mondo alla rovescia, secondo cui l’inferno è sulla terra e il vero diavolo è l’uomo».
Questa versione di “Belfagor arcidiavolo” costituisce nel suo complesso un unicum della letteratura favolistica; rientrata nel circuito folklorico, la favola subisce infatti una generale semplificazione di intreccio, personaggi e morale, visibile già solo nel finale appiattito sulla cifra antiuxoria. È il Diavolozoppo raccolto da Calvino nelle Fiabe italiane (Mondadori, 2020, p.752):
«Il diavolo compare andò alla finestra. ‒ Oh! Arriva vostra moglie!
‒ Mia moglie! ‒ fece Diavolozoppo. ‒ Mia moglie! Ma io scappo! Io scappo subito! Io non ne voglio sentire neanche l’odore! […]
Diavolozoppo scappò via e la Reginetta all’istante si sentì guarita.
‒ Bravo! ‒ fece il Re, ‒ la mano [della Reginetta] e la corona sono vostre.
E così cominciarono i guai per il diavolo compare».
***
Nel testo, la raffigurazione di Belfagor, diciassettesimo demone del Dictionnaire Infernal (Parigi, 1818) di Jacques Auguste Simon Collin de Plancy e le riproduzioni de Il concilio degli dei (1517-18) di Raffaello e bottega e di Watercolour of Katherine and Petruchio. The Taming of the Shrew by Shakespeare (1890 c.) di James Dromgole Linton.