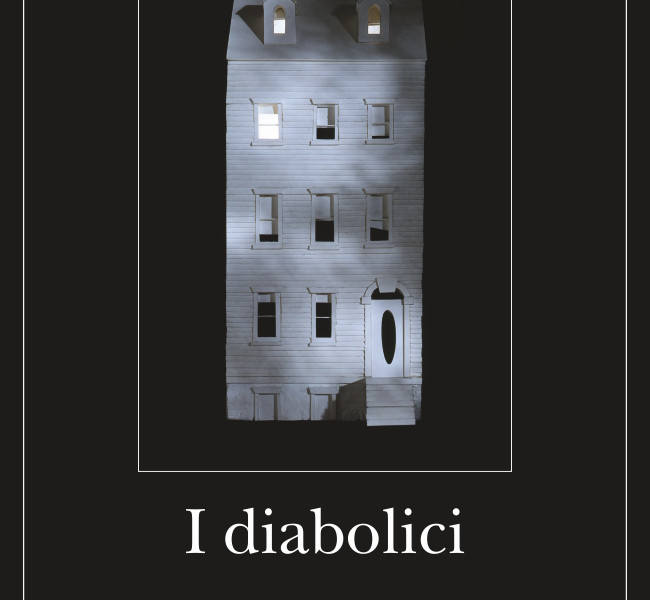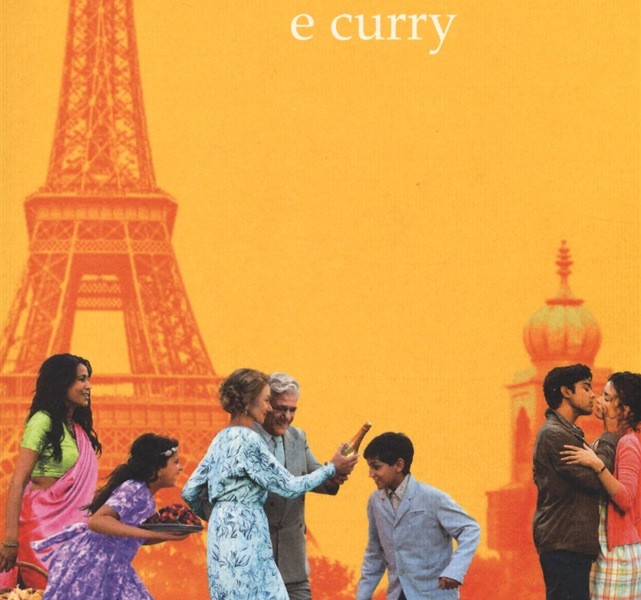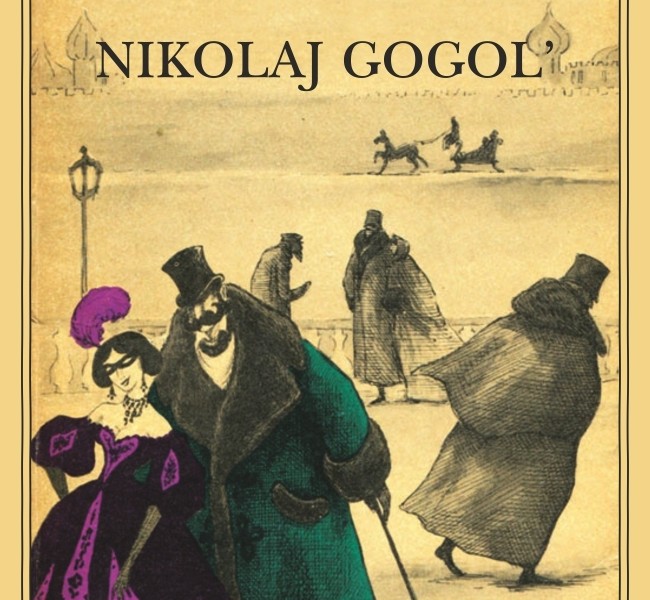Dezső Kosztolányi per chi scrive è stata una piacevole sorpresa.
Non lo avevo mai letto prima, sebbene in Italia circolassero da tempo traduzioni da diversi suoi libri. Si tratta di un poeta e narratore ungherese la cui vita è stata incastonata in un periodo (1885 – 1936) fra i più straordinari della letteratura europea. Nel romanzo Anna Édes (1926) ora tradotto da Anfora edizioni, sembra riassumerne alcuni temi decisivi: il crollo della vecchia borghesia mitteleuropea, la crepa rovinosa che si apre nel suo snobismo classista, la torbida pulsione erotica che ne scuote le fondamenta, l’intreccio fra preziosismo estetico (non ultima, la pretenziosità degli arredamenti privati che il bolscevismo pensava di smantellare) e un’insana, polverosa inquietudine verso l’esterno. Ma quel che più conta, per chi sa qualcosa della straordinaria narrazione culturale costruita intorno al Danubio, di finis Austriae e dintorni, il piano sociologico è interessante perché scivola ineluttabilmente verso quello esistenziale – e l’esito, feroce quanto inatteso del romanzo, lo conferma.
Nella casa di una famiglia benestante della Budapest del primo dopoguerra finisce Anna, una povera serva, timida e taciturna (per inclinazione personale e legge non scritta dei padroni). È costretta a vedersela con un funzionario ministeriale ligio al dovere, nemico dichiarato dei comunisti, e soprattutto con una donna francamente insopportabile, la di lui moglie, la cui vita, fatta eccezione per la parentesi di qualche ora passata in stato d’arresto come sospetta controrivoluzionaria (stava scrollando la tovaglia nel balcone e il gesto venne interpretato come un segnale per i suoi presunti complici) sembra concentrarsi nella ricerca di una domestica come si deve. Ai Vizy difatti nessuna sembra mai all’altezza della situazione – gli amici intanto tengono a sottolineare che andrebbero chiamate serve e basta, ché quella è la loro “natura” e che il mondo è sempre stato diviso fra servi e padroni, alla faccia del comunismo che per un breve lasso di tempo si era illuso di approfittare dello sfascio dell’Impero – asburgico – per prendere il potere nella città. La signora Vizy sottopone Anna a tutte le prove possibili, crea persino le condizioni perché ceda alla tentazione di rubare nella loro casa, ma niente, Anna è irreprensibile. Di sicuro poi è l’ultima a cui parrebbe venire in mente di concedere facilmente le proprie grazie con facilità a chiunque.
La tensione anche immotivata ma persistente in una casa di benestanti che non sanno però godere della loro condizione (specie la moglie), timorosi come sono, comunismo o meno, di perdere il loro status, proprio nel momento in cui sembra placarsi perché Anna dopo l’avvio farraginoso s’impone come la serva perfetta da sempre agognata, finisce per esplodere perché Anna serva perfetta lo è davvero, almeno se consideriamo perfetto un cliché: un giovane parente, estroso e malandrino quanto basta, prova a portarsela a letto e la ragazza, a dispetto della sua ritrosia e discrezione, sembra proprio non aspettare altro – che serva perfetta sarebbe sennò? Di lì si giunge a un esito che non riveliamo, degno però di un romanzo straniante che ci spalanca davanti l’abisso dell’irrazionale fin troppo noto al Novecento.
Un libro ben costruito, tragico ma ricco di tratti grotteschi; e di sicura abilità descrittiva. I personaggi hanno una riconoscibile cifra espressiva. Funzionano i dialoghi, ben calibrati nel contesto; l’ambientazione è ricca (senza essere prolissa) di dettagli che restituiscono bene il clima della casa (unità di luogo della vicenda). Una bella scoperta, che dobbiamo alla cura e alla traduzione di Mónika Szilágyi e Andrea Rényi.
(Dezső Kosztolányi, Anna Édes, a cura di Mónika Szilágyi, trad. di Andrea Rényi, Anfora edizioni, 2014, pp. 200, euro 15)