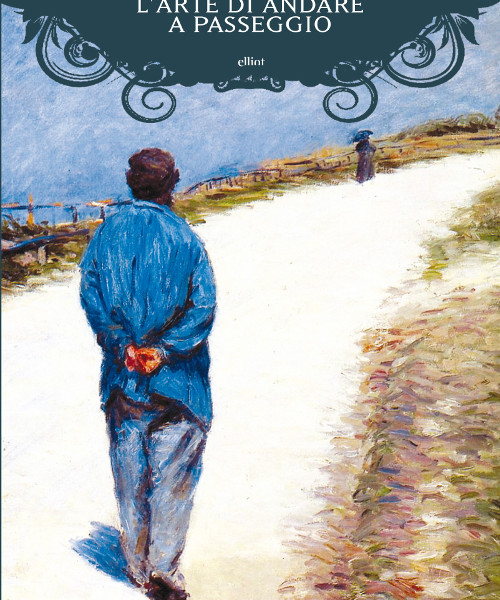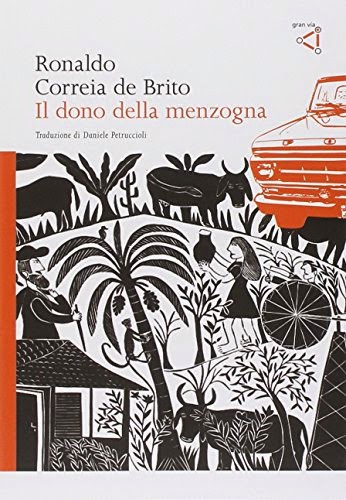Siamo arrivati al capitolo finale della saga di Hunger Games. O meglio, alla prima parte del capitolo finale, di quel Canto della rivolta che si inizia a levare su Capitol City e che porterà alla guerra tra i dodici distretti e il governo del presidente Snow.
Dopo essere sopravvissuta alla settentacinquesima edizione dei giochi, quella speciale, celebrativa dei grandi vincitori, Katniss Everdeen ha scoperto l’esistenza di un movimento di ribellione contro Capitol City che ha la propria sede nel Distretto tredici che tutti credevano distrutto. Esiste ancora, solo che è costruito sotto terra per nascondersi agli occhi del governo. È lì che la ribellione si organizza e si arma. Katniss è chiamata a diventare la ghiandaia imitatrice, l’uccello di cui porta la spilla in grado di replicare e diffondere all’infinito ogni suono che sente, per incendiare gli animi degli abitanti dei distretti contro la capitale e ribaltare finalmente Snow. Solo che Katniss ha il cuore e la mente occupati da Peeta, da cui si è separata nel convulso epilogo degli ultimi giochi e che vede riapparire in televisione come portavoce del governo per un immediato cessate il fuoco dei ribelli.
Bisognerebbe fare qualcosa per bloccare la deriva che sta prendendo il cinema negli ultimi anni. Va fatto un distinguo, essenziale: le serie tv sono una cosa, i film un’altra. Il concetto di cliffhanger – la creazione di una tensione narrativa che culmina nell’attesa di uno sviluppo in un momento successivo – è stato radicalizzato sempre di più fino a diventare insopportabile. Ormai, dividere l’ultimo capitolo di una saga cinematografica in due parti è una prassi consolidata. Ha iniziato Harry Potter con i due film dei Doni della morte, ha proseguito Twilight con Breaking Dawn uno e due. Ora ci casca pure Hunger Games (e nei prossimi anni, stando alle dichiarazioni ufficiali Marvel, sarà la volta degli Avengers per la Infinity War). È un meccanismo che si può applicare alla televisione, quello della divisione in due, o più, parti. In fondo si tratta di aspettare una settimana, al massimo due, nella peggiore delle ipotesi sei mesi, se è un finale di stagione, per sapere come si risolverà il sospeso. Al cinema no, funziona in un altro modo.
È chiaro, l’interesse degli studios è rivolto esclusivamente agli incassi, quindi raddoppiare un film rappresenta un automatico raddoppio delle entrate, ma l’artificio dell’attesa costruita a tavolino compromette, in modo inevitabile e indelebile, la tenuta narrativa di Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte I.
In questo primo-ultimo capitolo non succede niente di sostanziale se non negli ultimi dieci minuti, questo è il tasto dolente. Tutto quanto il film è costruito per aumentare l’attesa della conclusione, della battaglia definitiva che si terrà nella seconda parte e che non sarà nelle sale prima del novembre 2015.
La saga di Hunger Games aveva stupito sin dal suo apparire cinematografico per la capacità di coniugare l’intrattenimento dello spettacolo con una riflessione a diversi gradi su vari aspetti della società contemporanea, mostrando tutta la forza dei romanzi di Suzanne Collins. Attraverso il ricorso all’espediente del futuro distopico, Hunger Games e La ragazza di fuoco (il secondo capitolo) analizzavano il ruolo dei media nella società, la spettacolarizzazione di qualsiasi momento della vita, anche il massacro di adolescenti, a uso e consumo del pubblico televisivo. Si spingevano poi a un livello superiore, ossia la creazione di verità posticce da parte dell’informazione e la manipolazione che il potere è in grado di esercitare sulle masse attraverso l’intrattenimento, in nome del panem et circensem insegnato da Roma.
Nel Canto della rivolta parte I la riflessione sulla comunicazione prosegue, ma sottotraccia. Nella base dei ribelli Katniss diventa strumento pubblico per animare il popolo contro Snow. Anche al Distretto tredici le cose funzionano in base a una forte gerarchia alla cui cima c’è la presidente Coin (Julianne Moore, nuova entrata della saga, che appare molto poco coinvolta in quello che fa). Al suo fianco si muove e tesse Plutarch (Phillip Seymour Hoffman nella sua ultima – ennesima – interpretazione), l’esperto di comunicazione che aveva già affiancato Snow come infiltrato e che ora è chiamato a costruire la mitologia di Katniss. I ribelli la sfruttano, la mandano in giro sempre seguita da una troupe televisiva che riprende tutto quello che fa e dice, che cerca lo spot perfetto per la rivoluzione. Dall’altra parte, Capitol City fa leva invece sull’altra metà dell’amore pubblico, Peeta, portato in città direttamente dall’arena dei giochi, per convincere il popolo che ribellarsi è inutile, che tutto va bene, che tutto è giusto. Sono due forme diverse di manipolazione. Una, quella del governo, basata sulla costruzione di un’immagine rassicurante di ordine e pace, con gli studi televisivi e le luci, gli abiti eleganti e i sorrisi, l’altra, quella dei ribelli, che si immerge nella morte e nel sangue, che fa vedere i bombardamenti e le lacrime vere dell’orrore. Il tutto a uso di telecamera.
Lo scontro tra le due fazioni si consuma, in questa prima parte, su uno scenario indiretto, quello della comunicazione. A mancare, infatti, è soprattutto l’elemento dell’azione, il fuoco della rivoluzione che viene riservato alla seconda parte. Senza il punto forte della battaglia per la sopravvivenza nell’arena che aveva fatto la forza dei primi due capitoli, questa prima parte di Il canto della rivolta non può contare sullo spettacolo ma solo sulla costruzione delle premesse dello scontro finale. Tutto quello che succede, quello che dicono, non è nient’altro che accumulo.
Del resto, anche la Katniss di Jennifer Lawrence brucia solo a momenti, preoccupandosi soprattutto di piangere per mostrarsi straziata e vulnerabile, prima di tornare a usare il suo arco. Katniss è combattuta tra la preoccupazione per Peeta e l’odio per Snow. Questo è il filo conduttore del Canto della rivolta – Parte I, che viene tirato all’inverosimile in inutili ripetizioni. L’effetto cliffhanger è stato ottenuto. A rimetterci è stato il film.
(Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte I, di Francis Lawrence, 2014, fantascienza, 123’)