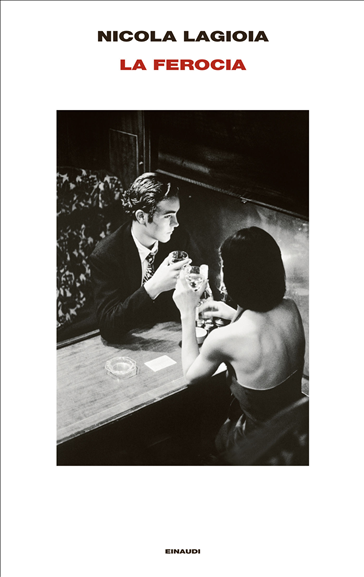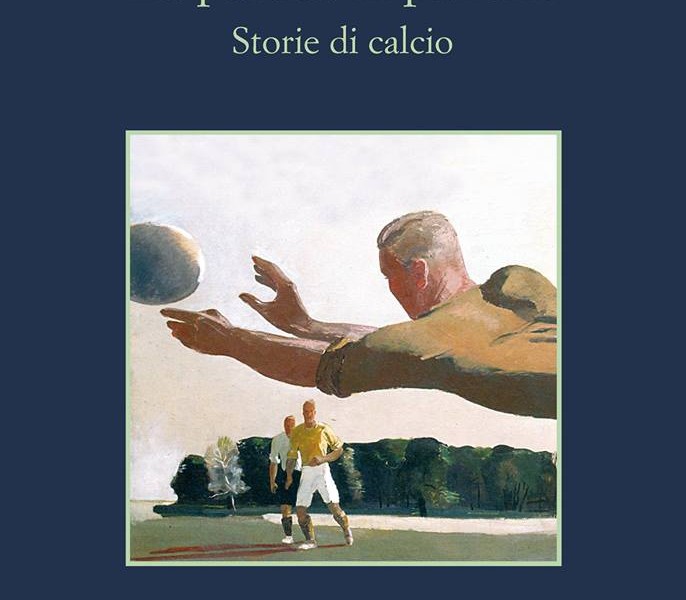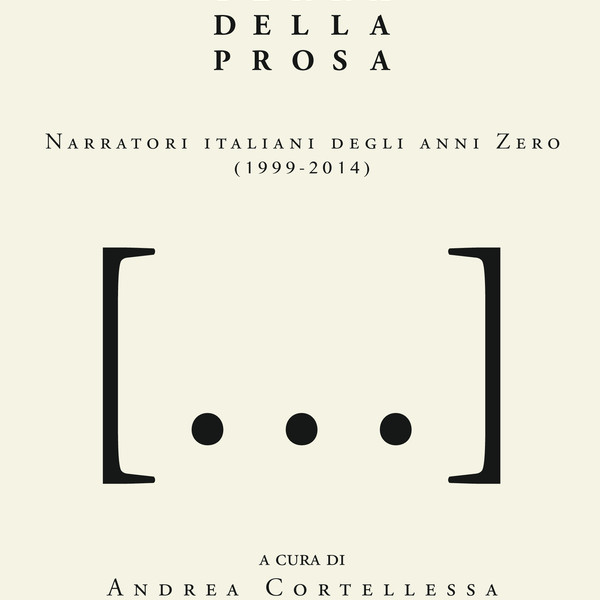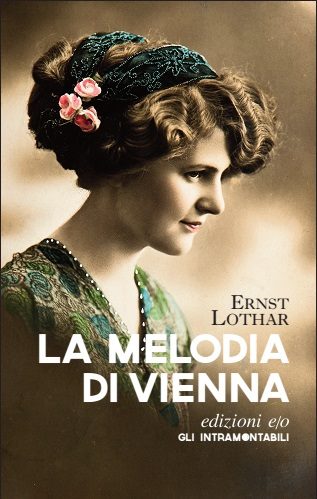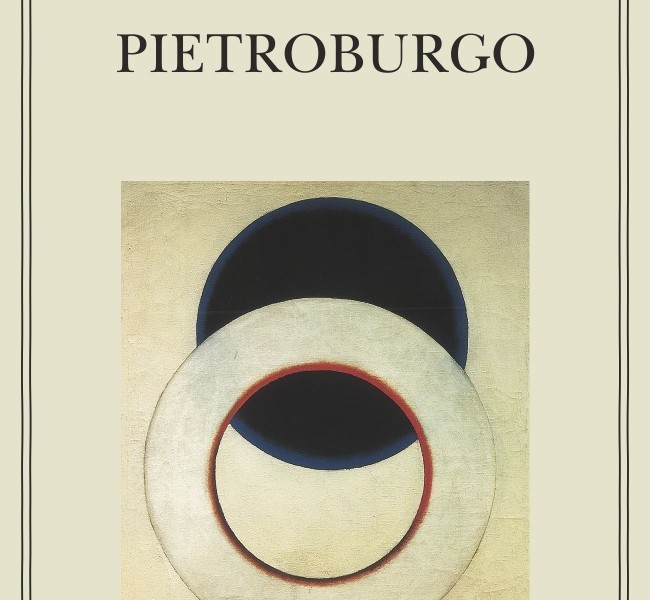Cosmo più servizi di Antonio Riccardi (Sellerio, 2014) si potrebbe definire una spedizione nelle soffitte delle case, delle vite, delle città, dell’arte. Al centro, infatti, sono sempre i grandi o piccoli oggetti abbandonati, o messi da parte in ricordo di qualcuno poi dimenticato, che emergono a sorpresa per consegnarci anacronisticamente il loro messaggio. Una grande casa, bauli, cassettoni, solai, tutti ricolmi di antiche memorie familiari: oggetti e parole. Il poeta Antonio Riccardi torna al luogo generativo della sua famiglia, nella dimora di Cattabiano, nell’Appennino parmense, e lo fa servendosi del racconto delle storie dei suoi avi, che s’intrecciano con la sua personale, dove figurano imbalsamatori, pittori novecenteschi, Piranesi, le tombe nel Cimitero Monumentale di Milano, diorami, musei e quadri sparsi per il mondo.
Scritto in uno stile elegante e desueto, attraverso la pratica e l’arte della parola che soppesa aggettivi e virgole, il libro è un viaggio nella memoria che si colloca tra l’Ottocento e gli anni Settanta del XX secolo. Figura centrale, insieme alla casa, è l’omonimo dell’autore, Antonio Riccardi, sacerdote dal carattere strano e curioso, esiliato nell’ampia dimora, intento a tessere le memorie della sua discendenza, manifestando un profondo e duraturo stato d’inquietudine, che insieme alla malinconia, coglie il narratore stesso di queste divagazioni colte e profonde.
Libro attraversato da meditazioni su varie tematiche, Cosmo più servizi è piuttosto una riflessione alquanto coerente, non solo al microcosmo di Cattabiano, bensì all’Italia intera, a questo Paese sfortunato e disastrato, che non è capace di fare i conti con se stesso e con il proprio declino. Un libro che potrebbe essere definito un ibrido totale, caratterizzato da una grande molteplicità di stili del tempo.
Insieme alla notevole prosa di Riccardi non si può non notare una poetica che potrebbe essere definita una metafisica “accreditata”, in un’ascesi oggettuale e spirituale, condotta in forza di un sentimento al contempo agghiacciante e ferace, come esigenza psichica di senso dell’apparizione umana sul pianeta Terra. Tutto è in Cosmo più servizi assolutamente psichico e non psicologico personale ma non individuale, poiché qui individuo è identico ad assoluto.
Antonio Riccardi, in Cosmo più servizi, in un modo estremamente diverso e e con differente potenza rispetto alla poesia di cui è autore, mette in scena una sorta di scena muta, dove brillano in una luce spettrale tutti i racconti, resi cristallo e pietra dallo sguardo di Medusa della storia storica e metastorica, cioè dal fenomeno umano. È un’interezza ontologica coincidente con la sua espressione totale estetica che si gioca qui nella rima che frattura il tutto con il nulla.
(Antonio Riccardi, Cosmo più servizi. Divagazioni su artisti, diorami cimiteri e vecchie zie rimaste signorine, Sellerio, 2014, pp. 172, euro 16)