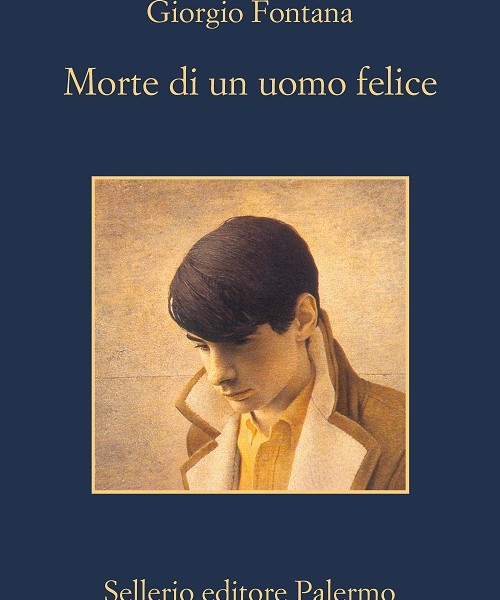Passato con grande successo al Toronto International Film Festival arriva all’Auditorium Nightcrawler – Lo sciacallo, prima regia di Dan Gilroy in concorso nella sezione Mondo genere.
Louis Bloom è un giovane spiantato che gira in macchina per Los Angeles la notte in cerca di espedienti. Ruba rame, recinzioni metalliche, tombini di piombo, che poi rivende per pochi dollari. Una sera, durante uno dei suoi giri, si ferma a osservare due poliziotti che cercano di estrarre una donna da una macchina in fiamme. Sulla scena dell’incidente piombano due cameraman che iniziano a riprendere il salvataggio. È così che Bloom scopre il mondo degli “stringer”, cineoperatori freelance che vanno in giro la notte sulle frequenze della polizia a caccia di scoop da rivendere ai notiziari del mattino. Gli piace, come idea. Si procura una telecamera, una radio, e inizia a girare, andando a caccia di rapine, di incidenti d’auto, di sparatorie. Fa un colpo, poi un altro. Mostra immagini a cui nessun altro arriva. Cresce, prende un assistente, compra nuove telecamere, una macchina veloce, e ribalta la sua posizione con il canale tv con cui collabora: non più anonimo procuratore di immagini, ma elemento centrale del notiziario.
Il vantaggio, se così si può chiamare, di Bloom è nel suo essere completamente distante da qualsiasi dimensione umana. Non c’è nessun filtro di compassione o empatia tra le cose che vede e quelle che decide di filmare. Bloom non apprezza la compagnia degli altri, e lo ammette senza problemi. Non vuole una relazione che non gli porterebbe niente. Chiede sesso alla direttrice del notiziario per continuare a fornirle l’esclusiva, e lo fa con lo stesso distacco di una mediazione d’affari. Gli altri non esistono, non li vede. Vede e vuole solo l’immagine sensazionale, a ogni costo, entrando nelle case delle persone, piazzando la telecamera di fronte alla morte, componendo l’inquadratura perfetta prima dell’arrivo della polizia, creando apposta la scena del crimine per il suo servizio, se serve. Non c’è morale, non c’è dignità.
Per il suo esordio alla regia, Dan Gilroy (una carriera come sceneggiatore, dal visionario The Fall a The Bourne Legacy) ha deciso di raccontare le conseguenze estreme della crisi, lo svuotamento di significato del mondo umano di fronte al voyerismo e alla società del consumo e dello spettacolo. Non è un mostro, Louis Bloom. Non lo è nella misura in cui basa le sue azioni su una logica rigorosa e inattaccabile di profitto e reciprocità, di ottenere il massimo da tutto ciò che arriva a ogni costo. È consapevole, lo dice all’inizio mentre cerca di vendere rete metallica, che per avere cose buone bisogna lavorare tanto, che c’è da lavorare e impegnarsi qualsiasi cosa comporti. Lui impara quello che c’è da imparare, come può. Ascolta ogni lezione, ogni suggerimento, ricorda ogni parola. Con i suoi occhi sempre spalancati assorbe tutto quello che serve per arrivare al successo. E non è un mostro nel momento in cui si ritrova a offrire un servizio richiesto, a spostare poco più in là un limite già basato in tutto sulla sensazione del momento. I notiziari che serve non ricercano la notizia, cercano la traccia da lasciare nello spettatore, cercano il motivo per essere preferiti a internet o agli altri canali. Non si tratta di dire che c’è stata una sparatoria in una villa, c’è da far vedere i cadaveri, perché la notizia la possono dare tutti.
È in questa prospettiva che Bloom è il prodotto compiuto del mondo, il figlio radicale dell’orrore quotidiano. Privato di prospettive, senza neanche più l’illusione di una stabilità data dal lavoro fisso, da un sentimento eterno, Louis Bloom ha elevato il nulla a sistema. Striscia nella notte in caccia di prede non per sé ma per il pubblico da nutrire la mattina a colazione, prima di andare a lavoro, di portare i figli a scuola. È quello che vogliono, è quello che lui procura. Ed è per questo che lo sciacallo continua a lavorare.
Muovendosi in una Los Angeles livida e buia, vicina ai colori di Collateral di Michael Mann e alla solitudine devastante di Crash di Paul Haggis, Louis Bloom è un personaggio da ricordare come simbolo di alienazione e inquietudine grazie al lavoro strepitoso di Jake Gyllenhaal, dimagrito venti chili, scavato nel volto e negli occhi, e distante come non mai dall’aspetto da bravo ragazzo americano. È la sua interpretazione migliore, una delle colonne su cui regge Nightcrawler – Lo sciacallo con cui Dan Gilroy si mostra definitivamente al cinema, non più nascosto negli script ma proponendo la propria idea di cinema. Cupo, spietato, veloce quando c’è da accelerare, e in cui ognuno è solo, sotto l’occhio della telecamera.
(Nightcrawler – Lo sciacallo, di Dan Gilroy, 2014, thriller, 117’)




_03.jpg)








_01.jpg)