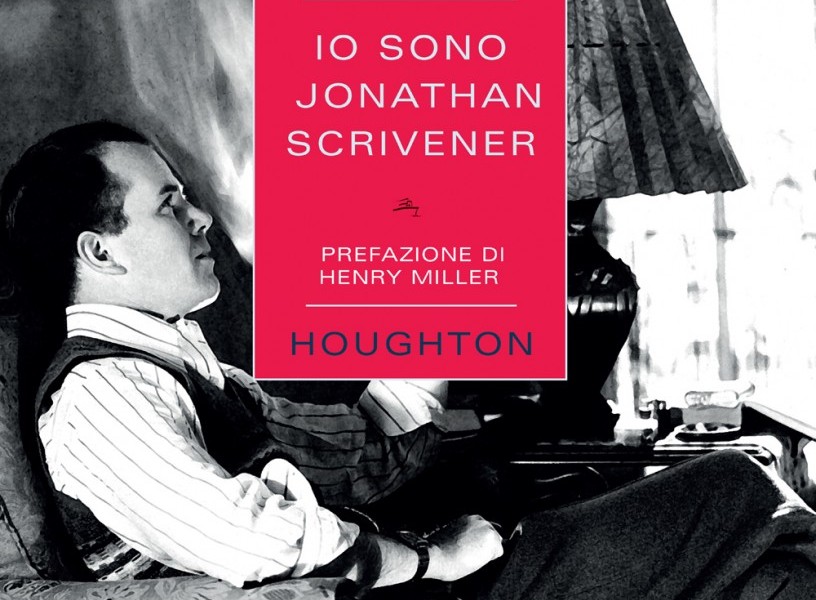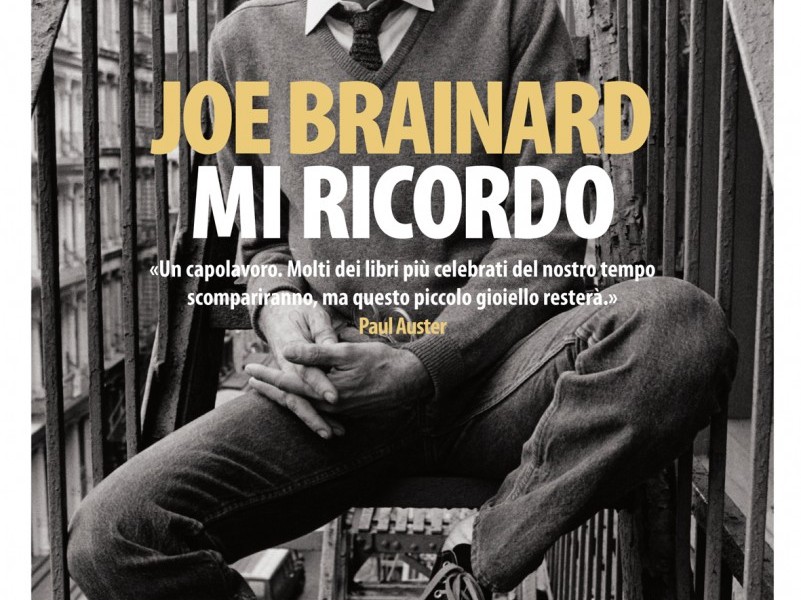La vita di James Wrexham appare inquieta da subito. La madre gli muore prestissimo, è figlio unico di un padre eccentrico che muore in circostanze non chiare quando lui non è ancora ventenne: e si ritrova così male in arnese da dover pensare presto a come mantenersi. Per sua fortuna lo chiama un agente immobiliare, sedicente amico di suo padre, e lo fa lavorare con lui. Saranno anni di una noia mortale, passati i quali Wrexham decide di rispondere a un annuncio sul giornale per un lavoro a Londra.
E lì inizia un’altra storia, la storia di questo romanzo, Io sono Jonathan Scrivener dello scrittore inglese Claude Houghton (1889-1961), che l’editore Castelvecchi rimette ora in circolazione con un prefazione di Henry Miller – che il libro lo amava – e la traduzione efficace di Allegra Ricci.
L’affaire intorno a cui ruota il romanzo è quantomeno bizzarro, secondo tradizione consolidata di certa letteratura inglese. Anzi, a leggere Miller, «in Claude Houghton questa singolare follia inglese – una sorta di demenza alla rovescia – acquista un’intensità notevole». Wrexham è stato assunto da un certo Scrivener: un incredibile fantasma che si è accontentato della sua lettera di presentazione, che non ha visto in faccia, e che ha bisogno di un segretario che gli sbrighi la corrispondenza e gli tenga in ordine la biblioteca. Tutto questo mentre è in viaggio senza sapere se e quando farà ritorno a Londra.
Per quanto stravagante sia la situazione, Wrexham accetta (lo stipendio è ottimo) e occupa presto l’abitazione di Scrivener. Se ne gode il lusso, la considerevole quantità di tempo a disposizione e intanto medita sullo strano caso che gli è capitato. Che si fa ancora più misterioso quando, ben presto,una successione di visite comincia a inquietarlo, anche considerando l’avvenenza delle prime due, una tale Pauline, e poi Francesca Bellamy, nota alle cronache per essere stata la moglie di un celebre finanziere morto suicida. Entrambe fanno irruzione nella casa chiavi in mano e hanno l’aria di essere donne interessanti. Cercano Scrivener, mostrando di non sapere nulla della presenza di Wrexham – il quale, anche in seguito ai racconti tutt’altro che omogenei che gli fanno del suo fantasmatico datore di lavoro, comincia a sospettare di essere finito in un crudelissimo gioco (non sarebbe esatto dire spaventoso: come nota ancora Miller «quel che forse è più inconsueto, tra le creature inconsuete che ci consegna Houghton, è il loro totale distacco»), le cui sole certezze sono: la bizzarria dei casi e una certa diffusa convinzione che la stessa sia il segnale di un’intelligenza sopraffina, diciamo pure superiore.
L’editore definisce il libro un thriller psicologico, ma il romanzo ha più il passo di un giallo compassato e senza sangue: la trama che lo compone è fatta soprattutto di un’ambiguità che si fa presto e francamente enigma, non tanto e solo sui fatti (chi è Scrivener, dove si è ficcato, è vivo o morto) quanto sulla nozione stessa di identità. Quella di Scrivener assume mille facce, anche divergenti, a partire dai racconti dei suoi amici. A tratti emerge direttamente con una certa sinistra quanto elegante fascinazione: nelle lettere che invia al povero Wrexham per dargli disposizioni. Assieme ai dialoghi del segretario con l’avvocato di Scrivener, sono i momenti stilistici più interessanti del libro. Il che non è secondario o esornativo: la nebulosità della storia è costruita attraverso la narrazione in prima persona di Wrexham, linguisticamente così minuziosa e accanita nella ricerca del dettaglio rivelatore da contribuire paradossalmente a infittire la mappa degli indizi e a lasciare il lettore a trovare da sé una soluzione. Scrivener, per alcuni un imbroglione, un fanfarone di genio che si stufa di tutto, molla amici conoscenze e occupazioni per sparire all’improvviso salvo a volte tornare più brillante e inafferrabile di prima, ecco, chi è Scrivener? E soprattutto, cosa vuole dal nostro narratore?
(Claude Houghton, Io sono Jonathan Scrivener, trad. di Allegra Ricci, Castelvecchi, 2014, pp. 288, euro 18,50)