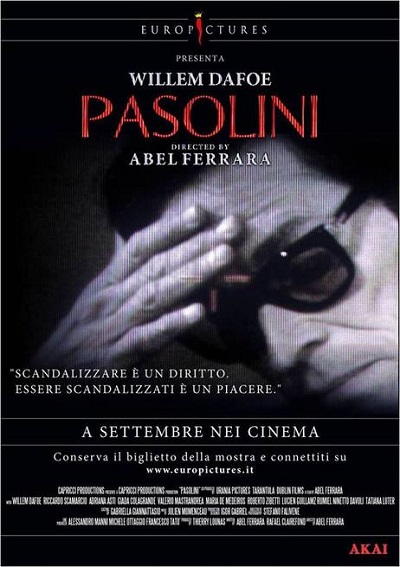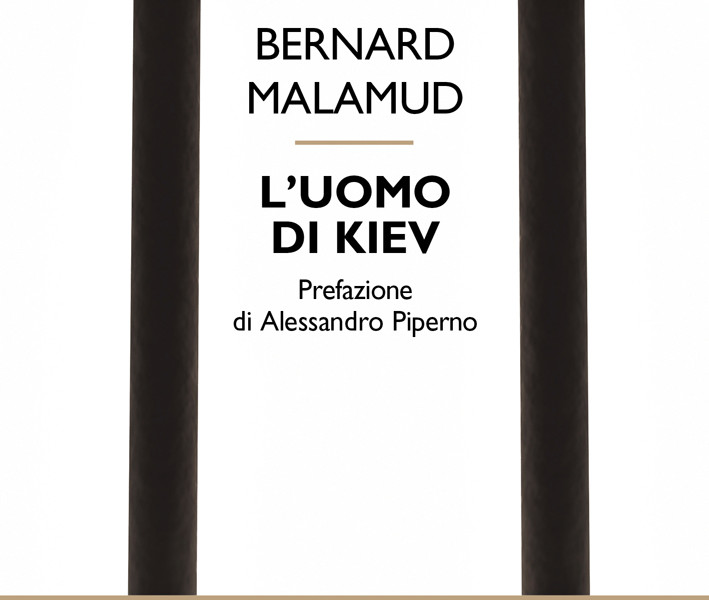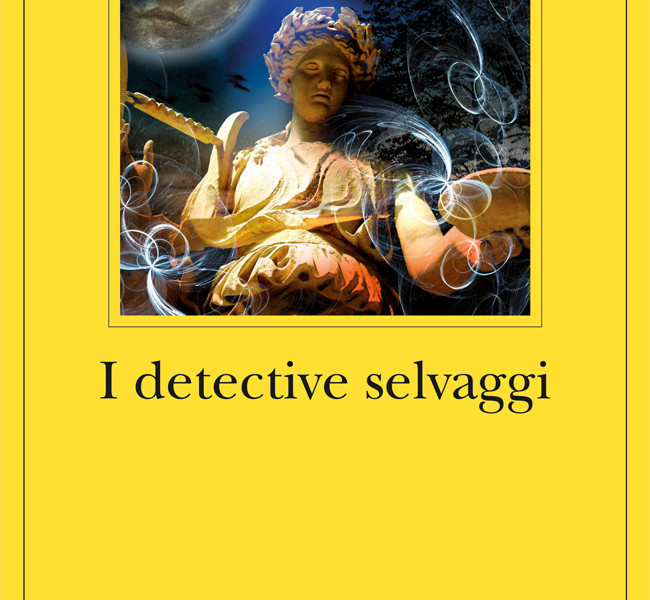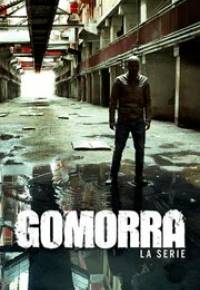Ultime ventiquattro ore, qualcosa di più, della vita di Pier Paolo Pasolini nella ricostruzione di Abel Ferrara presentata all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Dal risveglio a Roma dopo una trasferta a Stoccolma fino al ritrovamento del corpo senza vita all’idroscalo di Ostia all’alba del 2 novembre 1975. In mezzo c’è spazio per le lotte contro la censura per Salò o le 120 giornate di Sodoma, il rapporto con la madre e la famiglia, un pranzo in casa con Laura Betti di ritorno dalle riprese di Vizi privati e pubbliche virtù e da una sessione di doppiaggio per L’esorcista, un’intervista con Furio Colombo che verrà pubblicata su “Tuttolibri” con il titolo Siamo tutti in pericolo l’8 novembre, a sei giorni dalla morte, una cena tarda con Ninetto Davoli, consorte e figlio neonato. Poi il bar della stazione, Pelosi, il Biondo Tevere, Ostia, le botte, la morte.
Tra tutto questo c’è il lavoro: Pasolini che invia a Moravia il manoscritto di Petrolio per avere un’opinione; Pasolini che batte a macchina; Pasolini che scrive a Eduardo De Filippo per parlargli del film mai realizzato Porno-Teo-Kolossal e convincerlo a esserne il protagonista. Le lettere, gli appunti, le riflessioni, prendono vita sullo schermo, diventano narrazione nella narrazione, non più semplici idee ma forme.
Ecco, è proprio in questa scelta che Abel Ferrara dimostra di aver capito poco non solo del Pier Paolo Pasolini personaggio pubblico, ma anche e soprattutto della sua opera. Perché non c’è fedeltà, non c’è aderenza al linguaggio, allo stile, ai meccanismi sia cinematografici che di scrittura. Nella ricostruzione del quotidiano dello scrittore (come per brevità si era fatto etichettare Pasolini sul passaporto) si può usare come alibi la distanza culturale classica e inevitabile di chi dagli Stati Uniti prova a descrivere un’Italia lontana nella geografia e nel tempo, in cui si dichiara di non poter andare all’estero perché «so cucinare solo gli spaghetti» e in cui gli scontri del disordine politico sono ridotti al rango di vago e generico riferimento.
È nel confronto diretto con il linguaggio pasoliniano che ogni giustificazione cade, che emergono tutti i limiti di un film incapace di cogliere l’essenza della materia raccontata. Ferrara non vuole parlare della vita di Pasolini, o meglio, attraverso la sua morte vuole parlare della sua opera, della sua grandezza di intellettuale totale, di personalità capace di essere tutto ciò che fosse arte e cultura. Lo chiarisce nell’apertura che ricostruisce la sua ultima intervista televisiva alla televisione francese in occasione dell’uscita di Salò o le 120 giornate di Sodoma in cui viene ribadito il legame tra sesso e politica, il connubio tra scandalizzare come diritto ed essere scandalizzati come piacere. Posta questa chiave, Ferrara non fa niente per delineare un quadro preciso dell’opera pasoliniana, la butta lì per far vedere e capire che Pasolini è come lui: un provocatore, uno che fa dello scandalo un linguaggio per parlare di morale, per scuotere. Gli piacerebbe, a Ferrara, essere minimamente come Pasolini, che del sesso e della mostra del sesso, dell’abominio, aveva fatto un universo disturbante e simbolico capace di incidere coscienza e immaginario e incapace di lasciare indifferenti. Quella di Pasolini era una ribellione colta alla società piatta in cui l’istruzione obbligatoria aveva reso tutti uguali, tesi agli stessi bisogni da soddisfare, dividendo in soggiogati e soggiogatori (dall’intervista con Furio Colombo). Ferrara fa del ribellismo goffo pensando di parlare la stessa lingua di quello che chiama Maestro, mostra un pompino omosessuale nei primi minuti, con dettagli, per far vedere che non ha paura di niente, e quando prova a fare Pasolini immaginando un possibile Porno-Teo-Kolossal rischia il ridicolo (la scena dell’orgia nella Sodoma romana di gay e lesbiche uniti per la procreazione al grido di «Fica, fica, vaffanculo! Cazzo, cazzo, vaffanculo!»).
Insistendo sul tema dello scandalo e della provocazione, soprattutto nella prima parte, Abel Ferrara cerca di cogliere l’essenza dello scrittore ma si limita in verità a scalfirne la superficie. L’attitudine provocatoria tipica del cinema di Ferrara, il parlare dell’alto partendo dal basso del vizio, la ricerca della fede, di una verità morale, nei vicoli bui dell’agire umano, si scontra qui con un modello troppo più grande per non risultare un tentativo fallito miseramente. Non è possibile leggere Pasolini come un film d’arte per celebrare un’artista attraverso la sua opera, mostrando il connubio indissolubile tra vita e poetica, cercando il parallelo a tutti i costi tra la sordida fine di PPP e l’ascesa finale di Epifanio e del servo nell’ipotizzato Porno-Teo-Kolossal. Non basta montarli uno accanto all’altro per creare un vero collegamento, inseguire una cometa che è una «stronzata» e dire che la fine non esiste per lasciare intendere che l’eredità, il segno nel tempo rimane.
Il Pasolini di Ferrara è approssimativo, pasticciato, generico, debole in tutto ciò che circonda un William Dafoe che oltre alla mimesi fisica non riesce a riprodurre un briciolo della rabbia, della dignità, della grandezza del vero Pasolini. Non c’è la potenza delle idee nel confronto con Furio Colombo, non c’è il pensiero di Pasolini se non in forme semplificate e fraintese. Si salva solo la sequenza cruda e spietata dell’omicidio.
Da quello che un tempo era un campione dell’irriverenza cinematografica, della distruzione del sacro nella prosaicità del concreto, ci si sarebbe potuti attendere ben altro sguardo su chi, davvero, riusciva con il suo cinema e la sua penna a scuotere le coscienze della borghesia.
(Nota a margine: è uno dei rari casi in cui è fermamente sconsigliata la visione in lingua originale. Meglio optare per il doppiaggio di un attore esperto del repertorio pasoliniano come Fabrizio Gifuni anziché preferire la doppia lingua inglese e italiana della versione internazionale mostrata a Venezia. Straniante e, ancora una volta, confusa).
(Pasolini, di Abel Ferrara, 2014, biografico, 87’)