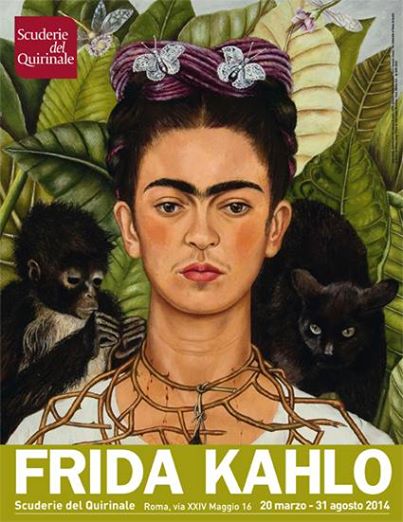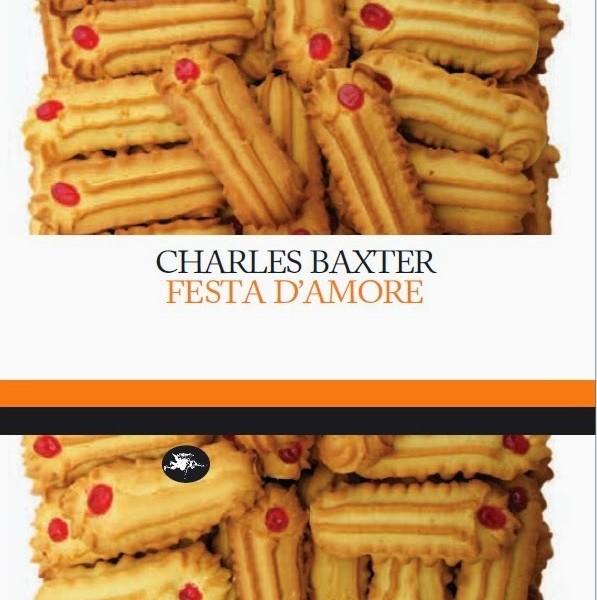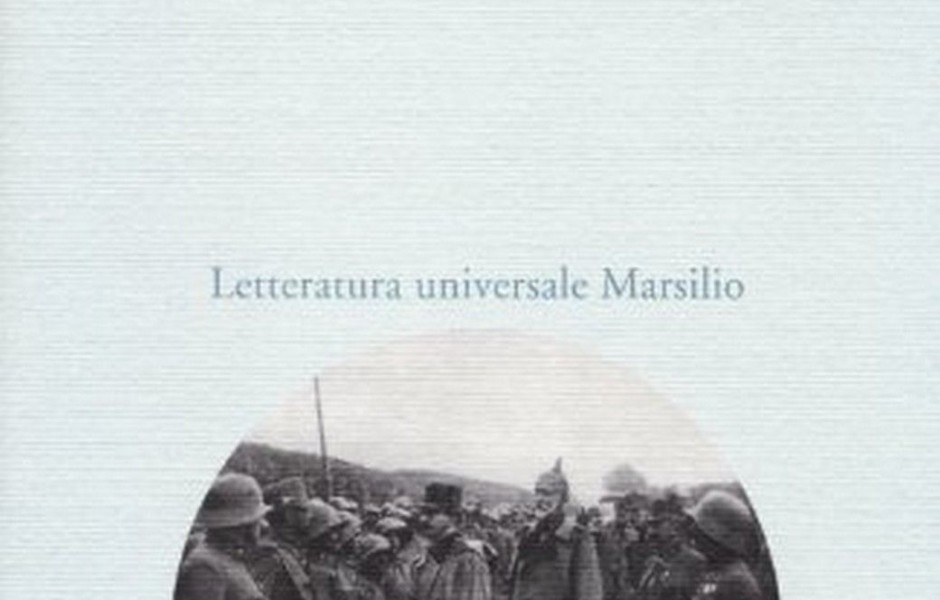Luigi De Pascalis è uno scrittore abruzzese, lancianese, con una notevole vena inventiva sorretta da una struttura narrativa di ampio respiro, come si è visto nei suoi romanzi di cui Il mantello di porpora è attualmente all’attenzione della critica, con apprezzamenti da parte di studiosi del calibro di Claudio Strinati o Filippo La Porta. Sempre storico, ma di tutt’altra ambientazione, è un altro suo romanzo, La pazzia di Dio, (La Lepre Edizioni, 2010), che vede protagonista la Grande Guerra vissuta da un ragazzo di un paesino dell’Abruzzo montano.
È un grande affresco di famiglia e di un’intera comunità che ricorda il romanzo classico ottocentesco, ma con un aggancio a Ignazio Silone, pur con una minore presenza dell’aspetto socio-politico, e per certi versi tendente al romanzo di formazione.
Siamo a Borgo San Rocco, un paese della valle del Sangro, vicino Chieti. Da queste parti, la vita, a fine Ottocento, è sempre uguale a se stessa, legata alla terra e al lavoro dei campi, con una fatica dura ma comprensibile, e quindi accettata come destino. I Sarra sono la famiglia possidente del paese, in cui nel 1895 nasce il secondo figlio di Filippo ed Elvira, Andrea.
Con loro vive Sigismondo, il fratello di Filippo, che esercita la professione di medico come si poteva esercitare allora in paese, cioè come un padre energico che segue i suoi pazienti come pecorelle smarrite. A questi personaggi si aggiunge Cicco, un figlio naturale di Filippo, che è accettato in casa benché Elvira gli sia ostile. Tuttavia Andrea e Cicco cresceranno come fratelli veri, uniti più di quanto Andrea lo sia con gli altri fratelli.
Gli anni passano. Dopo gli studi liceali a Napoli, in un tetro collegio di gesuiti, Andrea decide di partire per la guerra, dove avrà la più grande lezione di vita. Inoltre, deve abbandonare Rosa, la sua amante a Borgo San Rocco, amante in paese, e tutta la sua vita, i suoi sogni e la passione per la pittura, per perdere la sua umanità e ritrovarsi, lupo tra i lupi, nell’insensatezza di una guerra che è il macello di una generazione intera.
Ma il grande sacrificio collettivo è lo sradicamento di un popolo contadino dalle antiche consuetudini di vita, un popolo che nel giro di pochi anni si trasforma in qualcosa di totalmente diverso. L’esperienza di quegli uomini era unicamente volta a ciò che conoscevano, l’ubbidienza e l’umiltà le sole armi di cui disponevano. Ritrovarsi in un ambiente ostile come quello del fronte sarà un’esperienza che non sapranno interpretare.
Come la caduta della neve, per esempio, vista nella vecchia vita come portatrice di riposo, poiché d’inverno la campagna è in periodo di stasi, e dunque una possibilità di pausa, ma in guerra la neve non ferma le armi, anzi aumenta i disagi con il ghiaccio e il freddo, in una indifferenza apatica che congela anche gli animi, ma che rimarrà dentro quegli uomini ben oltre la fine della guerra.
Andrea partecipa a battaglie e al tempo sfinito della trincea, ma ha un dio benevolo che lo protegge: il suo attendente, detto Riccio, abruzzese come lui, che lo salva in più occasioni. Riccio è una figura vivida, piena di umanità, con il quale De Pascalis vuole forse adombrare il carattere “forte e gentile” dell’abruzzese.
Quando torna a casa, Andrea è cambiato. Trova il divario tra la vita ordinata della sua infanzia e il caos maligno della guerra, del fronte, con la loro inesplicabile ineluttabilità. Si rende conto di quanto sia stato inutile partire, lui che aveva pensato potesse essere solo un modo per farsi accettare dal padre, ma tutto è stato inutile perché ha perso anche la sua Rosa, che nel frattempo si è sposata. Perfino a casa sua, sembra che non ci sia più posto per lui, non perché rifiutato ma perché è lui stesso a sentirsi fuori posto.
Eppure, in quegli anni, la sua gente ha continuato a vivere, e a morire, con un certo ordine naturale; a lui invece è toccata l’insensatezza della guerra, con il “lupo” che è rimasto dentro di lui perché non è semplice liberarsene e tornando padrone della propria umanità.
A casa, un’altra terribile prova è in attesa: la spagnola. La grave epidemia che ha falcidiato ila popolazione europea all’inizio del secolo scorso è come una seconda guerra. Il padre e la madre moriranno, e la sorellina Margherita, e lo zio Sigismondo, e molti altri servi e amici del paese. Sarà Andrea ad accompagnare ai funerali la sua famiglia, i Sarra che soccombono alla spagnola, come un pastore pietoso che porti le sue pecore al sicuro.
La vita continua a scorrere, ma nulla sarà come prima, anche se i membri superstiti della famiglia tenderanno a prendere il posto degli scomparsi: Camillo, il fratello maggiore diventato medico, somiglia allo zio Sigismondo, medico anche lui; la sorella Carlotta, con la cura maniacale per la casa, sembra la madre; e lo stesso Andrea, nei suoi silenzi, insoddisfazioni, delusioni, tristezze, sarà sempre più uguale a suo padre.
Ma in paese arrivano nuove figure tristi, che approfittano dei tempi per ottenere la loro parte nella Storia. Il mondo agricolo muta, con lo scomparsa di tanti personaggi che avevano riempito la vita semplice dell’infanzia di Andrea, come mastro Alfredo, il ciabattino, che temeva il silenzio ma amava la musica con cui poteva sconfiggerlo.
Nel corso del romanzo incontriamo anche figure storiche reali, in particolare artisti come Gabriele D’Annunzio, che Andrea conosce per caso in una pausa del conflitto, e Boccioni, di cui egli sente parlare da un collega ufficiale come di un genio artistico irripetibile – e questa è un’altra sacrilega conseguenza della guerra, che annulla le nobili aspirazioni e tutto quello che l’Arte può suggerire di alto, per deviare là dove la Storia conduce il destino degli uomini, attraverso vie faticose anche per lo spirito. Solo con la pace si potrà ricostruire poi, oltre che le città, anche il pensiero, con la trama dei progetti e la volontà di procedere nel bene comune.
Un romanzo commovente e corale, pieno di spunti, con un senso di concretezza quasi terrosa e vicina al passato, ma anche con la speranza nel futuro, con Andrea che, ritrovata una sua vecchia amica d’infanzia, ha il coraggio di intraprendere con lei una nuova vita.
Di fronte alla “pazzia di Dio”, che altro non è che la pazzia enigmatica dell’uomo che non si sa spiegare se stesso, forse possiamo solamente dispiegare, allo stesso modo degli antichi filosofi, la sospensione di giudizio, l’epochè, ripetendo con i contadini abruzzesi nel loro dialetto: «Chi c’appura?»
(Luigi De Pascalis, La pazzia di Dio, La Lepre Edizioni, 2010, pp. 302, euro 22)