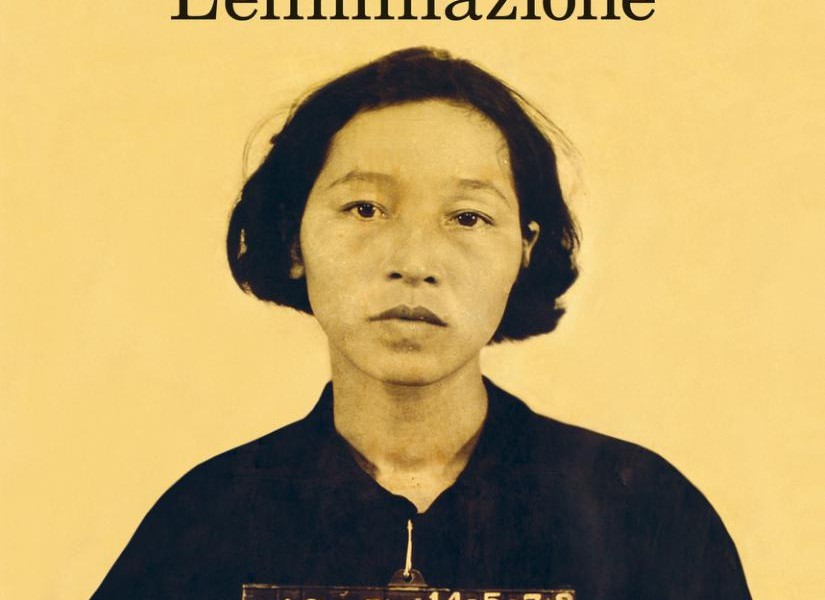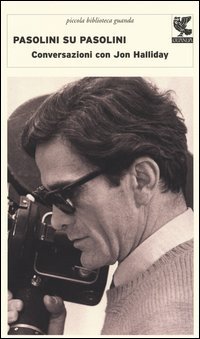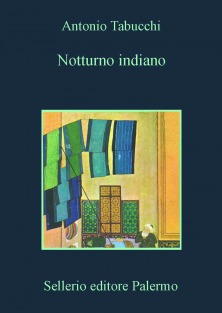Marc Augé descrive l’ospedale come un non-luogo, ovvero come uno spazio che ha la prerogativa di essere non identitario, astorico ed emotivamente asettico. È nel tentativo di ribaltare questo concetto che Il grande Flebosky trova il suo senso profondo e, sfuggendo alla tentazione di fare demagogia contro lo scandalo della malasanità, che nel nostro Paese è un argomento all’ordine del giorno, esplicita la capacità dell’essere umano di affrontare con coraggio anche la più difficile delle prove: la malattia.
Il grande Flebosky è in guerra con se stesso, con il suo corpo, eppure, nonostante debba combattere questa guerra sul più sterile dei campi di battaglia, riesce a individuare e superare tutti gli ostacoli che si frappongono tra sé e la guarigione. Non solo fisica, s’intende, ma anche quella psicologica, perché Il grande Flebosky, armato di ironia e levità, traccia mappe su mappe per non permettersi di sfuggire a sé stesso, per non perdersi o ingrigirsi, per scampare la morte convinto che non si smette di vivere quando si muore, ma si muore quando si smette di vivere.
Il riso è la chiave e non si tratta del riso lieve generato dall’ironia sottile, né della risata contenuta e intelligente dovuta alla battuta complicata; al contrario, giochi di parole, freddure, battutine e battutacce e nomignoli evocano una comicità immediata, rumorosa, sostenuta da frequenti richiami diretti al pubblico, ammiccamenti e una mimica accattivante. Ridere forte, quindi, e ridere bene, di pancia. Ridere della malattia per curarla, ridere della morte per scacciarla, ridere dell’ospedale per farlo proprio, per dare un nome che abbia un senso ai medici, alle infermiere, ai luoghi, ai parenti in visita e alle malattie. Ridere per sopravvivere.
Tra i pochi elementi di una scenografia semplice, pochi separé su ruote, un efficace disegno luci e le rapide comparse di due caratteristi di eccellente bravura, si svolge quindi un monologo dalle potenzialità importanti, capace di sfidare con pochi semplici cambi sillabici il carcere di micro-strutture linguistiche che, per dirla con Foucault, fanno del malato un «corpo docile».
Eppure è davvero un peccato che tante promesse siano alla fine tradite. Pistoia si dimostra eccellente nel creare l’atmosfera, coinvolgente, accattivante, ma sale in palcoscenico con il copione, si interrompe quando distratto, cede al pubblico il ruolo del suggeritore e, anche a voler concedere il beneficio del dubbio che l’errore sia calcolato e la tensione spezzata ad arte, l’improvvido intervento dell’incaricato suggeritore che spezza il pathos e passa all’attore la battuta durante una pausa a effetto nel discorso, risponde all’interrogativo dello spettatore che si stia chiedendo se il tradimento del patto tra attore e pubblico sia studiato o meno.
Il grande Flebosky
Tratto da Storie di ordinaria corsia di Fabrizio Blini
regia di Gigi Piola
con Nicola Pistoia
Prossime date
Roma – Teatro dei Conciatori, dal 6 al 25 maggio2014