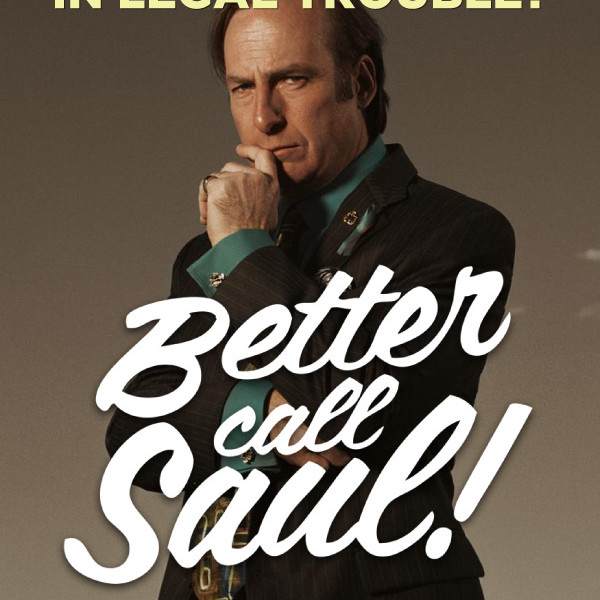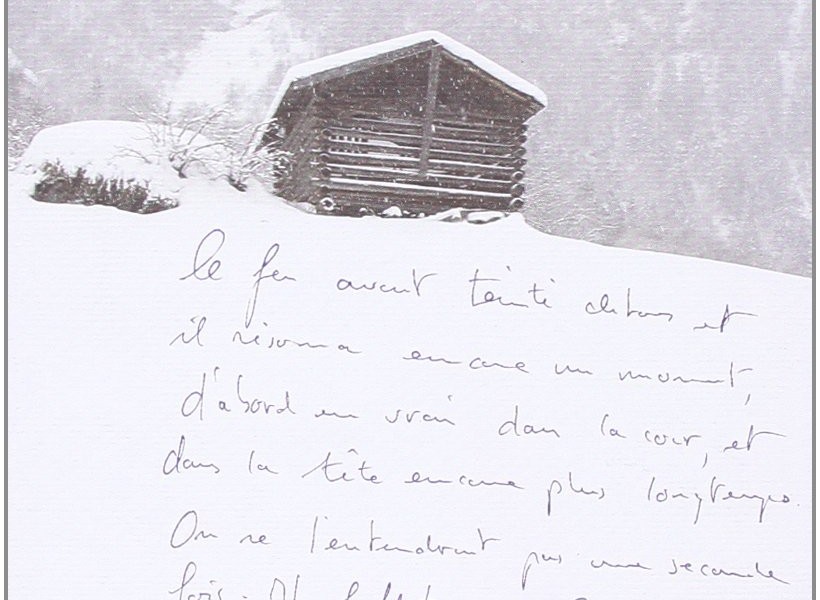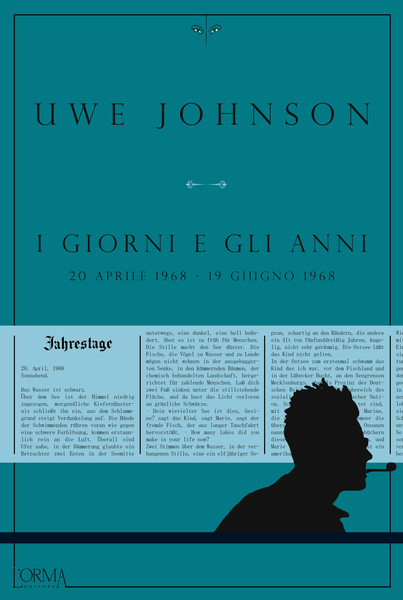Quando la nostra serie tv preferita finisce è un po' come vivere la fine di una relazione: ci si sente improvvisamente soli e abbandonati, irrimediabilmente tristi, a tratti inconsolabili. Il momento dell'addio è sempre doloroso e l'unica consolazione che a volte ci viene concessa è quella piccola promessa chiamata spin off. Cos'è lo spin off? Da un punto di vista tecnico, un qualcosa che deriva da un corpo principale, in questo caso una storia nuova che nasce dall'originale. Ma la vera domanda è: cos'è davvero lo spin off?
Di solito una manovra pubblicitaria, nonché un tentativo estremo di tenersi stretta la fascia di pubblico guadagnata con fatica durante gli anni, ragion per cui tante volte il prodotto finale è deludente – anche se non tutti gli spin off sono destinati a far rimpiangere la serie madre.
Per quanto riguarda le novità di quest'anno le nostre aspettative migliori sono senza dubbio per Better Call Saul, che debutterà a novembre, e che i fan di Breaking Bad attendono trepidanti dopo la splendida conclusione della serie lo scorso settembre.
Sarà incentrata sulla figura di Saul Goodman, l'avvocato di Walter White, che ha caratterizzato Breaking Bad con una vena comica e surreale, e racconterà le vicissitudini di Saul promettendoci – così almeno ci è stato rivelato sul web – i cameo di altri personaggi principali, tra cui il ritorno di Bryan Cranston nei panni di Walter White.
Scegliere di basarsi sulle avventure di un personaggio che è stato sviluppato in maniera marginale nella serie madre è una scelta buona, permette di collegare tanti avvenimenti tra loro senza snaturare il prodotto, dal momento che il rischio maggiore è quello di far rimpiangere ancora di più la fine della storia originale.
Se invece vogliamo guardare il lato rischioso e parlare di spin off 'preoccupanti' come non nominare How I met Your Dad, idea (malsana) degli stessi autori di How I Met You Mother che hanno finalmente concluso la serie il mese scorso dopo nove anni di attesa interminabile.
I fan sono ancora indecisi se accettare o meno la sorpresa del finale ed ecco che la CBS ha già confermato che manderà in onda le avventure di un altro gruppo di amici che hanno in comune con Ted e gli altri il MacLaren's: la stroria sarà raccontata da un punto di vista femminile e i personaggi saranno tutti nuovi, ma il rischio di incappare in un fiasco è grande, se consideriamo che How I Met Your Mother ha smesso di essere brillante alla quinta stagione e si è trascinata fino alla nona come un brodo allungato all'infinito.
Ma non sempre gli spin off mettono in agitazione i fan: Devious Maids, nato da una costola di Desperate Housewives, è passato quasi sotto silenzio ma è già alla seconda stagione con buoni ascolti e nessuna pretesa. Creato da Eva Longoria – che smessi i panni della frivola signora Solis ha deciso di passare dall'altro lato della macchina da presa -, racconta le storie di quattro domestiche latinoamericane a Beverly Hills, tutte al servizio di ricche coppie che nascondono dei segreti inquietanti. Sotto questo punto di vista ricalca molto la base di Desperate Housewives, dove i misteri di Wisteria Lane si sviluppano attorno al suicidio di Mary Alice Young, ma i personaggi sono ben caratterizzati, diversi tra loro e divertenti e si capisce senza troppe difficoltà che le due serie hanno punti in comune ma anche aspetti che le rendono diverse e quindi entrambe interessanti.
La formula che Devious Maids ha adottato per piacere al pubblico è semplice: ha preso il meglio di Desperate Housewives (in questo caso la caratterizzazione e la vena comica di fondo) e l'ha trasposta in una storia nuova dove cambiano i volti e i setting, ma la trama si snoda attraverso sentieri che Eva Longoria conosce bene e nei quali sicuramente sa destreggiarsi con sicurezza.
Il risultato è una serie leggera che non dispiace ai fan di Desperate Housewives ma neppure a chi non conosce i misteri di Wisteria Lane, ragion per cui la consigliamo a chiunque abbia voglia di iniziare una serie poco impegnativa che può regalare piacevoli momenti senza troppe pretese.
Per il momento, non potendo palare degli spin off non ancora usciti mi permetto di dare un coniglio spassionato a chi come me ha amato How I Met Your Mother e ha fatto fatica ad accettare la fine così come l'hanno pensata gli sceneggiatori: se non volete farvi altro male e rimpiangere quello che fu, mantenete puro il ricordo di Ted e amici che ci hanno fatto ridere e piangere per anni e state alla larga dai vari surrogati; di solito sono solo brutte copie degli originali.