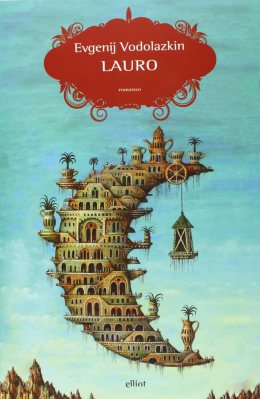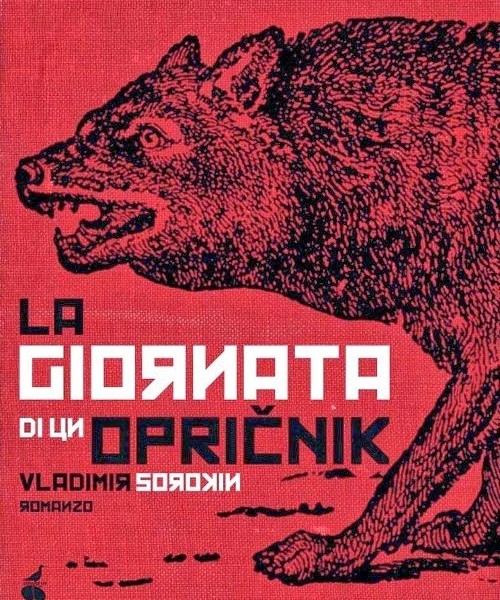Per quanto mi sforzi e a costo di apparire pretenziosa, non riesco a fare a meno di notare anzitutto che, forse per la prima volta, mi trovo al cospetto di una quarta di copertina che non delude, quando di solito riempita solo per non essere lasciata vuota. Cito dunque dalla quarta di Lauro, opera dell’autore ucraino Evgenij Vodolazkin (Elliot, 2013): «Un romanzo sull’amore nel significato più vero del termine, in cui elementi della natura medievale e contemporanea si fondono felicemente». E vorrei sottolineare per chiarezza quel sull’amore, e non d’amore dunque: agli antipodi rispetto agli Harmony, per intenderci, con tutto il dovuto rispetto.
Lauro è la storia di Arsenio, un bambino dell’affascinante quanto dura Russia di un non troppo distante Medioevo, rimasto orfano e per questo cresciuto dal nonno Cristoforo: nomina sunt omina, e mai fu più vero come in questo testo. Arsenio di nomi ne avrà addirittura quattro, forse perché, ci suggerisce l’autore «[…] la vita dell’uomo è multiforme. A volte succede che le sue parti abbiano poco in comune, talmente poco da sembrare vissute da persone diverse». Instradato dal nonno alla conoscenza dei segreti delle erbe e dei preparati medicinali, il ragazzo pare avviato a una brillante carriera di guaritore, quando la sua vita subisce una forte battuta d’arresto, segnata dalla morte per parto della donna amata. Questo evento tragico sembra inizialmente annichilire la sua esistenza, ma in realtà le darà il suo più autentico e profondo indirizzo: «“So che tu sogni la morte. Ti sembra che la vita non conti più nulla, non ci trovi un senso. Ma proprio ora nella tua vita si è rivelato un senso importante come non mai. […] Gli occhi di Arsenio fino ad allora erano asciutti. “Ma la vita terrena io gliel’ho tolta”. Lo starec lo guardò tranquillo. “Allora dalle la tua”. “Dici che io avrei la possibilità di vivere al posto suo?”. “Parlando seriamente sì. L’amore vi ha resi una sola cosa, e questo significa che una parte di lei è ancora qui. E quella parte sei tu.”». Eccolo qui l’amore di cui si diceva, punto focale del romanzo e Stella Polare del protagonista: umano, tutt’altro che banalizzato, vero, sempre a un palmo dalla morte eppure totalmente irriverente nei suoi confronti, tale da condurre serenamente al gesto dei gesti, dare la propria vita. Inizia così il viaggio, sofferto, verso la scoperta del senso della propria e altrui esistenza.
Eppure il fascino di questo testo non sta soltanto nella sua trama, per quanto intrisa di elementi particolarissimi, le descrizioni delle rigide ma rubiconde atmosfere russe, i personaggi, sempre lì lì per sconfinare nel magico, funambolici come tali possono essere soltanto le comparse di una letteratura così profondamente segnata da Dostoevskij, e poi lo sfondo, fatto di spazi sterminati fisici e non, racchiusi in un orizzonte squisitamente medievale il cui filo conduttore è il viaggio, tema trattato quasi alla stregua dantesca, non solo spostamento ma anche maturazione, non solo viaggio dell’anima, ma raggiungimento in sé dell’infinito. Amore, viaggio e tempo, sono questi gli elementi attraverso cui il lettore si muove, elementi che si intersecano di continuo, inscindibili, interscambiabili, ed è bravo l’autore a dosarli con cura, a darci di ognuno una saggia porzione, facendo in modo che mai da essi ci si allontani troppo, cosicché la storia di Arsenio è anche quella di un uomo contemporaneo, Jurij Aleksandrovic Stroev dell’anno 1977, la cui vita viene rievocata in una visione da Ambrogio Flecchia, veggente e viaggiatore nel tempo, appunto. «Stroev partì in treno per Pskov. […] pensava che non avrebbe più trovato Alessandra. […] “Non ci sono” avrebbe detto Parchomenko “sono andati via per sempre. Per sempre. Lei ha tergiversato troppo a lungo. Ma, a dire il vero, il tempo non c’entra, perché un vero amore non è nel tempo. Il vero amore può aspettare anche tutta la vita. […] Lei non ha saputo cogliere nulla di tutto questo e questa sua spedizione, come la precedente, è un inutile dispendio di tempo». Di nuovo amore, viaggio e tempo, un tempo prezioso pare, che non va sprecato.
Eppure, soltanto se si fosse disposti a viaggiare e se si arrivasse alla fine del viaggio sospinti dall’amore ci si accorgerebbe che «[…] il cammino dei vivi non può essere circolare. Il cammino dei vivi è aperto, perché senza uscita dal cerchio quale libero arbitrio ci può essere, […] mi piace paragonare il moto del tempo a una spirale. È una ripetizione ma a un livello nuovo. Più alto. Oppure se si vuole l’esperienza del nuovo ma non da zero. Con il ricordo del vissuto precedente”. Da dietro le nuvole spuntò un debole sole autunnale. Dalla parte opposta delle mura apparve lo starec Innocenzo. Durante la conversazione con Ambrogio aveva fatto in tempo a fare il giro del monastero. “Pure tu, starec, fai un cerchio”, gli disse Ambrogio. “No, questa è già una spirale. Certo, cammino come prima in un mulinello di foglie, ma nota, Ambrogio, che è uscito il sole, e io sono già un po’ diverso”».
(Evgenij Vodolazkin, Lauro, trad. di Emanuela Bonacorsi e Nodar Ladaria, Elliot, 2013, pp. 307, euro 18,50)