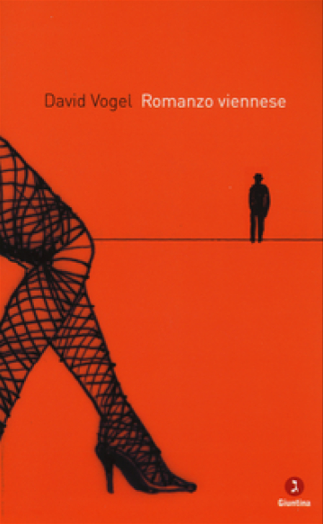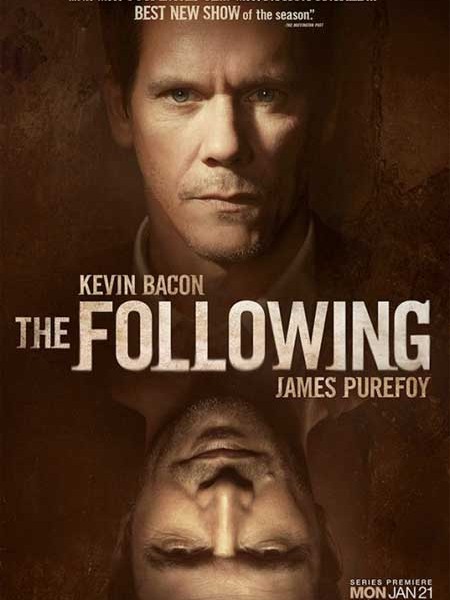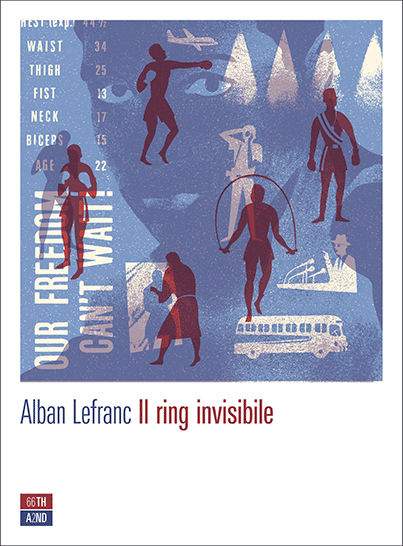Dopo due anni di quiete intervallata da un illusorio omaggio a Nina Simone, il 4 febbraio 2014 gli Xiu Xiu, quella strana creatura partorita dalla mente di Jamie Stewart nel lontano 2000, emette un nuovo lamento esternando ancora una volta tutta la propria ansia e tutta la propria schizofrenia. Il nono lavoro è intitolato Angel Guts: Red Classroom (titolo tratto da un film erotico giapponese del 1975).
Come a ogni loro uscita discografica questa volta ancora più che mai, gli Xiu Xiu travolgono e stravolgono al punto che piaccia o meno, non se ne può rimanere indifferenti.
«L’inizio della discesa di Xiu Xiu dal grigiore, nella più profonda oscurità sopportabile, è il suono della morte di Xiu Xiu. I temi sono: la questione-razziale, sesso, doppio suicidio, doppia penetrazione, criminalità, la paura del dolore, e non è adatto per i deboli di cuore. Ma quando il cuore ha smesso di battere, resta solo l’anima da portare avanti».
È con questo comunicato stampa sulla propria pagina web che la band ci consegna il biglietto per l’ennesimo tormentato viaggio affidandoci a Jamie Stewart che, come un decadente e post-moderno Virgilio, ci invita a seguirlo nella discesa agli inferi…i suoi inferi!
È proprio da considerarsi tale questo ennesimo lavoro degli Xiu Xiu, un viaggio nei bassifondi di una città indefinita e “malata” in cui si incontrano persone che non sono mai quello che sembrano, nascondendo sempre qualcosa nelle ombre proiettate da lampadine a neon di locali claustrofobici o stanze di alberghi a ore in cui consumare voluttuosamente desideri di omicidi e suicidi. In questo disco più che nei precedenti la voce di Jamie Stewart non si limita a esternare ansie interiori, ma si spinge a dargli contorni macabri e perversi usando bisbigli e urla, alternando momenti di lucida ansia a momenti di isteria schizofrenica. Il risultato è un disco che disorienta e che raramente ti permette di riprendere fiato. Quando ti concede una breve tregua ti colpisce subito dopo come un pugno in pieno stomaco.
Gli album precedenti davano principalmente spazio ai deliri, Angel Guts: Red Classroom invece appare più “lucido”, è un disco cinico, di un cinismo freddo di chi affronta temi malati e perversi con il distacco che solo una mente folle può permettersi. Le atmosfere sono più intime e claustrofobiche anche per la scelta degli strumenti usati, viene messa da parte quasi totalmente la chitarra che dà spazio a synth analogici e drum machines anni ’70, il tutto supportato da percussioni improvvise e disarmanti. Scontato quindi pensare ai Suicide o ai lavori di Von Lmo.
Il viaggio infernale vede 14 tappe sonore che risultano però un continuum altalenante.
Apre un intro strumentale (“Angel guts” ) ed è così che comincia la discesa agli inferi, accompagnati da un vento magnetico e sonoro che ci sospinge verso la macabra vocalità di Stewart in “ArchiE’s Fades”. “Stupid in the Dark” attinge a piene mani dalle sonorità anni ’80 ed è forse il pezzo che meno ti aspetti dagli Xiu Xiu. Un capitolo a parte è rappresentato da “El Naco” e “Black Dick”, basti solo pensare al fatto che il video di quest’ultima sarebbe inutile cercarlo su YouTube o Vimeo, per reperirlo dovreste infatti andare su PornoHub… si è proprio lì che è stato rilasciato ufficialmente, inutile dire che è sconsigliabile la visione sul posto di lavoro o in ambienti protetti. Se avete ancora dubbi sulla follia visionaria e paranoica degli Xiu Xiu, potete godervi le atmosfere industrial di “The Silver Platter” e “Knife in the Sun” fino a sfociare nell’ inquietante e ansiogena “Cynthya’s Unisex”. Ci sono tuttavia due piccoli barlumi di umanità anche in questo disco rappresentati dalla tiepida “Bitter Melon” e da “Botanica De Los Angeles” in cui riemergono i tratti melodici più comuni agli album precedenti.
In definitiva Angel Guts: Red Classroom più che un disco è un “esperienza”, come quando da bambini si entrava nella casa degli orrori al Luna Park e camminandovi dentro si provava quella condizione di tensione costante data dalla consapevolezza che lo spavento e il disorientamento sarebbero potuti arrivare da un momento all’ altro. E quella tensione, tutto sommato, era di per sé un piacere. In quelle attrazioni da luna park all’uscita c’era sempre uno scheletro che con la manina ci salutava e con un rumore sinistro ci spalancava la porta d’uscita. È proprio con questa logica che “Red Classrom” ci congeda dall’ ascolto riconsegnandoci all’ apparente normalità del mondo, ma con il battito cardiaco ancora accelerato… a voi le conseguenze!
(Xiu Xiu – Angel Guts : Red Classroom, PolyvinylBella Union, 2014)