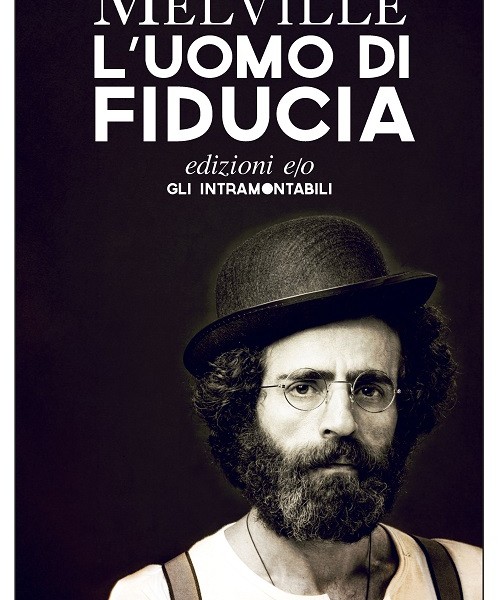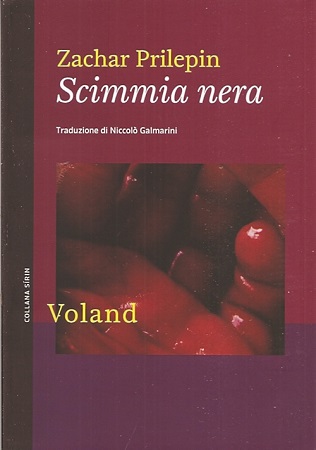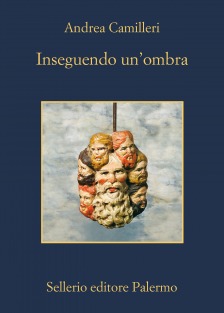Atteso, discusso, censurato, tagliato, criticato, rinnegato. Tutto questo prima ancora di essere stato visto. Se l’intenzione di Lars Von Trier era quella di creare scandalo e aspettativa intorno al suo Nymphomaniac, c’è riuscito perfettamente.
L’attenzione morbosa della stampa e del pubblico internazionali che hanno accompagnato il film sin dalla gestazione nel 2011, i riferimenti erotici evidenti delle immagini promozionali, la doppia versione e la teoria delle distribuzioni differite – prima la versione mondata delle scene più esplicitamente sessuali, poi la seconda, fedele alle intenzioni del regista e quindi con elementi oltre il limite del pornografico interpretati da controfigure provenienti dal mondo del cinema adulto –, l’uscita danese la sera di Natale e poi l’arrivo a Berlino, la maglietta di Von Trier contro Cannes reo di averlo bandito per presunte simpatie naziste, la protesta personale di Shia Labouef che cita Cantona e si incappuccia sul tappeto rosso, hanno prodotto una quantità di discussioni, articoli e critiche preventive che hanno pochi precedenti. Lo scandalo, il mostro del sesso che terrorizza e attrae ancora come la più potente delle calamite e che per continuare a funzionare deve essere nutrito sempre di più, spinto e mostrato ogni volta oltre i limiti di ciò che si è presunto accettabile fino a quel momento, è combustibile e miccia che Von Trier usa per bruciare i confini forse per lui troppo stretti del cinema e propagarsi come fenomeno culturale e di costume globale.
E poi c’è il film, o i film per dare retta alla suddivisione in due volumi che non ha niente a che vedere con la trama ma solo con le logiche distributive: la storia di Joe, lasciata pestata a sangue in strada una sera e trovata, raccolta e accudita dall’uomo solo Seligman a cui racconta una vita di avventure erotiche, dalla confusa scoperta infantile della sessualità e delle dinamiche del piacere, fino agli abissi più scuri della carne, passando per la prima volta con un primo amore distante, le scommesse e la scelta del sesso come strumento di ribellione alla società e il rapporto con la madre, «gelida stronza», e il padre, soprattutto, uomo elevato a categoria ideale di sapienza e affetto e visto scivolare a piombo nella negazione della dignità del delirio. Nella camera disadorna in cui la accoglie, Seligman ascolta silenzioso, senza giudicare, ispira i titoli per i capitoli in cui Joe suddivide la sua narrazione anticipando o recuperando paragoni per il catalogo erotico nella pesca, nella matematica, nella polifonia, nella storia. È chiamato a essere involontario confessore dei peccati – è lei a ritenerli tali – di una ninfomane. Finisce per essere psicologo più che prete, non assolve perché per lui, e anche per Joe, non c’è niente da perdonare, ma comprende, contestualizza, tira in mezzo la società e la rappresentazione sbilenca del sesso, che perdona l’uomo ma condanna ancora il desiderio femminile. Forte di un’asessuata verginità, è lo specchio in cui la ninfomane Joe può vedere la propria immagine speculare e riflettere (su) se stessa per la prima volta.
La prima parte di Nymphomaniac segue i primi cinque capitoli del racconto di Joe, che ha in questa fase la voce di Charlotte Gainsbourg e il corpo di Stacy Martin. La seconda, divisa in tre capitoli e un epilogo ideale, segue le perversioni adulte di Joe.
È assurdo a dirsi, ma di sesso in Nymphomaniac ce n’è molto meno di quanto Von Trier avesse fatto credere. Nonostante gli ammicchi, i richiami, i volti orgasmici del cast nella locandina, a prevalere nelle oltre quattro ore della versione soft è la chiacchiera, la riflessione e la discussione sulla sessualità molto più che sul sesso. È un’indagine, che guarda molto a Freud, sull’identità sessuale come condanna permanente, come destino che influenza e condiziona la vita sin dal suo primo manifestarsi. Il desiderio sessuale è una delle potenze che costringono l’agire umano anche nelle forme più raffinate di sovrastruttura sociale. L’appetito insaziabile di Joe la porta a farsi attraversare da corpi in centinaia che compongono le parti di un organo unico, come esplicitato nel capitolo sulla polifonia: l’idea stessa del desiderio. Niente può vincere il desiderio incoercibile, né il padre morente né la normalità di una famiglia.

La voglia costante è l’identità specifica di Joe, è il suo essere, non il suo agire. Se ne rende conto Jerome, il primo amore che torna e che le dà un figlio, che per concederle di nuovo gioia e piacere la autorizza a tornare in cerca di altri uomini, se ne rende conto Joe stessa affermandosi ninfomane e non sesso-dipendente, rivendicando il marchio dell’infamia come diritto di autodeterminazione contro la stimmate sociale della malattia. L’indulgenza per il cannibalismo sessuale, però, non è plenaria. Joe riconosce la dimensione del peccato nel momento in cui realizza il dolore che la sua condotta ha sugli altri attraverso il dolore fisico che sperimenta su di sé. L’antropofagia simbolica del sesso femminile diventa autodistruzione quando il corpo reagisce ad anni di abusi sanguinando, disfacendosi, appassendo assieme al desiderio. È lì che Joe inizia a guardare alla dimensione sociale della sua ninfomania, riconoscendosi nella solitudine di un pedofilo potenziale che censura i suoi istinti per evitare di essere il male. Perché, appunto, la sessualità, in ogni sua forma, è identità e modo d’espressione dell’essere umano. Joe avrebbe potuto essere frigida, omosessuale, anorgasmica o asessuata come Seligman e il film non sarebbe mutato nella sostanza, solo nelle forme espositive.
Certo, la scelta della ninfomania ha dato modo a Von Trier di stuzzicare la voyeuristica pruderie di quell’establishment che tanto gli piace scandalizzare, ma lasciando gli scandali e la sensazione al loro luogo di competenza (la cronaca dell’infimo, perché oltretutto le dinamiche della conquista sessuale sono di un ridicolo, forse volontario, che ricorda l’erotismo patinato di quel filone di cinema che unisce Le età di Lulù a Melissa P.), Nymphomaniac è in primo luogo un film sulla solitudine dell’uomo di fronte alla sua condizione, preda costante degli istinti invincibili che spazzano via ogni tentativo di costruzione sociale, di relazione ulteriore rispetto all’individualità.
Portando a compimento la sua ideale trilogia sulla depressione (iniziata con Antichrist e proseguita con Melancholia), il regista danese ha maturato e concluso una riflessione sull’uomo di fronte a se stesso. L’ha declinata al femminile perché la donna, in quanto principale potenza genitrice, è creatura ancestrale e oscura, radice stessa dell’essere umano e quindi sintesi simbolica dell’umanità.
A differenza dei capitoli precedenti, soprattutto di Antichrist – ma forse il discorso vale solo per questa prima versione “leggera” – Von Trier non vuole torturare lo spettatore sparandogli immagini incomprensibili e violente, ma piuttosto si diverte a fare cinema, cambiando stile espositivo tra i vari momenti della narrazione, citandosi nel citare di nuovo Händel che apriva magistralmente Antichrist, e raggiungendo momenti di grande enfasi (gli alberi, le passeggiate, ma soprattutto l’esplosiva e lancinante Mrs. H di Uma Thurman) e, tutto sommato, rendendosi meno ermetico e più comprensibile grazie alla guida di Seligman. Con Nymphomaniac, nel finale soprattutto, Von Trier lascia intendere che un riscatto, che è imposizione e dominio su se stessi, è possibile nel momento in cui si comprende e accetta la propria natura per assimilarla con la ragione.
Così, i vari capitoli del racconto di Joe, confezionati come le storie della tradizione novellistica delle Mille e una notte, dei Racconti di Canterbury e del Decameron, tra l’altro già di loro permeati di erotismo come evidenziato dal cinema di Pasolini, diventano stazioni di una via crucis profana, non blasfema, che rende possibile una vittoria dell’uomo-ragione sull’uomo-passione.
Non è detto che per arrivarci fosse necessario passare attraverso i duecentoquarantuno minuti, o addirittura i trecento della versione estesa, di film conditi con tutto il clamore pompato ad arte e lo spettro di una minaccia censoria che avrebbe impedito la distribuzione in Italia e in altri paesi. Von Trier ha scelto questa strada. E il risultato va oltre le polemiche.
(Nymphomaniac Vol. I, di Lars Von Trier, 2013, drammatico, 118’)
(Nymphomaniac Vol. II, di Lars Von Trier, 2013, drammatico, 123’)
Nymphomaniac Official Trailer from Zentropa on Vimeo.