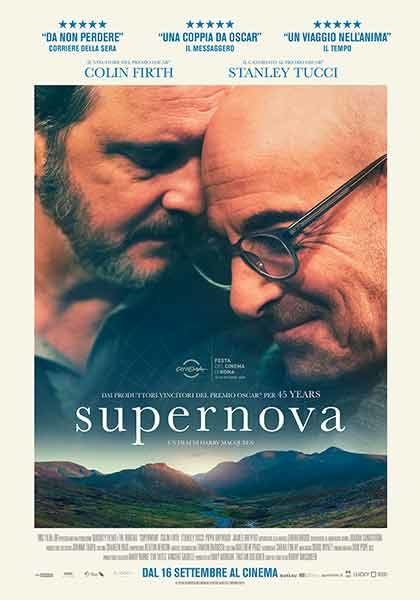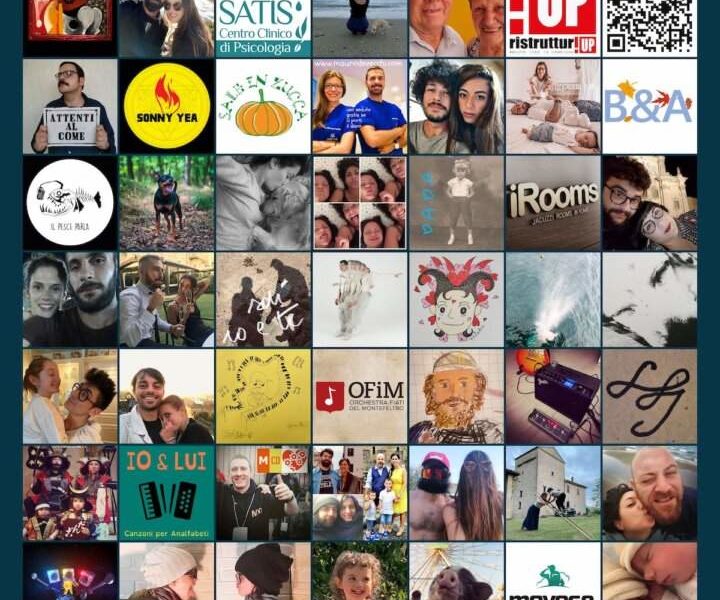È da poco in libreria La fuga di Enea (Solferino, 2021), raccolta in volume di una serie di editoriali di Antonio Scurati. Scritti per La Stampa e per il Corriere della Sera, gli articoli del Premio Strega 2019 compongono un mosaico dettagliato, «un vero atto di accusa al Paese di oggi», come si legge nella sinossi.
Dall’assenza politica della generazione X all’esplosione dei populismi, dall’oblio della scuola al presentismo degli adulti, tanti sono i temi toccati da Scurati, in un percorso che inizia prima della pandemia e sembra poi trovare speranza, paradossalmente, proprio mentre il Covid imperversa nell’Italia del 2020.
Gli editoriali raccolti dall’autore di M sono accomunati da una doppia anima: da un lato, si tratta sempre di analisi impietose della crisi permanente italiana, in tutte le sue sfaccettature; ma dall’altro è anche «una traiettoria ascendente» – così sostiene Scurati nell’introduzione –, una progressiva presa di coscienza dell’editorialista, sempre meno disponibile a denunciare e commiserare il presente e sempre più accorato nel predicare e ricercare un’alternativa, una rinascita, un futuro possibile.
Non è un caso che, come dicevamo, sul banco degli imputati compaia più volte la generazione X: quella di Scurati, degli adulti nati tra il 1960 e il 1980. «Stiamo nell’età adulta come adolescenti deprivati» scriveva l’autore nel 2011, raccontando il dramma di classi d’età cresciute con la promessa della festa permanente, del progresso continuo, e colpiti all’improvviso dalla Grande recessione (e ora dalla pandemia). Diagnosi e accusa si confondono quando Scurati recita (lo fa più volte) il ritornello di David Leavitt, che elegge a cifra di vita per i suoi coetanei: «Era sempre sabato sera e stavamo sempre andando a una festa».
Il presente, sembra dire l’autore, appartiene a una generazione che non è mai diventata adulta e si ostina ancora, sulle soglie dei sessant’anni, a non volerlo diventare. È questa pletora di donne e uomini irresponsabili, suggerisce, a inchiodare il mondo – e l’Italia soprattutto – a un presente permanente, in cui non c’è posto per il ricordo del passato e per la pianificazione del futuro.
Se questa è l’epoca degli “xoomers”, è allora inevitabile che sia anche l’epoca, per esempio del declino di Venezia, travolta dall’acqua alta e amministrata come una gallina dalle uova d’oro per i «suoi elettori di terraferma»; ma anche di un’università giunta in punto di morte, strozzata dai meccanismi di valutazione; della scuola allo sbando, alla quale si nega un ministro all’altezza del compito); della politica che rifiuta il linguaggio della complessità («Al grado zero dell’arte retorica si posiziona lo stesso Trump»). Ma, soprattutto, questi problemi discendono a cascata dall’annientamento del pensiero politico e dell’azione politica. «Siamo stati […] una generazione impolitica» commenta lapidario in uno dei primi editoriali dell’era Covid. E senza politica è ovvio che i grandi valori si disperdano e che si perda la bussola necessaria a programmare il futuro.
In più di un articolo Scurati si scaglia contro la pochezza degli attuali attori politici («Dobbiamo davvero rassegnarci a questo stillicidio quotidiano di inettitudine, a questo osceno battibecco, a questo ragliare di muli sterili?»). Ma dopotutto cosa aspettarsi da tempi simili? In «Il Palazzo e le Piazze ignorate» l’autore prova a ripercorre le tracce di un mutamento genetico delle proteste popolari, osservando come le masse abbiano smesso di mobilitarsi attorno a grandi temi e alle speranze di un avvenire migliore. Pian piano hanno preferito sempre di più protestare per resistere contro il presente, a volte persino contro le istituzioni democratiche che ne consentono gli sgraditi sviluppi. E l’ordine dei testi pubblicati sembra suggerire che proprio da qui è nato il terreno fertile per i nuovi populisti, «leader in grado di guidare la folla non precedendola, ma seguendola». Nuovi per modo di dire, perché per Scurati è lampante la continuità metodologica con il fascismo: fu Mussolini «l’inventore» della categoria del leader-populista.
Riepilogando, la generazione X ha smesso di fare politica e si è rifugiata nella propria intimità: ha smesso di convertire i problemi privati in collettivi, e quindi è entrata in un loop negativo di autocommiserazione («smettiamola di lamentarci» scrive Scurati) per poi affidarsi a demagoghi senza arte né parte. E allora dov’è la luce che l’autore crede di poter vedere nei suoi scritti? Probabilmente proprio nelle occasioni offerte dalla pandemia, una scossa senza precedenti che potrebbe costringere questa classe di “bambini troppo cresciuti” (ridotti a mettersi «in coda per il pane» come durante una guerra) a recuperare l’eredità di Enea, il compito di unire le generazioni: salvare Anchise e tutti i figli degli anni Quaranta, generazione grandiosa da proteggere contro il virus, e dare un futuro ad Ascanio, iniziare cioè a immaginare davvero una società diversa per garantire un’esistenza libera ai propri figli e nipoti.
«I giornali si chiamano così perché durano un giorno»: con questa battuta Scurati apre, sarcasticamente, il volumetto. Durano di più, gli editoriali raccolti in La fuga di Enea? A dire il vero, sembrano andare tutti un po’ in affanno, accusare un diaframma tra obiettivo e risultato, tra la larghezza dello sguardo e la qualità dell’analisi. Per esempio, la spoliticizzazione degli xoomers e la loro conclamata fragilità emotiva sono argomento di dibattito sociologico e politico molto serio (Realismo capitalista di Mark Fisher offre un assaggio della complessità del tema) che di certo non si può ridurre – come Scurati fa per tutto il libro – a una sorta di colpa morale collettiva, rimediabile con uno “scatto di reni” o un “sussulto di dignità”. Come è possibile che lo stesso sostenitore di una ripoliticizzazione della società finisca per ignorare la natura politica di questi fenomeni e immaginarli come meri peccati mortali nei quali sono caduti tutti insieme milioni di persone? Se la pandemia, almeno finora, non ha dato alcuna scossa, forse è perché c’è qualcosa di più.
Forse alcuni editoriali di Scurati durano un giorno, ma la nostra domanda dura ben di più: ci ricorda la differenza tra descrivere e analizzare, tra narrativa storica e politica. Leggere questo libro è anche un modo utile per tenerlo a mente: per non dimenticare che in certi trabocchetti retorici può cadere anche un grande intellettuale e scrittore, non solo l’elettore disagiato.