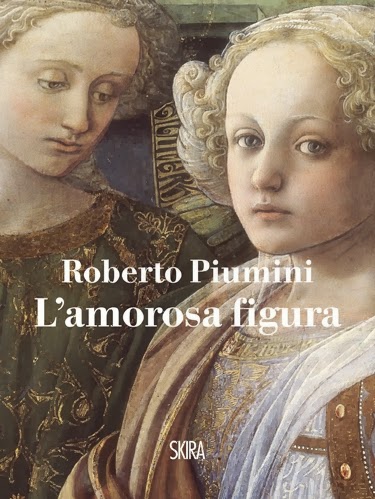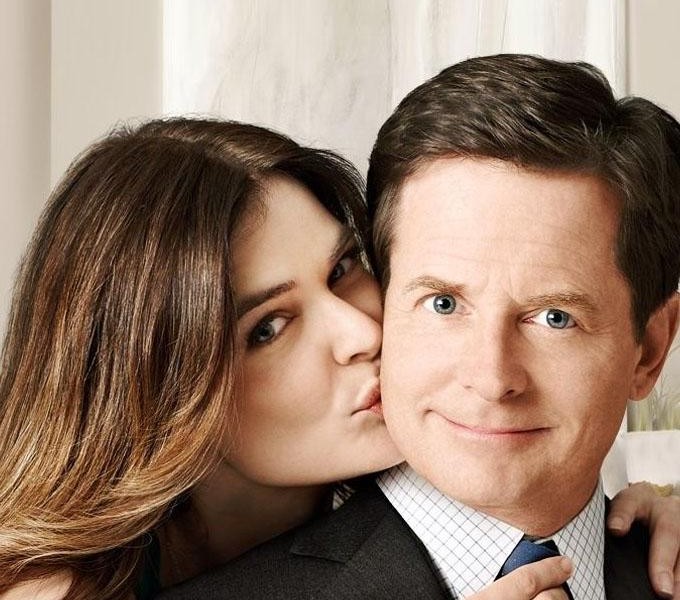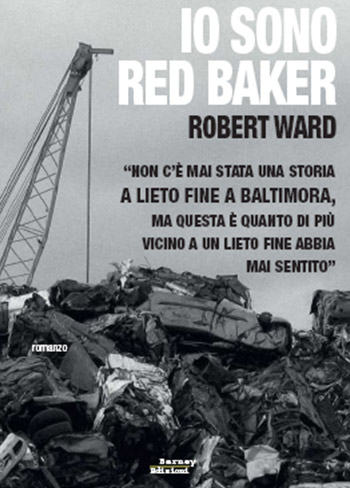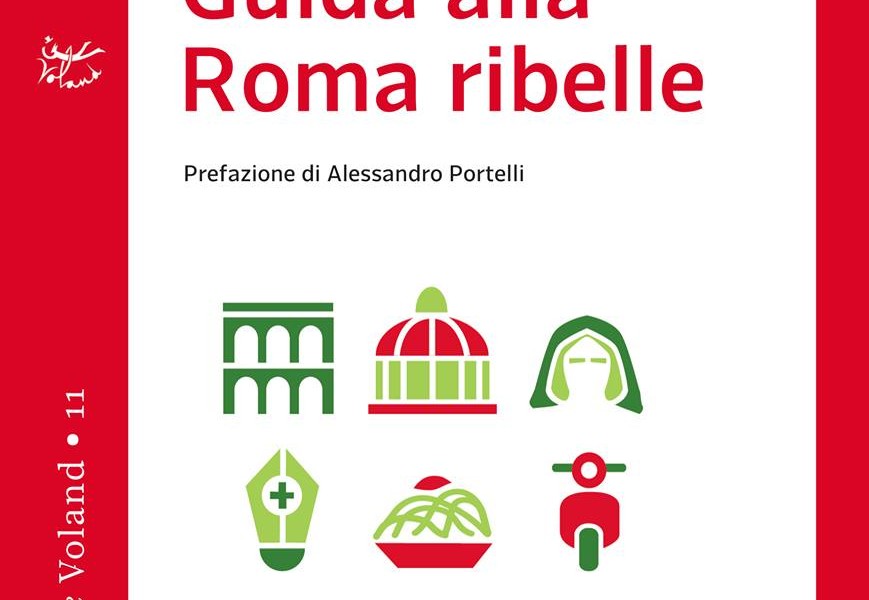Come molti lettori sanno, in un romanzo fortunatissimo, La cena, lo scrittore e giornalista olandese Herman Koch si era divertito (e il lettore con lui) a cavare perfidamente le unghie nella pasticciata carne psichica del borghese occidentale colto e annoiato e senza fiducia in alcunché propri eccentrici spassi a parte. Ora (ma in realtà il libro era stata scritta nel 2003, ben prima de La cena) Neri Pozza traduce con il titolo Odessa Star la sardonica storia di un uomo alle prese con un consuntivo della propria vita fallimentare – senza baloccarsi però in riflessioni noiose e penitenziali ma allestendo nei suoi momenti migliori una serie di quadri emblematici quanto divertenti della propria catastrofe.
Fred M., la voce narrante del romanzo, racconta la propria vita con brio sinistro e humour tarantiniano (Le Iene sono onnipresenti, ma in generale lo è l’immaginario cinematografico che catalizza le fantasie del protagonista – esso sembra fornirgli non solo un campionario di soluzioni estetiche alle proprie impasse ma persino un qualche perverso codice etico). Un registro medio-basso intrude la prosa di vicende corporali e scatologiche, lezzi di umani e bestie molto presenti, e già dall’incipit il libro sembra promettere pura azione procedendo per scene compatte che nei primi capitoli valgono come piccoli racconti in sé. Il narratore sciorina episodi grotteschi non di rado spassosi che testimoniano la sua inettitudine.
Via via la storia si ingarbuglia e c’è un motivo. Fred non ne può più dell’indifferenza un po’ malevola che gli riservano moglie e figlio: ai loro occhi è un fallito. E nemmeno degli strambi amici che lo circondano (presentatori televisivi, sedicenti fotografi, sfaticati dichiarati, tutti decisi e risoluti solo se si tratta di lamentarsi delle loro colf). Da un certo momento in avanti, a parte qualche soverchia insistenza metaforica, il rallentamento è dovuto al fatto che Fred non riesce a decifrare con certezza quello che gli succede. È entrato in scena Max, vecchio amico di scuola, ritrovato nel frattempo nei panni di un gangster molto cool. Fred ce lo ha già presentato all’inizio in un paio di prodigiosi flashback, ma ora si è messo mette in testa che Max possa dare una svolta alla sua vita. Di più, Fred è preda di una vera invasata attrazione per l’amico che gli compare in compagnia di una specie di guardia del corpo e belle donne. Gli pare che porti una luce seducente nel clima uggioso di Amsterdam che contribuisce a immalinconirlo. Eppure Fred (e con lui il lettore) impiega un bel po’ per capire che razza di scherzo Max gli stia preparato. Cominciano a succedere strane cose intorno a lui, come se qualcuno gli leggesse dentro e realizzasse i suoi desideri più riposti e macabri – compreso far sparire una vicina di casa sopportata a fatica.
Sa che di Max ha bisogno, che deve a ogni costo tentare il riscatto che lo riabiliti agli occhi stanchi della moglie e a quelli annoiati del figlio. Si tratta di avere il successo con cui tutti misurano il “valore” di tutti. Di acquistare la macchina migliore del mondo e una casa decente. La storia di Odessa Star è proprio il prezzo che Fred dovrà pagare per averle.
(Herman Koch, Odessa Star, trad. di Giorgio Testa, Neri Pozza, 2014, pp. 320, euro 17)