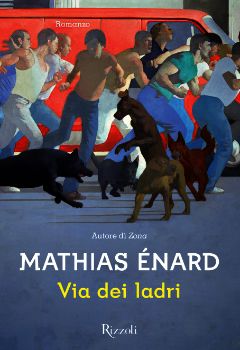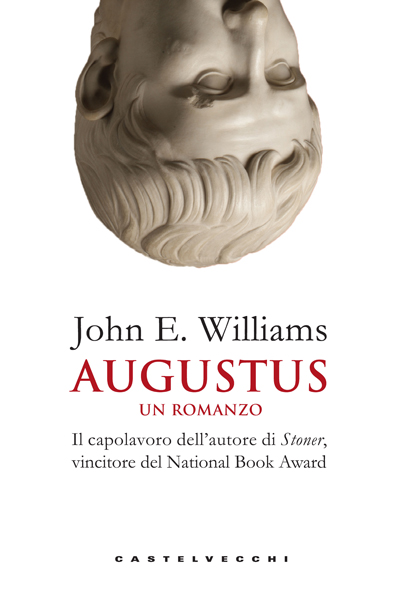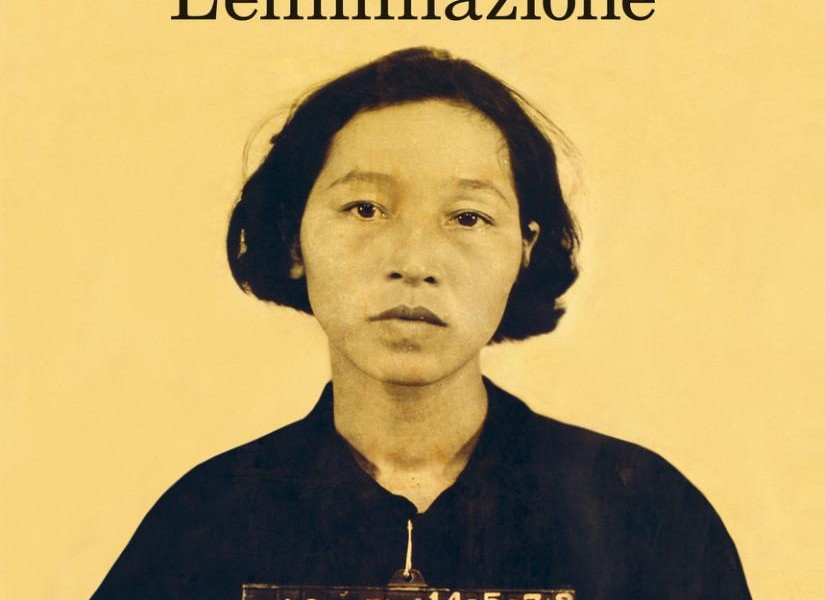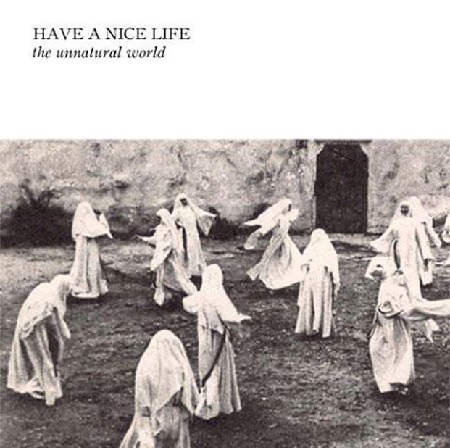Mark Lanegan, Has God Seen My Shadow? An Anthology 1989-2011
(Light In The Attic)
I fan di Lanegan non possono certo lamentarsi circa latitanza del loro eroe. L’ennesima uscita discografica dell’ex Screaming Trees non riguarda cover o duetti. Si tratta bensì di un’antologia: Has God Seen my Shadow? An Anthology 1989-2011. Più che valutare e criticare le scelte della tracklist del primo disco (nel secondo ci sono delle gustose rarità), l’opera va vista come un ottimo mezzo per gettare un amplio sguardo sull’oscura e affascinante carriera solista di Mark Lanegan. Da mettere sull’iPod.
St. Vincent, St. Vincent
(Loma Vista Universal)
Signore e signori, ecco a voi il capolavoro di St. Vincent. Dopo il duetto-consacrazione con David Byrne, il suo nuovo e omonimo album solista sancisce il definitivo apice della carriere dell’icona femmine della musica indie. Elettronica su chitarre massacrate per una sequela di brani in cui la nostra eroina declama una performance ispiratissima dietro l’altra. Superbo. Come il nuovo look.
The War On Drugs, Lost in the Dream
(Secretely Canadian)
Facile sfruttare il titolo per descrivere il terzo disco dei The War On Drugs. Formatosi nel 2005, in Pennsylvania, la band è ormai pronta per essere promossa a pieni voti. Anche se non li avete mai sentiti nominare – cosa possibilissima – i rockers americani hanno sfornato il classico disco che non lesinerà di ampliare il loro bacino di estimatori e fan. Bastano i nove minuti dell’iniziale “Under the Pressure” per capire che il livello è alto. E tra momenti più onirici e passaggi più massicci e rock, la qualità non si abbasserà mai. Non fate l’errore di non ascoltarli.
Pixies, Ep 2
Avevamo chiuso qualche mese fa augurandoci un secondo Ep migliore del primo sfornato dai Pixies. Sapete, essendo dei miti, il loro ritorno era circondato da attese e aspettative a dir poco alte. Bene, purtroppo, anche stavolta i quattro brani che pongono la seconda uscita direttamente fruibile da sito della band deludono a dir poco. Conviene, a questo punto, aspettare il tre?
The Baseball Projects, 3
(Yep Roc, Audioglobe)
Possono convivere musica e sport? Può un artista indie fare dei dischi sul baseball? La risposta è si, se a muovere le trame c’è quel piccolo grande eroe dell’underground americano chiamato Scott McCaughey. Membro aggiunto dei R.E.M. (è quello che nei live non si stacca di un passo da Peter Buck), leader degli Young Fresh Fellows e soprattutto dei mitici Minus 5. Ad accompagnare questo progetto ci sono proprio Buck e Mills, basso e chitarra dei R.E.M., a chiudere una formazione che vede la batterista Linda Pitmon e Steve Wynn. 3 è composto quindi di diciassette gradevolissimi brani rock in cui il baseball la fa da padrone, ma non così tanto da precludere l’ascolto a chi di questo sport non gliene frega nulla. E pensate che in alcuni brani ci sono come guest dei giocatori veri e propri!
Bologna Violenta, Uno Bianca
(WoodwormWallace)
Un disco che nel giro ha generato qualche polemica. Può un band trattare in un album dei fatti di cronaca che hanno causato spargimento di sangue? Si può fare musica parlando di ferite di cronaca ancora aperte? La domanda – e l’annessa risposta positiva – se la sono data i Bologna Violenta. Nicola Manzan, ideatore ed esecutore del progetto, dopo il periodo “alla Calibro 45”, decide di invischiare fino al midollo la sua musica nei fatti che dal 1987 al 1994 provocarono ventiquattro morti nella zona di Bologna. Appunto. Ventisette brani che ricostruiscono in maniera fredda e spietata quei fatti neri. Un lavoro che divide, e di questi tempi, ci sentiamo di dire: Fortunatamente!
Neil Young, Pono
No, tranquilli, non è il suo nuovo disco, ma una sorpresa! Stufo dell’Mp3 e di come secondo lui abbia rovinato la fruizione e la qualità musicale contemporanea, Mr. Young fa sbarcare Pono. Ovvero un lettore musicale ad altissima fedeltà supportato da file Flac. Dopo il successo del finanziamento tramite campagna Kickstarter, supportato da guest come Springsteen e Arcade Fire, il lettore di musica digitale progettato da Neil Young promette di fare una rivoluzione. Anni fa lo propose a Steven Jobs…