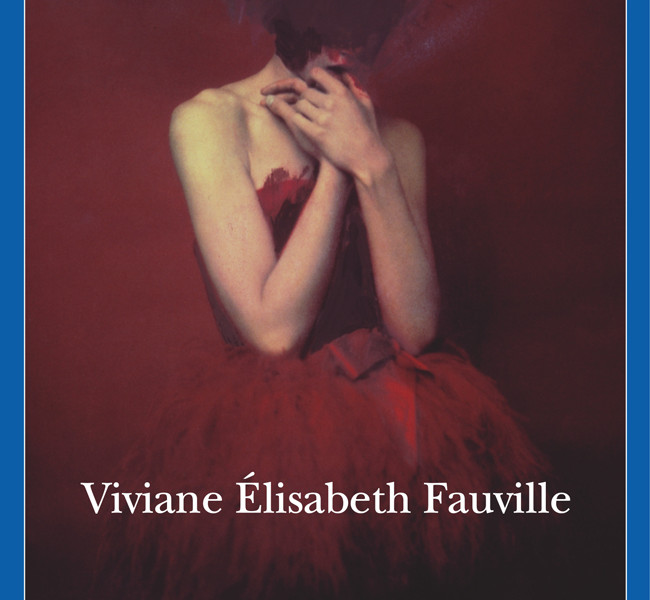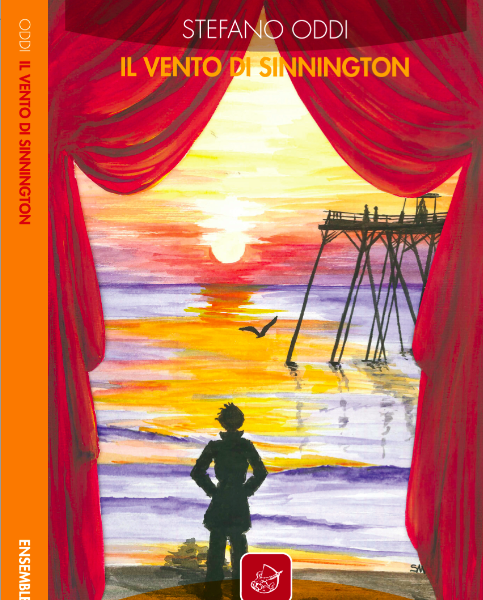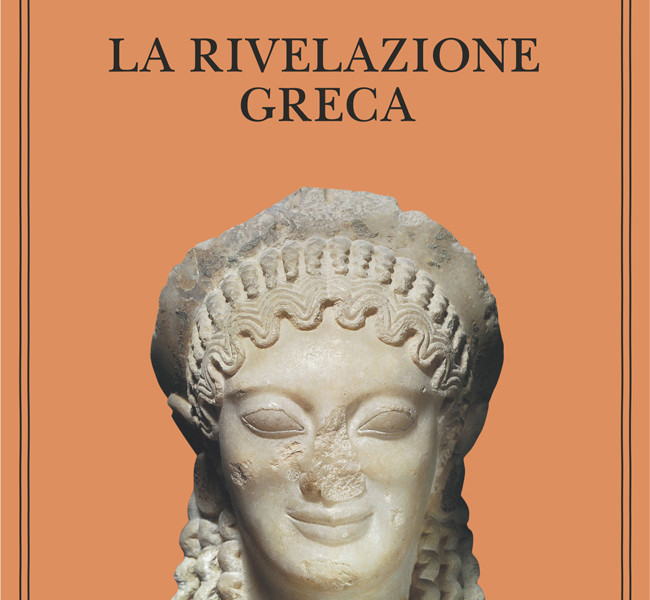«Ti chiami Viviane Élisabeth Fauville, in Hermant. Hai quarantadue anni e il 23 agosto hai dato alla luce la tua prima figlia, che molto probabilmente rimarrà anche l’unica. Sei la responsabile della comunicazione della Bétons Biron, un’azienda con un alto fatturato che ha sede in un edificio di otto piani in rue de Ponthieu, a due passi dagli Champs-Élysées. […] Tuo marito, Julien Antoine Hermant, ingegnere del Genio Civile, è nato a Nevers quarantatré anni fa. È stato lui, il 30 settembre, a mettere fine a due anni di incubo coniugale».
Viviane Élisabeth Fauville (Adelphi, 2014) della scrittrice esordiente Julia Deck, caso editoriale in Francia, è un’immersione nell’oceano oscuro dell’inconscio della protagonista, un noir psicologico dal fascino inusitato e sinistro.
Il successo di questo romanzo risiede senza dubbio nella struttura narrativa. L’alternarsi fra la prima persona, che dà forza di io narrante a Viviane rivelandone i sentimenti, e la terza persona di un narratore onnisciente super partes che rende oggettivi i personaggi, è spezzato dall’uso insolito della seconda persona, plurale in francese, quel “voi” delle conversazioni formali che i traduttori Lorenza Di Lella e Giuseppe Girimonti Greco hanno reso in italiano al singolare per dare quell’oggettivo distacco con cui l’autrice guarda Viviane, un po’ avvicinandola, un po’ respingendola senza mai cedere alla tentazione di esprimere un giudizio moralista, memore della lezione dostoevskijana di Delitto e castigo.
Lo stesso alternarsi dei due nomi, Viviane ed Élisabeth, nel corso dei capitoli rivela una personalità sdoppiata, psicologicamente dissociata.
La mente di Viviane ci restituisce frammenti, scene isolate. Si presenta al lettore mentre su una sedia a dondolo culla la figlia di tre mesi, con la sgradevole sensazione però «di aver fatto, quattro o cinque ore fa, qualcosa che non avresti dovuto fare».
Viviane è una donna fragile e per questo da quando è stata abbandonata dal marito è in cura da uno psicanalista. Questi le fa sempre domande che la infastidiscono. Ora però anche lui l’ha lasciata sola. Non perché ritenesse la sua paziente clinicamente incurabile, ma perché messo a tacere per sempre da una ferita mortale da arma da taglio proprio quel giorno, il 16 novembre, in cui Viviane presa da una crisi, gli aveva chiesto un appuntamento urgente.
Viviane, scossa, ricostruisce allora le ore precedenti alla sua visita: il leggero e ricorrente malore, la telefonata al dottore, il passaggio a casa del marito per prendere alcune cose tra cui il set di coltelli regalatole dalla madre per il matrimonio, la conversazione irritante con l’analista Jacques Sergent, il sangue.
Viviane, convinta di esserne l’assassina, lascia ora il posto a Élisabeth, la quale avvia una serie di sconclusionate e personali indagini pedinando la moglie del dottore e l’amante e altri pazienti sospetti.
È la morte del suo psichiatra a minare l’unità di un io già così instabile e farne esplodere le rimozioni. Alcune domande spontaneamente sorgono nel lettore avvinto da una tensione tutta staticamente psicologica: la separazione dal marito in una mente così permeabile sarà causa o effetto di tale evento?
Viviane sembra vivere in perenne stato confusionale. Prima ancora che madre è figlia. L’arma presunta del crimine le è stata regalata dalla madre. Ma la madre è morta lasciandole un appartamento in un bel quartiere di Parigi.
«E lei non chiede di meglio, mettere un po’ d’ordine nella sua memoria. Solo che i fatti, invece di venire alla luce, precipitano in un pozzo sempre più profondo.
Senza più un passato prossimo, si rifugia in quello remoto, si ricorda della madre che non ha né inizio né fine, che è impossibile datare quale che sia il metodo utilizzato, carbonio-14 o introspezione».
Solo la maniacale descrizione delle strade della capitale francese, che la protagonista percorre passando dagli arrondissement alto-borghesi ai bazar e negozi di immigrati di Gare de l’Est, fino a rue Louis-Blanc con i venditori di sigarette di contrabbando e caldarroste, sembra l’unico argine fisico alla follia delirante di Viviane. Ed è una metropoli tutt’altro che romantica, coperta com’è da una pesante coltre di neve, metafora dell’ottundimento della mente.
Nel frattempo le indagini della polizia proseguono parallele a quelle di Élisabeth, che non fa niente per non far convergere i sospetti su di lei. Ma nessuno in realtà la prende sul serio, anzi viene percepita come una «cosa da scansare», sola e abbandonata, con una bambina piccola come unico appiglio: «Una nuvola di polvere ti sale al cervello. Ti provoca un’immediata sudorazione, ti fa tremare le dita. Sull’orlo di un mancamento, ti aggrappi alla bambina perché ti impedisca di cadere. La bambina si rivela all’altezza della situazione».
Viviane Élisabeth Fauville è un noir in cui il vero nodo da sciogliere, il caso da risolvere non è tanto un omicidio quanto ritrovare una lucidità perduta che dia ordine a un quotidiano beckettianamente assurdo con colpo di scena finale.
(Julia Deck, Viviane Élisabeth Fauville, trad. di Lorenza Di Lella e Giuseppe Girimonti Greco, Adelphi, 2014, pp. 129, euro 15)