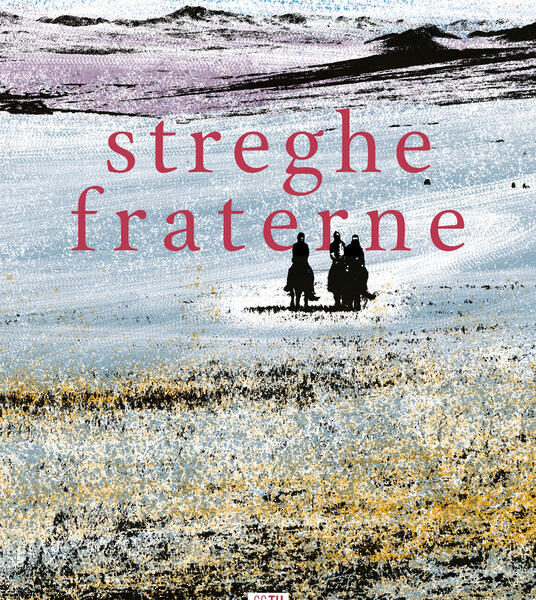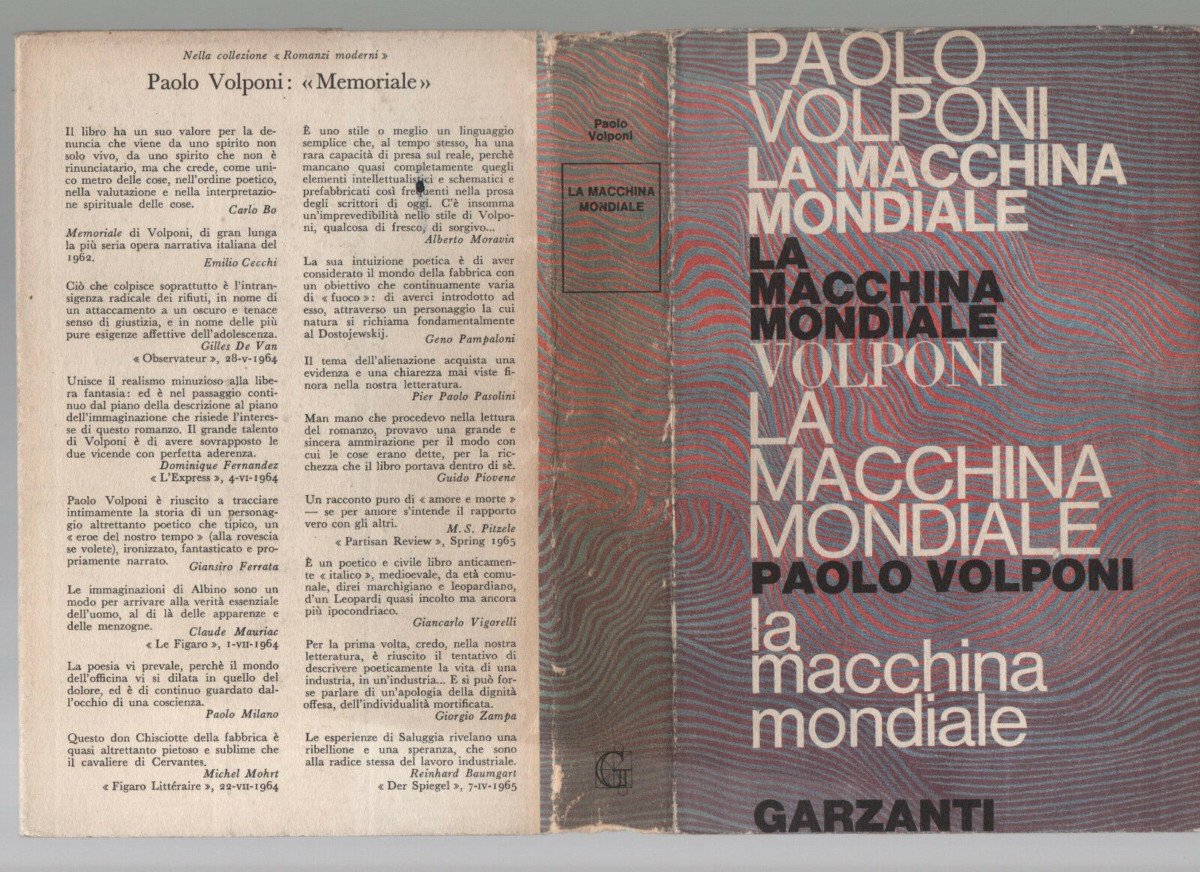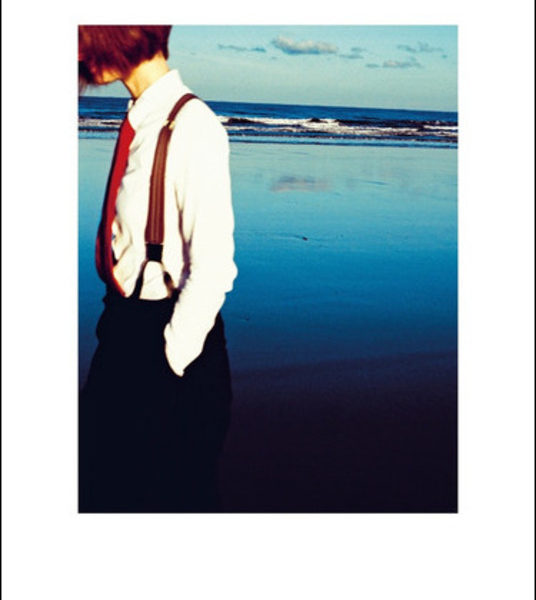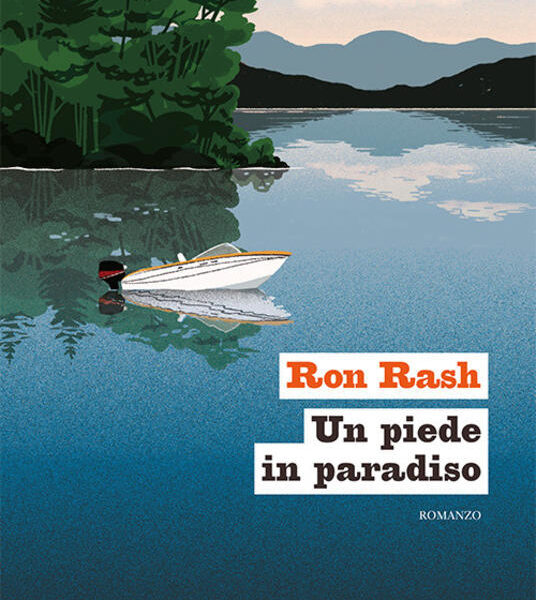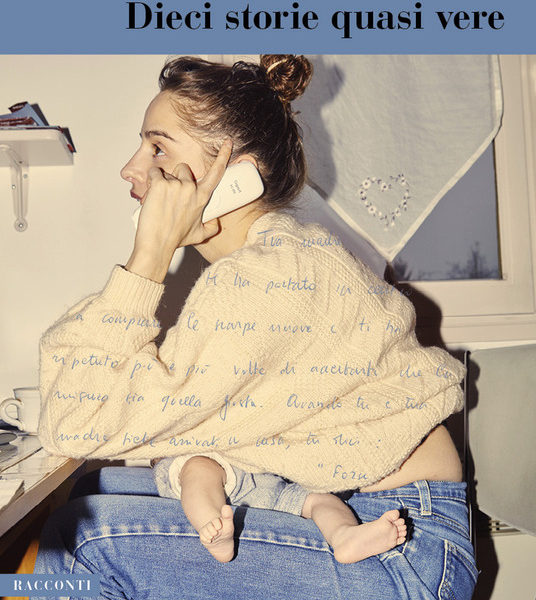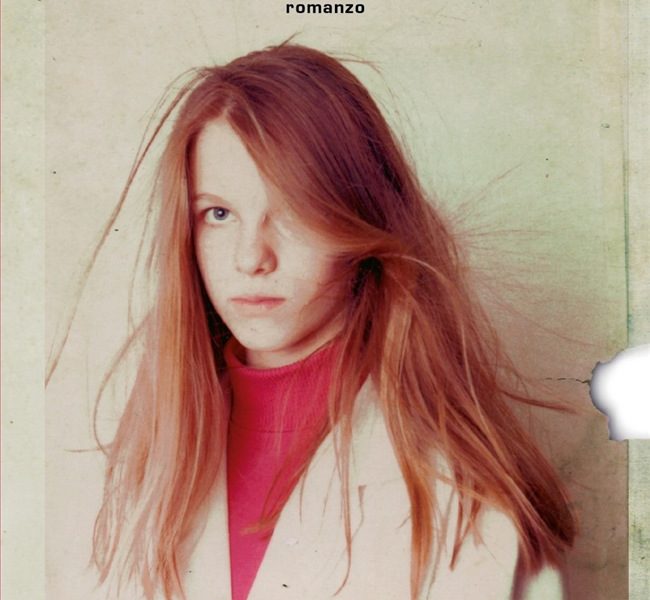Ci troviamo di fronte all’ennesima estate strana, fatta di desideri di fuga e ansie da pandemia. Ma che partiate o che restiate a casa, i libri sapranno sempre darvi la risposta giusta. Per questo abbiamo deciso di tornare con i nostri consigli di lettura per le vacanze. Una lista di libri decisamente variegata che possa servirvi quantomeno per distrarvi un po’ da nuovi decreti e vecchie minacce di chiusure a colori.
Niccolò Amelii
I mesi estivi sono per me, lettore compulsivo ma sistematico, mesi un po’ anarchici, votati spesso a ripescaggi, contaminazioni e accostamenti disorganizzati e intuitivi. Mi sistemo davanti alla pila sempre crescente dei libri accumulatisi nei mesi precedenti, scosto via il sottile strato di polvere sedimentatosi sulle copertine e mi lascio guidare dalla curiosità del momento e dalla voglia di essere almeno per qualche settimana dedito a letture puramente disinteressate (non legate dunque prettamente a ragioni lavorative). Ecco allora, in ordine sparso, i libri che terrò a portata di mano, tra il comodino e la borsa da mare: tra le uscite più recenti due libri che mi incuriosiscono per lo stile e la tematica, Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata di Raphael Bob-Waksberg (Einaudi), raccolta di racconti che mette al centro l’amore e le sue sfaccettate declinazioni contemporanee, e Spatriati di Mario Desiati (Einaudi), storia generazionale di chi è o si vorrebbe sempre altrove (fisicamente e mentalmente) nel tentativo di ridefinire la propria fisionomia e la propria identità irrisolta. Tra i recuperi cronologicamente più lontani nel tempo, le mie scelte sono ricadute invece su La città degli untori di Corrado Stajano, radiografia narrativo-giornalistica di una Milano oscura e impensata, pubblicato nel 2009 da Garzanti e poi riproposto da il Saggiatore, e su America amore di Alberto Arbasino (Adelphi), volume di quasi novecento pagine che affronterò a poco a poco con rapide, sconnesse quanto goduriose incursioni, accompagnando la prosa mirabile di Arbasino e i suoi finissimi ritratti americani magari con un gin tonic da bere rigorosamente al tramonto.
Claudio Bello
Ad agosto mi piace lasciarmi ossessionare da qualche autore ossessivo. Quest’anno, come già ripeto da un po’ a qualche amico altrettanto nerd, voglio passare un’estate post-esotica, dedicarmi cioè alla lettura di Antoine Volodine. Penso che comincerò con Terminus radioso (66thand2nd), un libro visionario ambientato in un mondo contaminato e in preda alla catastrofe (perché non è vero che l’estate è tutta allegria. Bisogna rivalutare la malinconia dell’estate). In realtà sono anche fatalmente tentato da Vorrh di Brian Catling (Safarà), che parla di un’enorme foresta viva e labirintica, e mi sembra un trionfo del new weird (che è stato la mia ossessione dell’inverno). Voglio anche dedicarmi alle raccolte di racconti, però, perché leggerle d’estate è un grande piacere (ma in realtà lo è anche in tutte le altre stagioni). Per ora ho tre idee: Le visionarie (Not, a cura di Ann & Jeff VanderMeer), Novena di Marco Marrucci (Racconti edizioni) e Storie dell’arcobaleno di William T. Vollmann (minimum fax). Probabilmente li ficcherò in valigia tutti e tre. Di certo non rinuncerò a un saggio: pensavo ad Allucinazioni americane (Adelphi), il libro che Roberto Calasso ha dedicato a Hitchcock. Infine, una mia personale tradizione: ogni estate leggo un libro di Stephen King, e questa volta si tratterà di Le notti di Salem (Sperling & Kupfer), una magistrale storia di paura con vampiri e case stregate.
Giovanni Bitetto
Questa estate, complice alcuni concorsi pubblici in cui sono andato a impelagarmi, non avrò molto tempo per leggere. Dunque immaginerò un me ipotetico che, come ogni agosto che si rispetti, passi le ore pomeridiane dondolando su un’amaca di una qualche fazenda pugliese. La mia proiezione rispetterà un certo gusto per le belle lettere portandosi dietro Fifty-fifty (TerraRossa edizioni), primo volume di un dittico di Ezio Sinigaglia, valente penna manierista riscoperta negli ultimi anni dall’alacre lavoro di Giovanni Turi e Giuseppe Girimonti Greco. A ciò, quel me infastidito dal caldo, aggiungerà le sfuriate di Teatro VI, sesto e conclusivo volume dell’opera teatrale di Thomas Bernhard, recentemente edito da Einaudi. Ricordandosi poi che bisogna pur interessarsi dell’oggi, l’avveduto ectoplasma sfoglierà (finalmente in italiano!) Cyclonopedia (Luiss University Press), caposaldo della theory fiction di Reza Negarestani, e Cosmotecnica (Nero edizioni), intrigante saggio sulla questione tecnologica in Cina per mano di Yuk Hui – due ottimi libri per accreditarsi in ambienti ketamina&lotta di classe. Infine, quel pigro impostore si tufferà in territori adelphiani ripescando La Gran Bevuta, primo romanzo del mistagogo René Daumal, e Lettere II, secondo volume delle lettere di Samuel Beckett che ripercorre gli anni della guerra. Saziato da questa scorpacciata si avvicinerà a me, chino su infinite sillogi di quiz a risposta multipla, e mi ringrazierà con sorriso sornione. Inutile dire che la risposta non è qui riportabile.
Elisa Carrara
«Amiamo stupirci, come i bambini, ma non troppo. Quando lo stupore c’imponga di uscire veramente di noi stessi, di perdere l’equilibrio per ritrovarne forse un altro più arrischiato, allora arricciamo la bocca, pestiamo i piedi, davvero ritorniamo bambini». Scriveva così Cesare Pavese in un articolo pubblicato nell’estate del 1945 su L’Unità di Torino: si intitola Leggere e racchiude tutto ciò che, secondo me, si dovrebbe sapere poco prima di aprire un libro. Ho sempre ammirato chi è in grado di fare liste, progetti, chi decide cosa e quando leggere, senza lasciarsi distrarre: da tempo ho accettato, con una certa ostile arrendevolezza, che il caso governa le nostre scelte più di quanto immaginiamo. Perciò la mia unica certezza, in quest’estate offuscata, sarà affidarmi alle parole altrui: ossia cercare letture capaci di far «perdere l’equilibrio», di stravolgere non il mondo, che ha lo straordinario potere di rimanere sempre uguale a sé stesso, ma il modo di vedere le cose. Letture distanti dall’amore ingiustificato per l’ordine, per l’equilibrio, per le simmetrie dilaganti. Spero, allora, di perdermi nel pensiero di Edgar Morin, del quale ho letto ancora troppo poco, di riconciliarmi con la forza del cinema (attraverso la rilettura di alcuni classici e di altre novità), di recuperare la visione di Todorov, e quella, ancora sconosciuta, di Iris Murdoch. E, infine, di scovare saggi e reportage narrativi che mostrino luci e ombre del nostro passato e del nostro presente.
Francesca Ceci
In un’estate nuovamente incerta, in cui non si progetta troppo per non essere smentiti, non si parte troppo per non illudersi eccessivamente, una piccola forte certezza rimane la libertà di poter leggere comunque e dovunque.
Senza un vero e proprio programma di lettura e senza sapere dove esattamente arriveranno, i libri in vista sono sempre quasi troppi, estivi e non, ma destinati loro malgrado a questo periodo. Tra i tanti in attesa c’è Quaderno dei fari di Jazmina Barrera (La Nuova Frontiera), che promette un percorso tra le coste e le scogliere per allontanarsi da se stessi; c’è Latte arcobaleno di Paul Mendez (Atlantide edizioni), che inizia con un boxeur giamaicano nell’Inghilterra degli anni cinquanta e che fin dalla sinossi fa pensare a James Baldwin. E poi c’è un libro che tutto sembra tranne una leggera lettura estiva ma di cui ho sentito tanto parlare in questi mesi, tra riviste e podcast, che forse in un momento controcorrente come è l’estate troverò il coraggio di iniziare: Se la morte ti ha tolto qualcosa tu restituiscilo (Utopia) della poetessa danese Naja Marie Aidt.
Daniele De Cristofaro
Di solito nelle mie letture sono abituato ad alternare un saggio a un romanzo, giusto per tenere la mente un po’ attiva da un lato e distenderla dall’altro. Penso proprio che anche per questa estate non farò eccezione, perciò i miei consigli di lettura seguiranno per lo più questo personale parametro.
Partirei col raccomandare, per quanto riguarda la saggistica, un libro che ho amato molto ai tempi dell’università e che rileggerei molto volentieri: Geometria delle passioni (Feltrinelli) del filosofo Remo Bodei, illustre accademico nonché persona dotata di straordinaria umiltà, scomparso purtroppo da due anni. Saltando poi al romanzo, sempre in tema di riletture, non mi dispiacerebbe riprendere in mano Tropico del Capricorno(Mondadori) di Henry Miller, lettura anch’essa un po’ datata, risale infatti ai tempi del liceo e che fu per me come una vera e propria folgorazione: dopo quello del Cancro, infatti, concentrato più sul piano narrativo-biografico, Tropico del Capricorno regala anche suggestive riflessioni filosofiche. Dalla citazione di un personaggio come Henry Miller alla connessione con la figura dell’outsider il passaggio è breve e quasi obbligato, e mi riporta a un altro saggio che vorrei consigliare: L’Outsider di Colin Wilson (Atlantide). Infine concludo citando il romanzo di un autore che sono sicuro non mi deluderà: Schiavo d’amore di Somerset Maugham (Adelphi), di cui ho potuto apprezzare la fluida prosa già con Il filo del rasoio e con Acque morte, sempre editi da Adelphi.
Dario De Cristofaro
«L’uomo è un animale viaggiante», così iniziava un libro di Manganelli che consigliavo qualche anno fa (Cina e altri Orienti, ndr). Faccio mio ancora una volta questo enunciato e mi appunto i libri che porterò con me questa estate. Moby Dick di Herman Melville è una certezza da rileggere; terminato questo leggerò sicuramente Alabama di Alessandro Barbero (Sellerio) e Quando vi ucciderete, maestro? di Antonio Franchini. In questi giorni ho comprato anche Contro l’impegno di Walter Siti (Rizzoli), Opera aperta di Umberto Eco e L’arte della guerriglia di Gastone Breccia (il Mulino), con cui concluderò le mie letture estive.
Daria De Pascale
Il 2021 è cominciato come un anno di scoperta: mi ritrovo, quasi sempre per caso, ad avvicinarmi a territori (purtroppo al momento solo letterari) che fino a poco tempo fa mi erano del tutto estranei, per cui non avevo mai provato interesse. Scopro nomi, luoghi, fascinazioni nuove, ed è con questo spirito che metto insieme una lista di possibili letture estive, sempre pronta a lasciarmi trascinare altrove da altre casualità.
Dopo un intensissimo mese insieme a 2666 di Roberto Bolaño (Adelphi), continuerò a esplorare un po’ a tentoni il mondo sudamericano con L’occasione di Juan José Saer (La Nuova Frontiera) e Andarsene di Rodrigo Hasbún (Sur). Farò poi un lungo viaggio fino alla Finlandia – dove l’anno, appunto, è iniziato –, per scoprire Fair Play di Tove Jansson (Iperborea), e mi aspetto già di trovare lì nuove ragioni per fermarmi, mandando all’aria ogni piano di lettura. Nonostante tutto, cercherò però di mantenere dritta la barra e seguire le due direzioni di lettura più costanti di questo periodo: l’editoria, con Cose da fare a Francoforte quando sei morto di Matteo Codignola (Adelphi), e ciò che si muove tra il new weird e la theory fiction, recuperando finalmente Ballardismo applicato di Simon Sellars (Nero edizioni).
Giulia Eusebi
Mai come in questo agosto ho necessità di intraprendere dei viaggi: fisici, metafisici, mentali. La scelta delle mie letture estive è quindi ricaduta su una triade che mi dia la possibilità – o almeno questo è l’auspicio – di studiare itinerari, scoprire nuove strade, ritornare in luoghi conosciuti per guardarli da una diversa prospettiva e, non ultimo, di fare incontri e ascoltare storie.
Parto con Un weekend postmoderno. Cronache dagli anni Ottanta di Pier Vittorio Tondelli per una necessità di ripercorrere il passato recente della provincia italiana attraverso quello che l’autore stesso definisce «un viaggio, per frammenti, reportage, illuminazioni interiori, riflessioni, descrizioni partecipi e dirette, nella parte degli anni Ottanta più creativa e sperimentale».
Il viaggio prosegue con Nella foresta delle metropoli di Karl-Markus Gauss, perché sono rimasta affascinata dalla definizione che Ilma Rakusa ha fatto del libro, ovvero «una cartografia biografica dell’Europa». Un modo nostalgico di esplorare, di entrare in contatto con i luoghi e le persone che li hanno vissuti.
E dopo aver viaggiato nel Vecchio continente, vorrei avventurarmi in mare, portando con me Quaderno dei fari di Jazmina Barrera, per apprendere le storie che si celano dietro questi giganti romantici, guardiani della terra e delle acque, che hanno affascinato scrittrici e scrittori. Una sorta di portolano letterario e spirituale che mi accompagni nel viaggio e che mi permetta sempre di trovare un porto in cui approdare.
Martin Hofer
Questa estate è iniziata all’insegna delle città letterarie, prima con la lettura di Super-Cannes di J.G. Ballard (Feltrinelli), poi con la rilettura ad alcuni anni di distanza di L’altra parte di Alfred Kubin (Adelphi), entrambi consigliatissimi. Per il mese di agosto ho la possibilità di pescare da una bella pila di provviste accumulate nelle ultime settimane: ci sarà senz’altro spazio per Padre Occidentale (effequ), l’opera seconda di Simone Lisi, e magari anche per il recupero di Terminus Radioso di Antoine Volodine (66thand2nd) e di Necropolis di Giordano Tedoldi (Chiarelettere).
Luigi Ippoliti
Cercherò di essere il più razionale possibile, evitando progetti di lettura irrealizzabili: per festeggiare l’Europeo appena vinto, ho già sul comodino il libro di Stefano Piri Italia-Francia, l’ultima notte felice (66thand2nd). Poi, visto che ho appena terminato Tre millimetri al giorno di Richard Matheson (che vi consiglio), continuerò con la fantascienza e mi butterò sul suo grande classico Io sono leggenda. Infine, per forza di cose, terminerò quest’estate con Due vite di Emanuele Trevi. Con questi tre libri dovrei stare tranquillo, anche se la tentazione di leggere quel vecchio amore giovanile che è Palahniuk mi porterà dritto al suo nuovo L’invenzione del suono (Mondadori). Vediamo.
Giuseppe Maria Marmo
L’estate con tutto il carico di bilanci e riconciliazioni che si porta dietro è una valanga che ci soverchia tra un bagno e l’altro. Quindi per una sana dose di leggerezza con ghiaccio sto cercando di scovare in tutti i mercatini dell’usato un libro fantasma scritto da Umberto Eco e Roberto Leydi nel 1961, dal titolo Shaker. Il libro dei cocktail (Pizzi Editore); un allegro, colto e ironico volume sull’arte della mixologia, dove sardonicamente il giovane semiologo, allora ventinovenne, ci illustra con dovizia di particolari la ricetta per produrre nella vasca da bagno un buon gin speziato. Nell’attesa e con la speranza di trovare questo piccolo tesoro porterò con me il primo romanzo di Tommaso Landolfi, La pietra lunare(Adelphi), un testo immaginifico nel quale l’incontro tra città e provincia, convenzione sociale e irrazionalità del mito, viene scaraventato nel tumulto dell’iniziazione erotica. Città aperta di Teju Cole (Einaudi) sarà sicuramente la mia seconda lettura estiva; un romanzo che con la sua marcata componente esplorativa ricorda in qualche modo lo stato d’animo che accompagna questa stagione di novità e cambi di rotta. Lo sguardo dell’eroe sembra essere quello di chi d’estate scruta un posto o una situazione per la prima volta; uno sguardo delicato e profondo che raccoglie impressioni e rivela i nostri confini. Tra i libri che ho messo in valigia c’è anche Piranesi (Fazi Editore) di Susanna Clarke; romanzo fantasy inusuale dove il protagonista abita in una sorta di palazzo labirintico da cui non esce mai. Un testo che subisce l’influenza di grandi classici della letteratura come La biblioteca di Babele di Borges e Aspettando Godot di Beckett ma che si rifà anche al mito della caverna di Platone. Infine ho deciso di dedicarmi alla rilettura di Solo (Carbonio), un racconto lungo di August Strindberg, nella nuova traduzione di Franco Perelli, in cui il protagonista attraverso il faticoso ma necessario esercizio della solitudine osserva con elegante realismo la propria trasfigurazione morale.
Giovanna Nappi
I libri scelti per il periodo estivo sono per me sempre all’insegna dei grandi ritorni. In prima linea quello – attesissimo – in libreria di Mario Desiati, con Spatriati, da poco pubblicato da Einaudi: autore ormai già portavoce di più di una generazione di ragazzi e ragazze, erge a protagonisti i cosiddetti «spatriati», i senza patria, cittadini del mondo che a fatica, ancora oggi, vengono inquadrati in categorie socialmente accettate. Sarà poi la volta di A volte una bella pensata di Ken Kesey, autore di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Quasi novecento pagine alla scoperta dell’America, nel cuore dell’Oregon, dove scoppia una rivolta sindacale tra le file degli operai dell’industria del legno. È questo lo spunto per ricreare personaggi già definiti «indimenticabili», tra paesaggi maestosi ed epopee familiari che tornano finalmente in Italia dopo cinquantasette anni grazie a Black Coffee. Ultimo volume della tornata estiva di letture, Panico di James Ellroy. Per inquadrarlo basterebbero poche parole: fumo, alcol, violenza, una città che marcisce; tra queste coordinate, in una Los Angeles degli anni Cinquanta, un ex poliziotto si ritrova in scandali e complotti più pericolosi di quanto avrebbe voluto.
Gabriele Sabatini
Libro da spiaggia, ma solo perché si presenta sotto l’intreccio di brevi biografie, comode da leggersi fra un bagno e un gelato (rigorosamente in quest’ordine per evitare congestioni), Disorganici. Maestri involontari del Novecento di Filippo La Porta: una enciclopedia portatile di figure con cui occorre trovare la giusta confidenza se si prova a capire il secolo passato e interpretare il tempo presente. Fra loro manca però Leone Ginzburg, sulle cui Lettere dal confino tornerò certamente in ogni spostamento fino a settembre; un po’ perché i carteggi sono sempre appassionanti (salvate e stampate mail e chat, i nipotini vi ringrazieranno), un po’ perché da qualche tempo penso a come sarebbe stata l’Einaudi degli anni Cinquanta se lui fosse sopravvissuto alla violenza nazifascista. E se poi alla fine di agosto mi dovessi rendere conto di aver speso troppo (e succederà), potrei attingere alla Teoria dei sentimenti morali per ricordarmi, attraverso le amene pagine di Come Adam Smith può cambiarvi la vita di Russ Roberts, che il denaro forse non è tutto.
Cristiana Saporito
Quest’anno mi sono infatuata della tarologia. Precisiamo subito, non intendo propinarvi interattivi in diretta sul ritorno del partner animico né snocciolare drappelli di arcani maggiori, con spolverate di oracoli della Sibilla. Sarebbe bello, ammetto, ma non lo farò. Però questa passione ancora in stato fetale mi ha già trasmesso una traccia lampante, che è quella che vorrei condividere, in stile lanterna cinese spedita tra i nembi. Nulla di quello che accade, accade e basta. Si verifica perché esiste un motivo. Perché i nostri pensieri ci traghettano ovunque. Ovviamente anche davanti a un libro.
Quindi vi propongo un gioco: davanti ai vostri scaffali o a quelli di una libreria, avvicinatevi e inspirate. Poi, lasciatevi attrarre. A me è successo di totalizzare un bottino da corredo matrimoniale.
Qualcosa di nuovo. Qualcosa di vecchio. Qualcosa di prestato. Qualcosa di azzurro. Qualcosa con cui partire e per cui restare impigliati. Ecco quello che deborda dal bagaglio:
Il cielo è dei violenti di Flannery O’Connor (vecchio, minimum fax): qui siamo di fronte all’immensità. Ed è normale supporre di trovarsi spaesati. Enormità di una scrittrice mai abbastanza letta e sempre pronta a spiazzarci. Storia fitta e bruciante di Francis Marion, orfano di quattro anni rapito dal suo prozio ultrareligioso e intenzionato a farne un uomo di puro spirito. A 14 anni Francis riapproda a casa con una missione addosso. E un grumo di nodi contro cui schiantarsi. Non c’è molto da aggiungere. Se non il brutale, impagabile impatto. Con i crateri insaziati della legge interiore.
I mostri del mare di Chloe Aridjis (nuovo, Playground): amate i romanzi di formazione? Quelli da evento spartiacque, che in un’estate, un viaggio, condensano il senso labile e cocente dell’esistere? Quelli del prima e del “mai più come prima”, dell’inesausto crescere cercando? Allora spiaggiatevi tra queste pagine. Tra i relitti di Luisa e la sua insofferenza. Il tutto fatalmente condito da mareggiate di new wave anni Ottanta. Per me un richiamo irresistibile.
La vita segreta delle api di Sue Monk Kidd (prestato, Mondadori): se una parte di voi, più o meno consapevolmente, agogna una rinascita, orbitate intorno al titolo giusto. Lily non può vantare nessuna credenziale per essere felice, con un padre che la imbottisce di lividi e una madre morta forse prima di poterla amare. Eppure palpita un riscatto. Tra le carezze della sua governante e le geometrie di un insetto magico. Delizia di un mistero nascosto nel minuscolo.
Gli affamati di Mattia Insolia (prestato, Ponte alle Grazie): romanzo potente, sul disagio insanabile di due fratelli. Antonio e Paolo vivono in bilico nell’equilibrio di vetro che hanno costruito per loro. Ma il passato scuote la pelle delle loro abitudini, le trova sguarnite a lasciarsi ferire. Come noi che leggiamo questa lingua fendente.
E il suo mosaico di solitudini.
La simmetria dei desideri di Eshkol Nevo (Blu e universale, Neri Pozza): questo, signori, è il libro perfetto. Per chi? Per chiunque abbia un amico. E sappia e sperimenti cosa vuol dire tradire il confine dell’altro. Fare il male pensando al meglio, trafiggere il tu con le più alte intenzioni. È il romanzo dell’amicizia che invecchia, che resiste franando. Insomma, è il romanzo per la propria valigia e per quella di chi amiamo.
Se poi la stesa terminasse con il dieci di coppe, allora il trionfo sarebbe garantito…
Francesco Vannutelli
L’obiettivo dell’estate è leggere (almeno) La storia di Elsa Morante, probabilmente un po’ in formato audiolibro durante i viaggi in macchina, un po’ su carta. Nella mia scorta di titoli da leggere e che probabilmente porterò in giro con me ci sono anche Dominio di Andrea Esposito (ilSaggiatore), Esercizi di fiducia di Susan Choi (edizioni SUR), Domani avremo altri nomi di Patricio Pron e Le canaglie di Angelo Carotenuto.
Foto: Mathilde Langevin, via Unsplash.