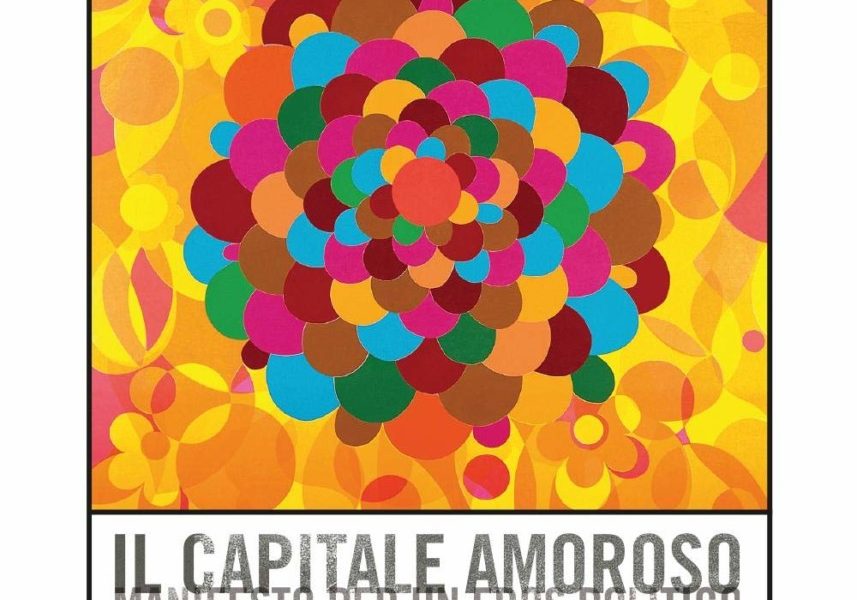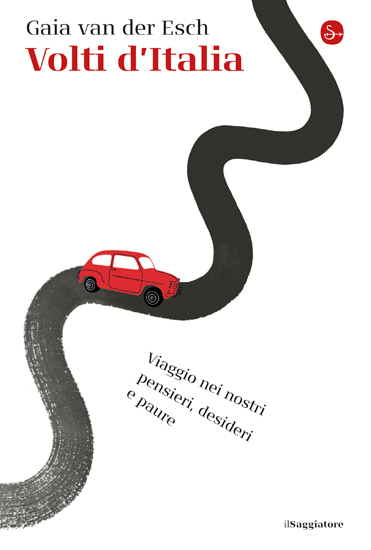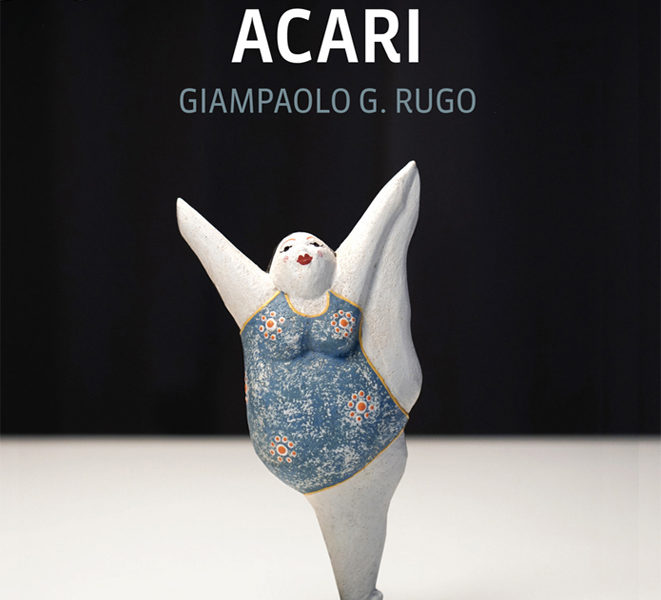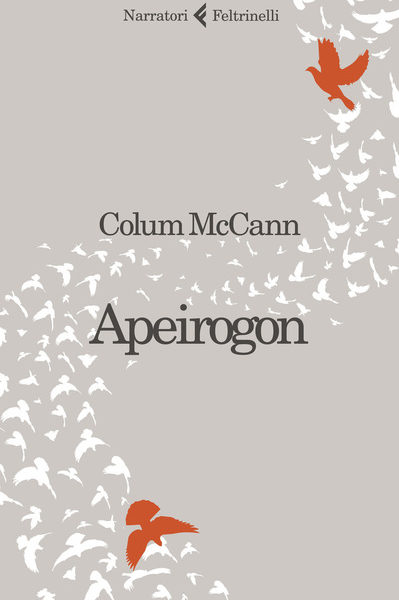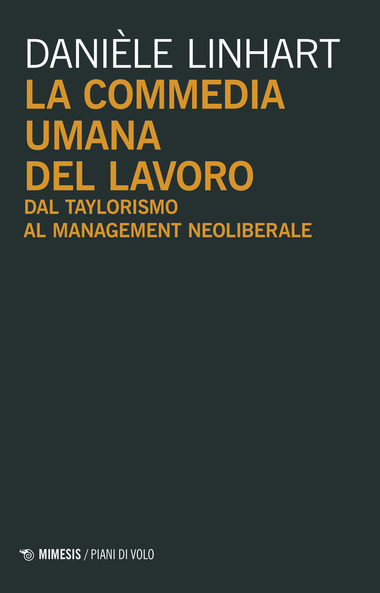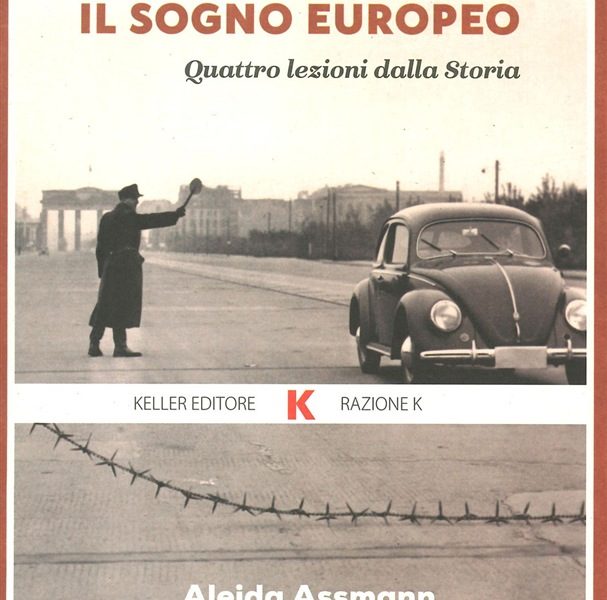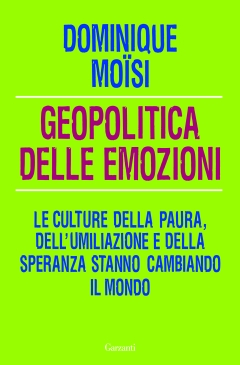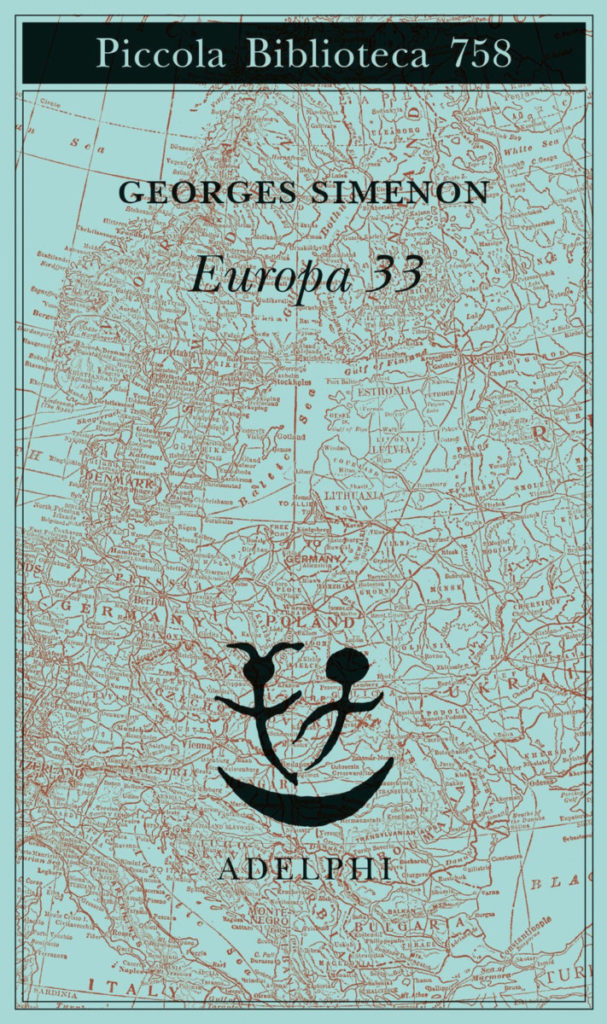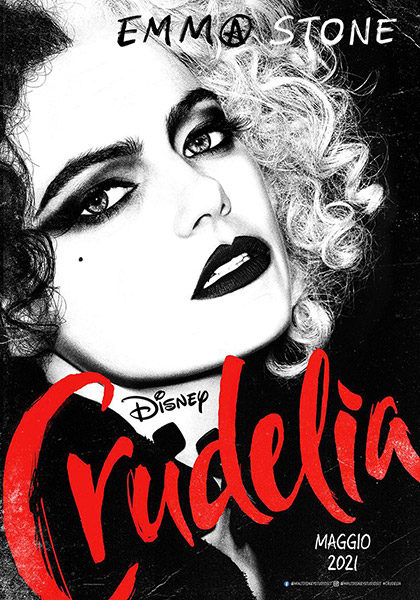L’impotenza della critica letteraria italiana contemporanea, schiacciata dall’autoreferenziale clan mediatico di un panorama culturale tanto più anonimo e massificato quanto meglio, è ormai un triste dato di fatto. Si fa un gran discutere, e a ragione, del senso che possa ancora avere battersi per interpretare e giudicare una letteratura svilita al rango di merce, subalterna al mercato e incapace di farsi ciò che per sua natura dovrebbe invece anzitutto essere, vale a dire ricerca e comprensione del senso integrale del mondo attraverso il linguaggio, sfida costante della parola scritta all’opacità inattingibile dell’esistenza. Come e perché infatti continuare a scovare nei suoi testi, oggi, quel quid invisibile «dietro cui sentiamo vibrare l’infinito», si domanda Giulio Ferroni in La solitudine del critico (Salerno Editrice, 2019), se tale compito ermeneutico ha perduto funzione civile e prestigio, sostituito com’è dalla pubblicità, da valutazioni basate sul flusso delle vendite e declinate in sondaggi, statistiche, classifiche al servizio del pensiero unico dominante dei cliché letterari alla moda.
Interrogativo sui suoi destini che, già posto con preveggente anticipo in Notizie dalla crisi di Cesare Segre (Einaudi, 1993) – sia pure ponendo il focus soprattutto sulle scelte metodologiche piuttosto che sugli ostacoli relativi all’orizzonte sociale – è ormai, più che grido d’allarme, amara constatazione dello stato di indifferente accessorietà nel quale sono relegati quanti hanno ancora a cuore una letteratura contro «il troppo e il vano», sideralmente diversa cioè da quella che «collabora allo scarto, che non fa altro che ruotare intorno alla comunicazione già data, che non fa che cercare occasioni di presenza, producendo materiale da consumare», come osserva lucidamente Ferroni in Scritture a perdere, (Laterza, 2010).
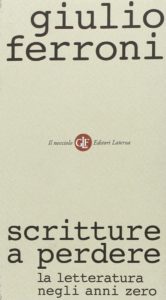
La marginalizzazione della figura del critico, infatti, ha negli ultimi decenni assunto proporzioni di tale gravità che il suo dibattito non verte nemmeno più sulla necessità di rivederne gli assunti relativi al metodo, ma proprio sulla sua stessa ragion d’essere in quanto tale. Basti pensare a un libro come Sottotiro di Enzo Golino, pubblicato nel 2002 da Piero Manni Editore e rieditato nel 2013 da Bompiani, raccolta di quarantotto stroncature di altrettanti scrittori nata nel 1988 come rubrica del mensile Millelibri, rimasta prezioso e raro caso nella prospettiva critica recente, eccezion fatta per alcune perle come Sul banco dei cattivi di Ferroni, Onofri, La Porta e Berardinelli (Donzelli, 2006), dall’eloquente sottotitolo A proposito di Baricco e altri scrittori alla moda, o del già citato Scritture a perdere.
Come difatti scrive lo stesso Golino nell’introduzione alla prima edizione, sono via via andate perse le figure tanto del recensore che dello stroncato, appiattite entrambe da un’omologata, pacificata informazione a largo raggio che, aumentando la quantità delle recensioni, inversamente abbassa il peso specifico del giudizio positivo o negativo delle medesime.
L’attuale atrofia del discorso critico è data, in sostanza, perché la società delle lettere non esiste più, questo è il punto. Al di là dell’intenderne l’essenza in quanto strumento di intervento sociale o politico piuttosto che corpo autonomo di regole, strutture e meccanismi di indagine filologica e stilistica, è in sé proprio il suo fine di interrogazione del mondo che appare incomprensibile e fuori luogo nel contesto epocale della spettacolarizzata vacuità di un sapere alla deriva. Di fatto, nel nostro presente sfiancato dalla progressiva discesa agli inferi del sistema scolastico delle tre “i” – informatica, inglese, impresa – delle università dei crediti formativi, delle lauree brevi e dei settori disciplinari, non meno che avvilito dallo squallido parametro secondo il quale il valore dei prodotti artistici debba essere determinato dal volume delle vendite e dalla diffusione sui salotti social e nei media, la scomparsa dell’effettivo peso ponderale della letteratura e della discussione intorno a essa appare quantomeno inevitabile, oltre che prevedibile. Tuttavia il pericolo maggiore, per chi abbia contezza di ciò, è quello di rinchiudersi nelle consorterie intellettuali che ne offuscano ulteriormente l’orizzonte, nella passiva visione rinunciataria e manichea che contrappone il proprio salvifico status a quello di chi è perso nel rutilante, volgare nulla della pseudo cultura.
Perché, per paradosso, mai come oggi si assiste a un entusiastico proliferare a macchia d’olio di festival, fiere, saloni, reading, riviste, contest, corsi, lezioni e quant’altro, de visu o moltiplicati in rete attraverso una sorprendente parcellizzazione di blog, interventi, video di tavole rotonde, conferenze da remoto in tempo reale e così via. Si discute con passione di resistenza del critico e dell’intellettuale, del valore oppositivo del professore accademico, dello scrittore indenne al circo mediatico, della solitudine dell’editore coraggioso, dell’improcrastinabile necessità di combattere l’analfabetismo funzionale, ecc. Eppure spesso tutto questo assume le parvenze e i metodi di una roccaforte aristocratica che, al di là delle pur sacrosante intenzioni, divide i giusti dai peccatori con salomonica certezza, rintracciando le cause dell’incalzante barbarie dell’incultura di massa in qualcosa d’altro esterno a sé, astratto e inafferrabile: la globalizzazione, la generale decadenza dei tempi, la spinta dell’imperativo al consumo, l’onnipotenza della logica del profitto.

Certamente la crisi della critica, come osserva Francesco Muzzioli in Le teorie della critica letteraria (Carocci, 2019) è una crisi generale della criticità, dunque a più ampio spettro dell’intero universo sociale, culturale e letterario, ma quella del sentirsene al di sopra è una falsa prospettiva che non può portare a soluzioni concrete. Magari la sua eclisse si annidasse unicamente nella logica che muove le recensioni asservite del giornalista di turno, nell’elogio sperticato dei dimenticabili romanzetti di onnipresenti personaggi televisivi o nell’invadente imporsi delle dittature mediatiche. Affinché cambi l’esterno da noi occorre agire dal di dentro.
Il web pullula di riviste di alto profilo e acclarata militanza letteraria apparentemente aperte a collaborazioni esterne, entrare nelle quali è impossibile se non si fa parte di una ristretta cerchia di iniziati. Le case editrici più colte e controcorrente, quelle che mai pubblicherebbero un romanzo mainstream in odore di best seller commerciale, hanno al loro attivo editor incredibilmente ignari di chi sia Roland Barthes, o che con amabile disinvoltura etichettano E. A. Poe tra i giallisti. Gli stessi che, giustamente in guardia rispetto a certo facile dannunzianesimo decadente, in compenso selezionano i manoscritti col metro di un’intellighenzia settaria e tranchant chiusa nei canoni delle ultime tendenze dell’editing editoriale, per il quale ad esempio «qualsiasi eccedenza rispetto al linguaggio scorrevole viene stroncata», senza capire che quell’assenza di stile alla quale attribuiscono innovazione, modernità e qualità «nasconde, tutto sommato, uno stile, sia pure di tipo standardizzato e banale», come acutamente nota Muzzioli.
Se davvero vogliamo salvare la letteratura, è necessario comprendere che il compito svolto dalla critica non solo è ancora e sempre fondamentale ma che è addirittura diventato indispensabile. In uno scenario in cui perfino le case editrici più impegnate si limitano a combatterne pavidamente il degrado con la pubblicazione di vecchi classici di sicura vendita, o che con miope provincialismo preferiscono affidarne le sorti alle novità oltreoceano, concedendo col contagocce nulla o poca manovra agli esordienti italiani, una solida, motivata funzione in chiave interpretativa ed esplicativa anzitutto di riconoscimento – di scouting, diremmo oggi – nonché approfondimento, supporto e propagazione del testo letterario, è quanto di cui si sente maggiormente il bisogno. Occorrono in sostanza gli strumenti per l’acquisizione di una coscienza della scrittura e delle sue ragioni che, a fronte del non trovare legittimazione nel macro circuito dello scorrevole niente di una letteratura come super produzione e immediato consumo, svolga però il proprio esercizio al di dentro delle case editrici, dei premi letterari, dei blog, delle scuole di scrittura e di editing proprie a quel condiviso panorama culturale che, pur lottando contro la sua deriva, non è sempre all’altezza di un’opposizione strumentalmente adeguata.

Affinché dunque torni ad affermarsi una scrittura – e di conseguenza una critica – che non cerchi di piacere, ovvero svincolata dalle modalità sia del network culturale di matrice consumistica sia però da quelle di una sua sistematizzazione in canoni che finiscono loro malgrado per uniformarla, è utile ricordare che «un testo narrativo implica che infinite cose si possono scrivere in infiniti modi», come sottolinea Vanni Santoni in La scrittura non si insegna (Minimum Fax, 2020). Perché di fatto, insieme alla certezza che non esistono regole assolute in grado di scomporre la letteratura in algoritmi matematici, oggi è di primaria importanza che la figura del critico ricompatti la propria centralità in chiara opposizione a qualsivoglia aurea mediocritas, vale a dire tanto quella che si trova nell’illusoria comunicazione del vuoto quanto – e a maggior ragione – all’interno di quell’universo letterario che fa, sì, i conti con le contraddizioni del presente e ne interroga il destino, ma spesso vi impone i propri modelli e saperi con inconsapevole e pericolosa sicumera.