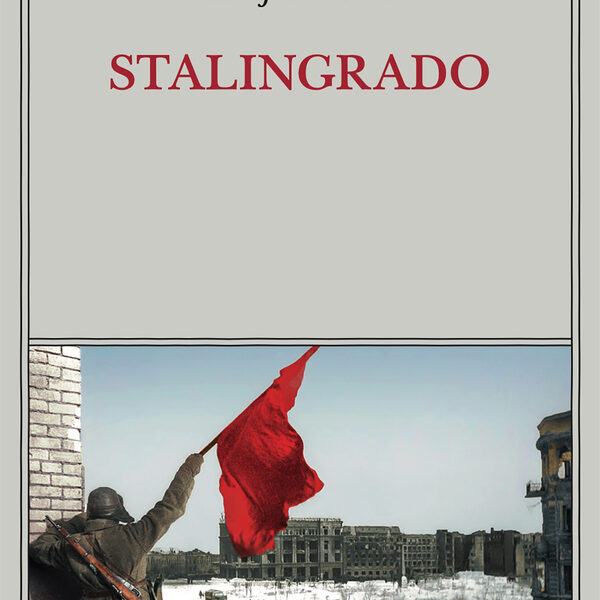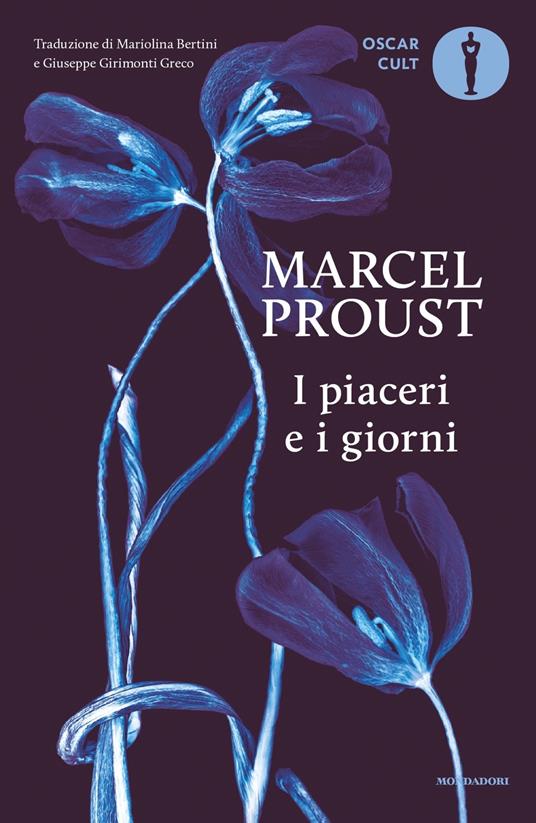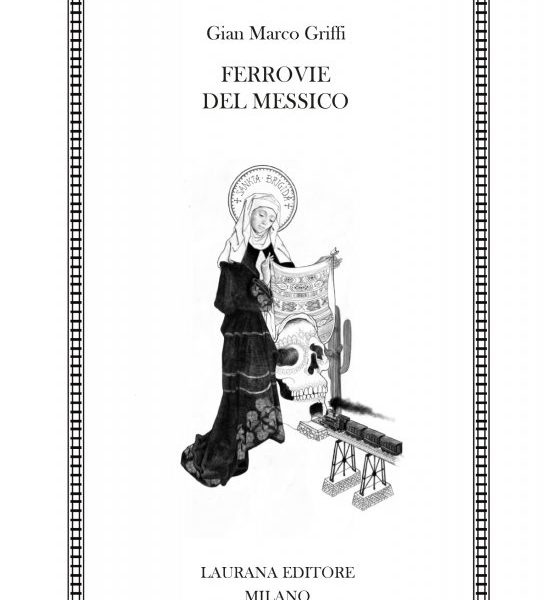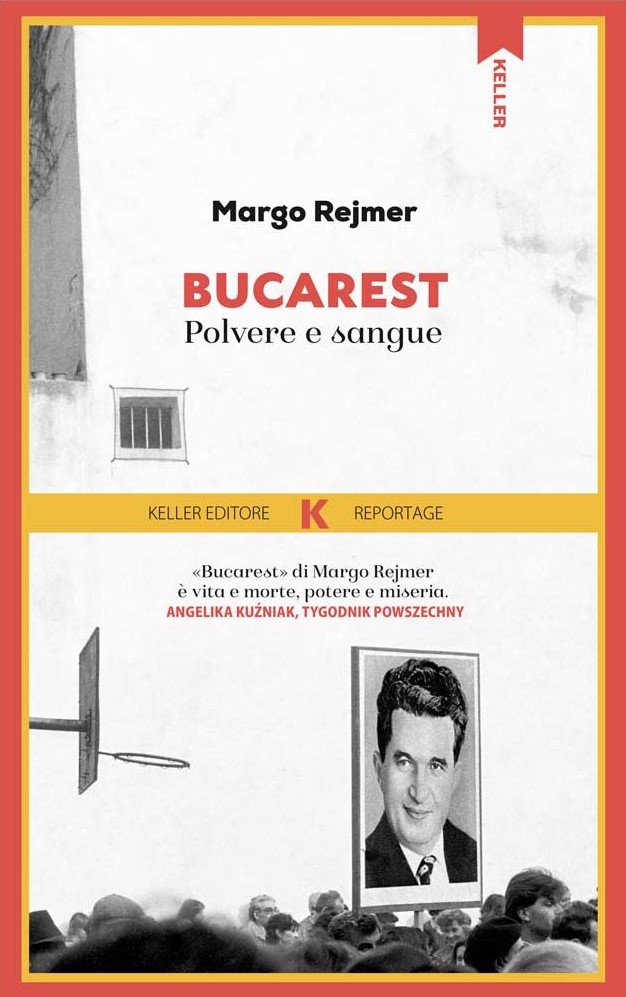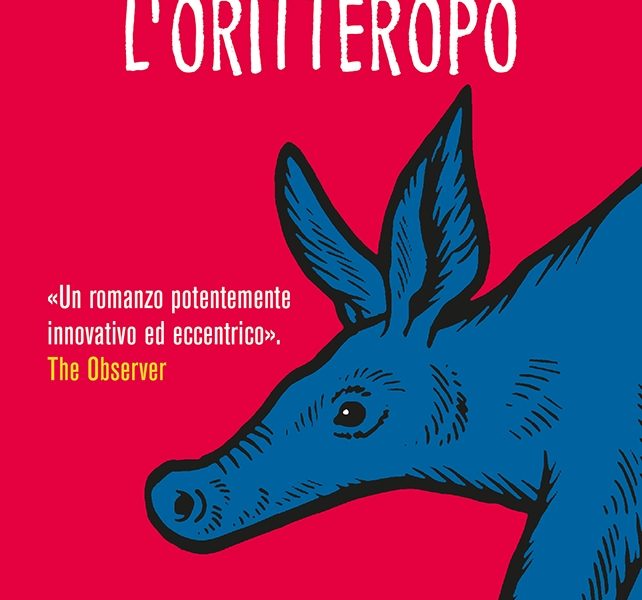Pubblicato durante la campagna antisemita del regime staliniano sulla rivista sovietica «Novyj mir», nel 1952 vede la luce Za pravoe delo (Per una giusta causa), il romanzo che negli originari intenti dell’autore (di famiglia ebraica) avrebbe dovuto precedere – nella sua diffusione occidentale – il ben più conosciuto Vita e destino e chiamarsi Stalingrado. Un manoscritto dalla storia editoriale assai travagliata e lunga, scritto e revisionato da Grossman almeno quattro volte, al fine di assecondare il demone più temuto da ogni artista, la censura. E tuttavia, dopo un’accoglienza entusiastica da parte della critica e la candidatura al premio Stalin, il clima di tensione politica scatenatosi all’indomani di un presunto complotto ai danni del dittatore, ordito da medici ebrei, alimentò ed estese l’odio in maniera generale e tramutò l’opinione dei giornali nazionali in «un romanzo che distorce l’immagine del popolo sovietico». Molto peggio capitò al seguito della dilogia, terminato nel 1960 e sequestrato dal KGB per le sue tematiche del tutto più esplicite; se il Guerra e Pace del Novecento ha infatti potuto essere tradotto in quasi tutte le lingue europee, in cinese e perfino in vietnamita, lo si deve allo scrittore Vladimir Vojnovič che di nascosto ne portò in Svizzera una copia in microfilm. Poi, L’Âge d’Homme di Losanna, editore specializzato in pubblicazioni di dissidenti sovietici e slavi, lo diede alle stampe nel 1980. Come ritiene Robert Chandler in chiusura alla recente edizione Adelphi di Stalingrado, mentre quest’ultimo «è meno filosofico, più immediato, contiene una storia umana più ricca e variegata», il capolavoro Vita e destino è considerato il manifesto della filosofia morale e politica di Grossman, «una meditazione sulla natura del totalitarismo, sul pericolo di ogni ideologia, sulla responsabilità morale che un individuo ha delle proprie azioni».
E in effetti, Vita e destino diventa una lettura irrinunciabile laddove si volesse comprendere appieno il pensiero del comunemente definito Tolstoj dell’URSS. L’epopea di Stalingrado non è soltanto uno straordinario racconto della gesta eroiche di un popolo che si difende dall’invasore nazista nel corso della battaglia omonima, ma una vera e propria opera mondo che mette a nudo la natura umana. Non vi è alcuna celebrazione dei vincitori, nessun senso di rivalsa, bensì un’analisi approfondita degli innumerevoli personaggi, della loro sofferenza, del senso d’abbandono, un’esemplare indagine sui tormenti di tante anime corrotte o lacerate per sempre dallo stalinismo e dal nazismo. Il ritratto degli attori principali e dei comprimari, le reazioni e la descrizione dei sentimenti rispetto agli eventi che accadono sono il frutto di un’incommensurabile maestria. Il realismo di Grossman trova il suo apice nella rappresentazione degli stati d’animo dei soldati che partono per il fronte, che si ritirano in seguito alla straripante avanzata tedesca, che combattono nella città assediata fino all’estremo sacrificio – gli uomini del civico 6/1, per esempio, che patiscono la fame e il freddo nei rifugi sotterranei, che attaccano il nemico sulla riva destra del Volga e lo costringono al ripiegamento.
Minuscoli dettagli sono funzionali allo scrittore ebreo-sovietico per raccontarci uno spaccato di vita di taluno o talaltro personaggio e spiegarci quanto la guerra sia totalizzante. Il contadino Pёtr Semёnovič Vavilov, chiamato alle armi, dopo aver lasciato il kolchoz, una moglie, una figlia e il calore della sua isba, si ritrova a dover sistemare la porta di un’abitazione dispersa nella steppa, per aiutare la vecchia proprietaria che ha sfamato lui e i compagni: «Il suo occhio di falco aveva adocchiato una tavola appoggiata alla parete. Prese la scure, e le somiglianze con la sua gli misero tristezza. Gli misero tristezza anche le differenze con la sua – era più leggera, e anche il manico era più lungo e sottile: gli ricordarono quanto fosse distante da casa. La donna capì cosa stava pensando, e disse: “Sta’ tranquillo che ci torni, a casa”. “Eh” rispose lui. “La strada da casa al fronte è breve, ma quella dal fronte a casa è bella lunga”».
Più avanti, sempre i soldati di cui fa parte Vavilov, asserragliati nella stazione di Stalingrado, la notte prima di essere annientati dai tedeschi si intrattengono in una conversazione. A un certo punto, Muljarčuk discorre del suo passato e scandisce il nome della propria madre: «Aveva pensato che, se non gliel’avesse raccontato lui, i suoi compagni non avrebbero mai saputo quanto si stava bene d’estate a Polonnoe, con gli zuccherifici intorno, o quant’era bella sua madre e che brava sarta era stata».
Un ulteriore esempio, riportato anche da Chandler nella postfazione, riguarda il maggiore Berёzkin, ignaro del destino della propria consorte, che durante una cena in una casa semibuia nei pressi del Volga si imbatte in dei pomodori: «Cominciò a tastare i pomodori per trovarne uno maturo ma sodo, e per un attimo si commosse ricordando che la moglie lo rimproverava sempre, quando lo faceva a casa con i pomodori e i cetrioli nel piatto di portata».
E a riprova degli impatti globali della guerra, Grossman non trascura neppure la fauna della steppa, dove gli uccelli selvatici devono volare in un’aria pregna di fumo, i pesci sono obbligati a inabissarsi sul fondo del fiume per evitare il rumore assordante delle granate, le lepri e i topi si abituano con fatica all’odore di bruciato e ai tremori della terra, le vacche perdono latte per il nervosismo e i cani latrano di notte.
La lettera di Anna
Sebbene l’accostamento tra Grossman e Tolstoj compaia in svariati articoli di critica letteraria per una plateale somiglianza delle vicende narrate nei rispettivi capolavori, nonché per il contributo morale e filosofico che entrambi hanno consegnato ai posteri, il primo ha vissuto la guerra per davvero, trascorrendo oltre mille giorni al fronte quale corrispondente del quotidiano «Krasnaja Zvezda». E in effetti, non si può prescindere da un approfondimento della biografia dell’autore, per constatare come gli avvenimenti drammatici abbiano letteralmente fondato i temi di quest’opera.
Nato e cresciuto a Berdičev (Ucraina) in una famiglia ebraica, ingegnere chimico, nel 1930 Grossman lasciò la professione per dedicarsi alla scrittura e al giornalismo. Quando la città natale, all’epoca considerata tra i più importanti centri dell’ebraismo dell’Est Europa, venne invasa dall’esercito tedesco, la madre di Grossman, Ekaterina Savel’evna, fu confinata in un ghetto e successivamente fucilata. Nella ricostruzione di Chandler, leggiamo che Vasilij «provava un senso di colpa profondo, per aver permesso che […] restasse a Berdičev anziché insistere perché andasse a stare con lui e la moglie a Mosca». A tal riguardo, il personaggio che nel romanzo emerge su tutti per la complessità e per il preponderante numero di pagine a lui dedicate è il fisico nucleare Viktor Pavlovič Štrum, il quale pur essendo ispirato con ogni probabilità alla figura di Lev Jakovlevič Štrum – tra i fondatori della fisica nucleare sovietica, giustiziato per «trockismo» nel ’36 – deve considerarsi come l’alter ego dell’autore. Anche Štrum-personaggio ha una madre rimasta a Berdičev, Anna Semёnovna, che vive gli orrori dell’occupazione e invia al figlio lontano una lettera d’addio di una gravità sconvolgente. Ritenuta il pezzo artistico più brillante di Grossman, seppur citata in varie circostanze di Stalingrado, se ne scopre il contenuto – lungo un intero capitolo – in Vita e destino. Oltre a circostanziare i terribili fatti del trasferimento forzato nel ghetto, ciò che colpisce è la descrizione dello stato d’animo di Anna, al momento dell’ingresso: «Sai cosa ho provato una volta dietro il filo, Viktor caro? Pensavo che avrei avuto paura. Invece, figurati, in quel recinto per le bestie mi sono sentita sollevata. E non perché io sia succube, no. No. Ero attorniata da gente con il mio stesso destino, lì dentro, non avrei dovuto camminare sul selciato come un cavallo, né mi avrebbero fissato con cattiveria; i conoscenti mi avrebbero guardato negli occhi e non mi avrebbero evitato. Tutti avevamo il marchio imposto dai nazisti, dunque dentro il recinto quel marchio non mi avrebbe bruciato troppo il cuore. Non mi sarei sentita un animale senza diritti, ma una persona sfortunata. Per questo ho provato sollievo».
Le quattordici pagine del racconto di Anna Semёnovna, unitamente a quelle dedicate alle gasazioni, rappresentano la testimonianza di un’immane crudeltà che rimane impressa più di tutto nella mente del lettore, e costituiscono anche, a conferma della puntigliosa analisi di Grossman sui comportamenti umani, una denuncia per i russi che rimasero indifferenti o aiutarono il nemico nel folle progetto di epurazione. Dice Anna: «Sotto la mia finestra la moglie del portinaio commentava: “Grazie a Dio gli ebrei hanno i giorni contati”. […] Ho chiesto che mi pagassero l’ultimo mese di lavoro, ma il nuovo dirigente mi ha risposto di domandarli a Stalin, i soldi che avevo guadagnato con i sovietici, di scrivergli a Mosca. […] E il dottor Tkačev mi ha stretto la mano. Non so cosa sia peggio: la cattiveria o la compassione con la quale di solito si guarda un gatto rognoso a cui resta poco da vivere. […] quelli che chiedono di liberare la Russia dagli ebrei si umiliano di fronte ai tedeschi e sono pronti a vendere la Russia per trenta denari nazisti».
E verso le battute finali della missiva, come a esacerbare involontariamente il senso di colpa del figlio personaggio-autore, la donna esplicita la paura e la rassegnazione per una situazione che non si sarebbe risolta in alcun modo: «Da bambino correvi da me perché ti difendessi. In questi momenti di debolezza vorrei essere io a nascondere la testa tra le tua ginocchia così che tu, forte e intelligente come sei, potessi proteggermi, difendermi. […] Penso al suicidio, e non so cosa sia a trattenermi, se la debolezza, la forza o una speranza priva di senso».
La lettera di Anna Semёnovna include il leitmotiv di molti filoni narrativi in cui vengono coinvolti altri comprimari: il dualistico rapporto madre-figlio. Tenuti distanti dagli eventi bellici, le loro storie viaggiano su binari paralleli; ogni possibilità di rincontrarsi è vana, ma il dolore dell’assenza trasmuta nell’illusione che induce ad agire e che dona tensione e potenza a ogni riga che compone la pagina. E così, Ljudmila Nikolaevna Šapošnikova, moglie di Štrum, affronta una lunga e pericolosa traversata del Volga per raggiungere l’ospedale militare in cui è ricoverato Tolja, figlio avuto dal primo marito, ferito gravemente in combattimento. Non arriverà in tempo.
Il diciassettenne Sergej (Serёža) Šapošnikov (tra gli eroi del civico 6/1), nipote di Ljudmila, partito volontario, apprende da una lettera che la madre, Ida Semёnovna, è morta. Ida non era mai stata una donna così amorevole nei riguardi del figlio. Soleva lasciarlo per molti mesi a Stalingrado, a casa della nonna paterna affinché se ne occupasse, e quando Serёža vi si trasferì per sempre, lei gli scriveva di rado. Eppure, il giovane, preso atto della sua scomparsa, diventa taciturno ed elude le domande dei compagni:
«”Cosa c’era scritto nella lettera?” gli domandò [Čencov]. “Sei il primo che ne riceve una”.
Serёža lo guardò di nuovo e disse:
“Sì, è vero. Sono il primo”.
“Cos’hai agli occhi?”.
“Mi fanno male. Sarà la polvere” rispose Serёža».
Il tema madre-figlio è centrale per Grossman anche nell’agghiacciante resoconto di un massacro. È il caso del piccolo David – nome non casuale –, e di Sof’ja Osipovna Levinton, medico chirurgo amica degli Šapošnikov. I due si conoscono su un vagone diretto a un campo di sterminio. David è solo: la mamma si trova a Mosca e per motivi economici lo aveva affidato provvisoriamente alla nonna, nell’Ucraina occupata. Durante il viaggio, Sof’ja, che non ha mai avuto bambini, s’intenerisce davanti al terrore muto del ragazzino, gli sussurra parole dolci, lo accompagna tenendolo per mano fin dentro al lager, e quell’inspiegabile protezione materna la induce a rinunciare alla salvezza (forse momentanea) che la sua professione le avrebbe dato.
All’ennesimo addio tra una madre e un figlio – l’unico che avviene senza distacco fisico – assiste la bella Evgenija (Ženja) Nikolaevna Šapošnikova, mentre sta fuggendo per le strade bombardate di Stalingrado. Si tratta di due sconosciuti, un’anziana donna che si accascia a terra e un uomo dal viso tondo e dall’impermeabile grigio che cerca di sollevarla: «La vecchia accarezzava le guance dell’uomo inginocchiato, e fu allora che Ženja capì cosa c’era in quel palmo rugoso, che poi era l’unica cosa degna che ci fosse al mondo, per lei. C’era la tenerezza di una madre, c’era la supplica di una creatura inerme come un bambino, c’era la gratitudine per quel figlio che l’amava, c’erano le lacrime e la voglia di consolarlo, lui ormai grande e forte, ma che nulla poteva in quel momento; c’era il perdono delle colpe di lui, c’era l’addio alla vita, c’era la voglia di respirare e di vedere la luce del giorno».

La bontà illogica
Se l’effetto più catastrofico della guerra è la perdita della “madre” – intesa, in senso lato, come patria, casa, origini, cultura, normalità e l’insieme dei valori che ci rendono degni di vivere –, viene da chiedersi come si sia arrivati a questo, come le ideologie nazionaliste abbiano potuto attecchire sui popoli. Al riguardo, le riflessioni filosofiche di Grossman si pongono lo scopo di liberare la realtà dalle sovrastrutture mitiche e di sgombrare le menti da tutte le deformazioni della propaganda. L’analisi è profondamente legata all’essere umano, ai suoi comportamenti e alla sua natura, ma per poterla comprendere bisogna tener conto fin dall’inizio di un principio dal quale non si può prescindere: esiste una sola e unica verità. Rifiutando e disprezzando le illazioni imposte dal nazionalsocialismo e dal bolscevismo, non rimane che l’uomo libero, razionale e buono.
Grossman tenta di esaminare la radice dell’antisemitismo e arriva alla conclusione che esso «è l’espressione della mediocrità, dell’incapacità di vincere in uno scontro ad armi pari: nelle scienze, nel commercio, nell’artigianato e nella pittura. L’antisemitismo è la misura della mediocrità umana. […] L’antisemitismo è l’espressione dell’ignoranza delle masse che non sanno trovare una ragione a disgrazie e patimenti». L’autore attribuisce alla minoranza ebraica alcuni tratti specifici che nel corso della storia l’hanno sempre distinta rispetto agli altri gruppi etnici. Innanzitutto, l’ebraismo si intreccia e si confonde con molte questioni politiche e religiose universali; la diffusione degli ebrei nel mondo è capillare e l’industrializzazione ha loro permesso di specializzarsi in ambito tecnologico e di accumulare capitali commerciali; per indole, gli ebrei non rimangono confinati in periferia, ma cercano di distinguersi «là dove prosperano il pensiero e l’azione», integrandosi con gli autoctoni, ma allo stesso tempo mantenendo la cultura e le tradizioni proprie. Si annoverano tra gli ebrei i migliori fisici nucleari, direttori di banche, inventori di reattori atomici e medici. Questi successi hanno generato tra le folle un odio e una frustrazione sfociate in un antisemitismo dalle molteplici forme, latenti o esplicite. Esso può riguardare il singolo, una società, uno Stato: «Nei paesi democratici può insorgere un antisemitismo di natura sociale, che si manifesta negli organi di stampa appartenenti a gruppi reazionari […] e in un sistema religioso o ideologico reazionario. Nei paesi totalitari, dove la società civile non esiste, può svilupparsi solo un antisemitismo di Stato». Negli Stati totalitari, aggiunge Grossman, in un primo momento l’antisemitismo è discriminatorio, e pertanto agli ebrei viene impedito l’esercizio di alcuni diritti (la frequenza delle università, l’occupazione di posizioni di prestigio, ecc…), poi avviene lo sterminio.
In Vita e destino, più che in Stalingrado, l’autore ci fornisce un quadro allarmante degli orrori dello stalinismo ricordando le purghe del 1937, mostrandoci spaccati di vita dei deportati nei campi di lavoro siberiani, presentandoci un’intellighenzia che durante le cene centellina le parole per la paura del sospetto e dello screditamento. Siamo in un’epoca in cui Dostoevskij è da considerarsi reazionario, i decadentisti sono inutili, mentre Tolstoj e Čechov risultano funzionali al realismo socialista, ma con un capovolgimento totale delle loro idee democratiche che porrebbero, invece, l’uomo al centro del sistema. È proprio l’uomo che l’ideologia cerca di seppellire. Quando Štrum si ritrova a compilare un questionario per l’Istituto di Fisica, è obbligato a indicare la sua estrazione sociale (borghese), quella dei genitori e quella dei genitori dei genitori, e riflette sulla somiglianza di fondo tra nazismo e stalinismo: «[…] non c’è dubbio che anche ai tedeschi parrà etico chiederti la nazionalità. Uccidere gli ebrei perché sono ebrei è terribile, non si discute. Sono essere umani, sono uomini, gli ebrei: buoni, cattivi, sciocchi o talentuosi, ottusi, allegri, bravi, sensibili o taccagni. A Hitler, invece, non importa: quel che conta, per lui, è che siano ebrei! E io protesto con tutto me stesso! Il nostro, però, è un principio analogo: quel che conta è che tu sia nobile, kulak o mercante. Cosa importa se sei bravo, cattivo, talentuoso, buono, sciocco o allegro?».
Di estremo interesse è la scena che ritrae il colloquio tra lo Sturm-bannfϋhrer Liss e il prigioniero Mostovskoj, intellettuale sostenitore del socialismo sovietico. Il funzionario delle SS lo invita a ragionare sulle identiche metodologie adottate dai tedeschi e dai russi: «voi avete ucciso milioni di persone, e gli unici a capire che andava fatto siamo stati noi tedeschi! […] A che cosa si deve tanta ostilità tra noi? […] Siamo due ipostasi della stessa sostanza: uno “Stato partito”. […] La bandiera rossa sventola anche sul nostro Stato popolare, anche noi chiamiamo all’unità nazionale, alla cooperazione, anche noi diciamo: “Il partito esprime il sogno dell’operaio tedesco”. E anche voi usate parole come “popolo” e “lavoro”. […] Il socialismo in un solo paese esige che si elimini la libertà di seminare e di vendere, e Stalin non ha esitato a far fuori milioni di contadini. Hitler s’è reso conto che il socialismo nazionalista tedesco aveva un nemico: l’ebraismo. E ha deciso di eliminare milioni di ebrei». E Mostovskoj, che ha sempre una risposta per tutto, stavolta tace in preda ai dubbi e non riesce a controbattere.
Un’efficace metafora che sintetizza gli effetti delle ideologie sulle menti degli esseri umani è la «teoria della pasta lievitata» che emerge in un memorabile dibattito tra Štrum e il suo mentore Čepyžin in Stalingrado. Secondo Čepyžin, il nazismo è forte, ma è destinato a soccombere. Esiste un limite al suo potere che risiede nella morale e nella bontà del popolo. Esse sono indistruttibili e prima o poi lo annienteranno. Nell’impasto del popolo tedesco, Hitler, infatti, non ha modificato la proporzione degli ingredienti, bensì l’ordine. Ha portato a galla le nefandezze, il passato reazionario della Germania, e ha depositato sul fondo la saggezza popolare, il buon senso, la bellezza dell’arte, della letteratura e delle scienze tedesche; ha rinchiuso nel lager le persone oneste, i fiori all’occhiello di ogni città. Eppure, la debolezza dell’hitlerismo risiede nel non poter dichiarare apertamente i crimini peggiori, perché il male, pur producendo altro male, potrebbe anche generare il bene. È un’osservazione di incredibile acutezza, sulla quale Grossman si sofferma più volte nel corso degli eventi narrati. Secondo lui, la proclamazione dell’immoralità, della negazione delle libertà altrui, della soppressione dei diritti, riaccenderebbe l’anima del popolo che, seppur annebbiata, non può essere modificata. Ben presto, ci si renderebbe conto di quanto inumano sia il nazismo. In Vita e destino, Grossman finalmente dà un nome a questa propensione immutabile dell’anima: la bontà illogica. Essa è la chiave di lettura dell’intera opera.
Esaminando il concetto di bene, infatti, l’autore rileva come nel corso dei secoli questa parola abbia perso significato, relativizzandosi, miniaturizzandosi e arrivando a giustificare gli atti più crudeli. Ogni setta, religione, ideologia, classe politica, partito, nazione ha perseguito il proprio bene, ammantandolo di universalità: «Il mio bene coincide con il bene di tutti, il mio bene non serve a me soltanto, ma a ogni altro uomo. E facendo il mio bene, mi metto al servizio dell’umanità intera». È per il bene dei cristiani, per esempio, che sono avvenute le torture dell’Inquisizione o il massacro delle tribù pagane della Tasmania. Proprio per il bene sociale si è verificata in Unione Sovietica la collettivizzazione forzata e le uccisioni di centinaia di migliaia di uomini e donne. È per il bene dei tedeschi che il nazismo massacra milioni di ebrei. Il bene vero, invece, è per Grossman quel bene che alberga in ogni essere umano, che induce ad amare gli esseri viventi, la vita, è quella felicità al termine di una giornata di lavoro. «È la bontà dell’uomo per l’altro uomo, una bontà senza testimoni, piccola, senza grandi teorie». Si tratta di una bontà che appartiene al singolo e che è eterna, istintiva e cieca. È quella bontà inspiegabile che induce una vecchia russa a dare da bere a un soldato tedesco in fin di vita, la stessa bontà «che scagiona la tarantola che morde il neonato». È forte finché non diventa mercanzia dei profeti, è forte finché paradossalmente rimane priva di forza: «Appena la si vuole trasformare in forza, la bontà si perde, scolora, si offusca, svanisce». Quanto più è debole tanto più è invincibile. La bontà illogica è l’arma che ci ha salvato e che ci salverà dal male perché costituisce il senso dell’umanità. La vittoria di Stalingrado non è la vittoria del bolscevismo contro il nazismo o del bene contro il male, ma è la vittoria dell’uomo.
La scelta
Leggendo Grossman è difficile non pensare al monumentale Europe Central (Mondadori, 2005) di William T. Vollmann, un romanzo postmoderno e «massimalista», secondo la definizione che si desume dal fortunato saggio di Stefano Ercolino (Il romanzo massimalista, Bompiani, 2015). E molte sono le analogie tra le due opere. Anche per Vollmann, la letteratura è uno strumento di indagine morale e anche in Europe Central i personaggi vengono posti dinanzi a delle scelte drammatiche. L’esempio più lampante è l’ufficiale delle Waffen-SS Kurt Gerstein, membro dell’Istituto d’Igiene delle SS, che viene a conoscenza dell’uso reale del gas Zyklon B, nel campo di concentramento di Auschwitz. Sconvolto e combattuto tra il desiderio di salvare gli ebrei e preservare la vita della propria famiglia, l’uomo tenta in più occasioni di informare i governi dei paesi neutrali, ma senza successo.
In Vita e destino, il solito Štrum viene invitato ad abiurare pubblicamente la sua scoperta – una formula matematica relativa al meccanismo di disintegrazione dei nuclei atomici – in quanto contraria alle idee leniniste sulla natura della materia. Egli rifiuta e viene abbandonato e criticato dai colleghi, vivendo nel timore di essere arrestato da un momento all’altro. Inaspettatamente, però, riceve una telefonata riabilitante da parte di Stalin in persona, che lo invita a proseguire i lavori. Per Štrum, tutto cambia in meglio, riacquista credito tra i suoi ex delatori e ottiene un aumento di stipendio. Quando, però, il regime gli chiede di firmare una denuncia nei confronti di due medici accusati di un presunto crimine – analogamente a quanto accaduto allo stesso Grossman –, egli cede alle sue lusinghe e al timore di perdere tutto, smarrendo la propria identità e lacerandosi nel senso di colpa. Ecco l’obiettivo di uno Stato totalitario: l’obbedienza cieca, la distruzione del corpo, la conquista dell’anima e la resa incondizionata dell’uomo.
Sia Europe Central che l’epopea di Stalingrado sono opere polifoniche dove molti comprimari si esprimono allo stesso modo: sono quei casi in cui a parlare è l’ideologia del blocco tedesco o di quello sovietico. Tra i personaggi che invece sono in contrasto con il partito o che ne subiscono le conseguenze, Vollmann racconta le “parabole” (una sua definizione) di musicisti, partigiani, scultori, artisti – figure realmente esistite –, mentre Grossman è ispirato dai fisici e dagli scienziati. Per entrambi gli autori l’arte e la scienza rappresentano una forma di ribellione al totalitarismo e devono essere scevre da ogni influenza.
La vita è libertà, ci dice Grossman. Ma sebbene anche la volontà dell’uomo sia libera, in epoche tremende egli non è più artefice del proprio destino perché «è il destino del mondo ad arrogarsi il diritto di condannare o concedere la grazia, di portare agli allori o di ridurre in miseria, e persino di ridurre in polvere di lager, tuttavia né il destino del mondo, né la storia, né la collera dello Stato […] erano in grado di cambiare coloro che rispondono al nome di uomini».
(Vasilij Grossman, Stalingrado, trad. di Claudia Zonghetti, Adelphi, 2022, 884 pp., euro 28; Vita e destino, trad. di Claudia Zonghetti, Adelphi, 2022, pp. 982, euro 16, articolo di Carmine Madeo)