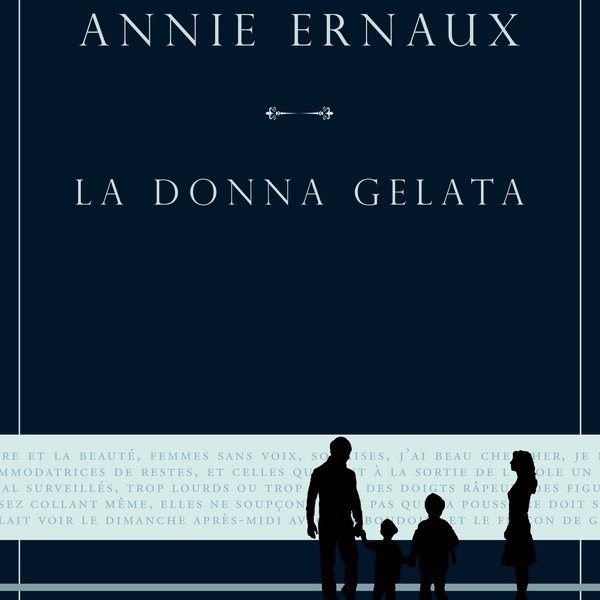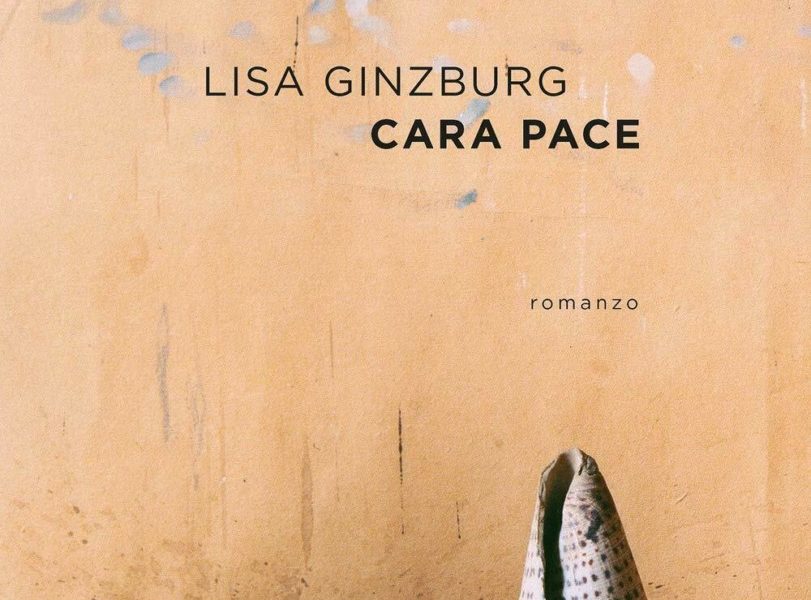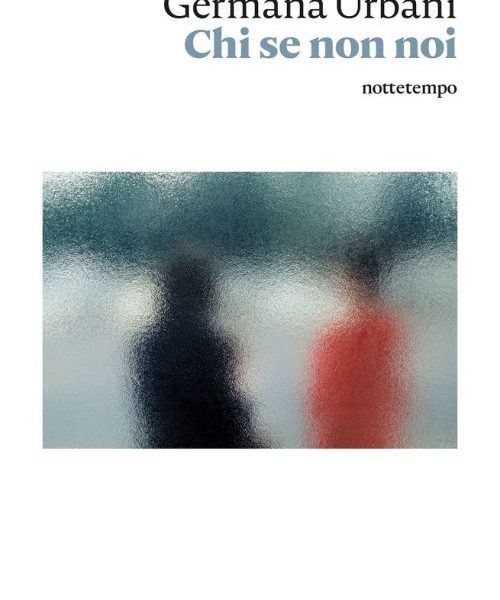Quasi senza accorgermene ho finito la tesi, l’ho discussa nella sessione di luglio e sono partito per una breve vacanza insieme a Greta. Sempre senza accorgermene ho cominciato a derubarla in modo sistematico. Sulla spiaggia, di notte, al ristorante, in auto. Ho iniziato per essere risarcito e continuo perché il mio bisogno di risarcimento non ha fine.
L’idea del Salento è stata di Greta, che studia alla Normale e ha un’amica, anche lei normalista, originaria di Lecce. Ci siamo conosciuti mentre preparavo una tesi sulle transazioni di denaro nei Miserabili di Victor Hugo. Secondo il relatore, ai fini della mia ricerca era fondamentale che consultassi un certo fascicolo della Revue des Deux Mondes di cui non esistevano altre copie se non nella biblioteca della Normale. Un caso bizzarro, se si può parlare di caso per queste faccende, ha legato anche il primo incontro con Greta a un piccolo furto. In biblioteca non è infrequente che qualcuno dimentichi di recuperare dal contatore la tessera per le fotocopie. Per tutto il periodo della tesi, così, sono andato avanti senza spendere un euro, lasciando che la mia ricerca fosse finanziata dalla distrazione collettiva.
«Scusa, hai preso la mia tessera?», mi chiese Greta apparendomi alle spalle mentre fotocopiavo le pagine della rivista. «Chi, io?», risposi sciolto, con in tasca la tessera che avevo tolto dal contatore un minuto prima. Avevo avuto la prontezza di introdurre subito la mia (“mia” si fa per dire), la feci uscire e, con uno sguardo da pokerista, gliela passai. Greta studiò con cura la superficie. Sbuffò: impossibile, disse, era uscita dalla stanza giusto il tempo di una telefonata ed era passato il solito stronzo. Quel mese aveva già perso due tessere e adesso stava attentissima, aveva addirittura marcato le sue iniziali sull’angolo, insieme al numero di matricola.
Allargai le braccia e, un po’ per l’effettivo senso di colpa, un po’ perché ho sempre trovato adorabili le smorfie di delusione, la invitai a prendere quel tipo di caffè che prelude al corteggiamento. Lei accettò senza esitare. Doveva aver capito che in me c’era qualcosa di torbido, non so come ma alcune ragazze lo percepiscono e ne restano incuriosite.
«Comunque lo so che l’hai presa tu, la tessera», mi sussurrò Greta alcune settimane più tardi con l’orecchio sul mio petto, la terza o la quarta volta che facevamo l’amore. Negai; lei insisté e io negai con più determinazione, ottuso e maledetto come quei personaggi dell’Antico Testamento su cui, inevitabile, si abbatterà un flagello.
Abbiamo noleggiato un’auto all’aeroporto di Brindisi. Greta mi ha strappato di mano le chiavi e si è messa al volante: dice sempre che guido come una vecchia. Alla svolta per Lecce, dopo un’occhiata miope alla segnaletica, ha preso uno svincolo. «Guarda che stiamo andando dalla parte opposta», le ho fatto notare appena mi sono accorto che il mare era sul lato sbagliato.
«Lo so, facciamo un piccolo détour», mi ha risposto allegra. «Voglio vedere Cisternino».
«Ma nel contratto del noleggio non abbiamo un limite di chilometri? Se sforiamo, poi ci tocca pagare di più e…»
«Ti prego, no. Il conteggio dei chilometri in vacanza no, dai!»
Per non fare il noioso ho lasciato perdere. Greta studia le tecniche narrative dei romanzi cavallereschi, e Il détour del cavaliere bretone è l’argomento della tesina complementare che prepara per ottenere il diploma di licenza della Normale. Se ho ben capito, le svolte improvvise, le deviazioni inaspettate e irragionevoli dei cavalieri alla ricerca di avventura sono la chiave fondamentale per leggere quei romanzi, che si svuoterebbero di senso se il racconto dovesse seguire una linea diritta.
All’arrivo Greta ha preteso di dormire in una tipica casa bianca di Cisternino (ottanta euro) e di mangiare la tipica carne alla brace di Cisternino (trenta a testa).
Il giorno dopo guidavo io. Siamo passati da Ostuni per vedere altre case bianche, dopodiché siamo tornati verso Brindisi per continuare in direzione di Lecce. Stavo per imboccare la superstrada quando Greta, piedi sul cruscotto come da peggiore tradizione, ha gridato «Détour!», indicandomi l’uscita di una rotatoria. «Ci facciamo mezz’oretta di mare a Torre…»
«Senti», l’ho interrotta, «non voglio essere pesante. Ma nel contratto del noleggio abbiamo un limite di chilometri e a me non va di…»
«Aridagli con ’sti chilometri! Voglio fare un tuffo, va bene? Ci sono cinquanta gradi in questo cesso di macchina che hai scelto tu. Almeno lasciami fare un bagno in pace prima della sauna sulla superstrada».
È stato a questo punto che ho messo a fuoco quello che forse avevo intuito fin dal primo caffè: la nostra relazione è frutto di un equivoco. Studente curioso ama studentessa brillante, come se questo potesse bastare per essere felici. La verità è che condividiamo interessi di superficie ma restiamo divisi su tutto; veniamo da mondi diversi e andremo in direzioni opposte. E io non ho più soldi.
Senza fare obiezioni ho guidato in silenzio fino a Torre Guaceto (venticinque chilometri ad andare e venticinque a tornare), dove sono rimasto in auto per protesta mentre Greta andava a fare il bagno.
Il primo furto non si scorda mai: venti azzurrissimi euro facevano capolino dal portafogli abbandonato sul sedile. Li ho estratti in fretta, nervoso ed esitante, e in definitiva convinto che sì, stavo facendo una cosa sbagliata ma per una causa giusta: la mia riparazione. Al ritorno Greta non si è accorta di niente.
La lascerò all’aeroporto, è deciso, appena saremo a Pisa. Non ho voglia di guastarmi la vacanza della mia laurea con discussioni e lacrime. Il Salento è splendido e chissà quando mi ricapiterà. Farò finta di niente per qualche giorno, mi sono portato da leggere Infinite Jest (quarto tentativo) e non permetterò che la fine banale di una banale storia di non-amore mi distolga ancora una volta dall’impresa.
Da quando abbiamo fatto base a Lecce, i détours si sono sprecati, complice Luisa, l’amica di Greta che pretende di farci visitare ogni singolo rimasuglio di civiltà messapica (argomento della sua tesina di licenza), di farci mangiare ogni piatto tipico, di introdurci agli arcani del vento salentino, con i relativi cambi di rotta da costa ionica a adriatica e viceversa.
Dopo quello inaugurale i furti sono diventati più spontanei e la mia tecnica si è affinata. Le remore della prima volta hanno ceduto il passo all’abitudine di una pratica ragionieristica, in fondo un po’ noiosa ma da completare con scrupolo per rimettere i conti in pari.
Ogni notte mi sveglio per andare in bagno e prelevo dieci euro dalla borsa di Greta; altri cinque li trattengo da un resto; un biglietto da venti mi rimane appiccicato alle dita nella confusione accaldata degli aperitivi.
Non credo che si possa parlare di cleptomania. Mi sento legittimato a rubare sulla base di alcune considerazioni razionali e argomentabili: l’estrazione altoborghese di Greta, prima di tutto, architetto il padre e notaio la madre. Quando ha compiuto diciotto anni e ha vinto il concorso in Normale, anziché regalarle una Nissan Micra, i genitori le hanno comprato un appartamento a Pisa. Greta, tra l’altro, ha deciso di non abitarci, credo per un qualche regolamento o per una consuetudine secolare che obbliga i normalisti a vivere in collegio. L’appartamento, allora, è stato affittato, e il ricavato (settecento euro che sputaci sopra) è diventato la paghetta di Greta, a cui si aggiunge la sua – meritata, ci mancherebbe – borsa di studio.
Per quanto riguarda me, la mia situazione economica giustifica, se non i furti, di certo la mia preoccupazione ogni volta che Greta strilla «Détour!» e mi costringe a cambi di programma talmente sconcertanti da sembrare deliberate crudeltà. Stamani, lasciandoci Otranto alle spalle, abbiamo definitivamente sforato il tetto di chilometri. Ogni metro che percorreremo da qui alla fine della vacanza andrà pagato extra.
A Pisa, pur senza funzionare, le cose si mantenevano in equilibrio. Costretta a entrare in risonanza con la vibrazione di una comunità studentesca mediamente povera e di sinistra, Greta non ha mai lasciato emergere il suo lato godereccio, o forse non ne ha mai avuto una vera occasione. Anche in vacanza, a ben guardare, non è tanto in gioco un autentico bisogno di lusso, quanto piuttosto l’esigenza di evitare i calcoli, di poter spendere come se i soldi non dovessero finire mai.
Alle undici abbiamo fatto tappa a Santa Maria di Leuca. Secondo uno schema ormai collaudato mi sono steso sull’asciugamano con il mio libro e, quando le ragazze si sono lanciate in acqua, ho preso il portafogli di Greta e ho incamerato cinquanta euro. Forse stavolta ho esagerato, ma anche loro ormai non si regolano più. Ieri sera ho dovuto fare resistenza per non finire in un ristorante che, pare, è in lizza per ricevere la sua prima stella Michelin.
Non volevo rovinare la serata e ho ceduto più tardi, quando si è trattato di andare fino a Gallipoli (trentacinque più trentacinque, settanta chilometri extra), dove Luisa voleva mostrarci a tutti i costi un’oscena discoteca, prima con l’intenzione di guidarci – cito – «in un safari del cattivo gusto», per poi passare lei stessa alla caccia grossa verso le tre del mattino, quando ha iniziato a limonarsi un quarantenne con le sopracciglia e la barba perfettamente sagomate.
«Bella serata di…», prima che riuscissi a dire merda, Greta mi ha mangiato vivo: «Ma tu che ti lamenti tanto, eh, che vorresti fare? Si può sapere? Dai! proponi qualcosa di divertente. Fosse stato per te potevamo passare le vacanze della tua laurea a Marina di Pisa…»
Era il momento perfetto per lasciarla, ma mi sono morso la lingua e sono rimasto in silenzio. Ancora due giorni di vacanza e sarà finita. In fondo Greta ha ragione, abbiamo ragione tutti e due. Io sono un poveraccio da Marina di Pisa e lei ha tutto il diritto di godersi i soldi suoi e della sua famiglia. A condizione che questo non costringa me a vendere un polmone nel deep web quando torneremo dalle vacanze.
Motivo per cui, mentre Luisa e Greta sguazzavano al largo, ho fatto un secondo esproprio di venti euro. Tre minuti dopo ho guardato Luisa tuffarsi da uno scoglio e, drogato di adrenalina, ho proceduto a un addebito di cinquanta euro anche nei suoi confronti.
Quando sono tornate a riva e Luisa ha cercato il portafogli per comprarsi un gelato, si è subito accorta dell’ammanco. Greta no: da quando siamo arrivati le avrò scucito trecento, trecentocinquanta euro, e lei non si è resa conto di niente. Come se nulla fosse ha ritirato al bancomat due giorni fa, e di nuovo ieri prima di andare a cena.
A quanto pare Luisa condivide con Greta molte cose ma non il bug che la rende incapace di tenere il conto del denaro. Ora che ci penso, non ci ha invitato a casa sua nemmeno per un caffè (noi alloggiamo in un B&B di amici suoi, economico ma non regalato). Forse la sua famiglia abita in un appartamento misero e per lei questi giorni di vacanza con Greta sono un inevitabile costo d’esercizio per non sfigurare con una compagna di collegio. Un’emorragia, insomma, da affrontare ostentando entusiasmo e con la speranza che il bluff regga fino a dopodomani.
Addirittura una denuncia ai carabinieri per un furtarello di cinquanta euro. E poi il miserabile sarei io…
Luisa ripone le sue speranze nella telecamera del bar, anche se il maresciallo – un maschio italico che vedendo entrare due ragazze in pareo si è dimostrato di squisita galanteria – dice che ci sarà poco da fare, anche perché molte telecamere che si vedono in giro sono trappole cinesi che sgranano qualsiasi sagoma più lontana di due metri.
Io sono rimasto calmissimo. Durante il verbale ho ripetuto quel che avevo già detto alle ragazze: mi sono allontanato solo un momento per fare pipì e non ho notato niente di sospetto.
A me hanno rubato qualcosa? Non credo. O meglio, è possibile ma non saprei dire: mica uno sta a contare se gli mancano venti euro. E i cellulari? Tutti al loro posto, li avevamo messi nella borsa frigo per non lasciarli al sole.
Uscendo dalla caserma, un po’ in colpa per il détour tutt’altro che vacanziero e, chissà, pentita anche per la sua reazione da proletaria, Luisa propone di tirarci su il morale portandoci a mangiare i ricci di mare in un ristorantino che conosce. Più che un ristorante è una baracca di lamiere. Sulla lavagnetta all’ingresso sono esibiti senza vergogna i nomi di alcuni molluschi che presumo sia illegale pescare.
Davanti al ristorante vediamo la minuscola filiale di una banca mai sentita, Credito cooperativo di Vattelapesca. Greta ne approfitta per fare un altro prelievo al bancomat, ma sullo schermo compare un messaggio di errore. Quasi a compensare l’entusiasmo meridionalista che rivolge a tutto ciò che è territorio, tradizione, gastronomia e arte, Luisa non perde occasione per stigmatizzare l’arretratezza di qualsiasi apparato moderno che si riveli obsoleto e rozzo. «Figurati», scherza con Greta convincendola ad abbandonare il bancomat, «al massimo ’sto coso sarà abilitato per il prelievo del bisante medievale».
Torniamo a Lecce nel pomeriggio e ci troviamo per l’aperitivo con Luisa alle sette in punto sotto la colonna di Sant’Oronzo. Sulla strada per il bar Greta tenta un altro prelievo da uno sportello Unicredit e poi al Monte dei Paschi. Il responso è sempre lo stesso: carta non abilitata.
Temo di sapere che cosa sta succedendo e la conferma arriva quando Greta, più infastidita che allarmata, si decide a chiamare il numero del servizio clienti e scopre di aver superato il massimale dei prelievi mensili. «E allora alziamolo», la sento dire, adesso piuttosto scocciata. E subito dopo: «Password a sei cifre? Ma quali sei cifre?»
Niente da fare, per modificare i massimali ci vuole questo codice di sicurezza che Greta non sa, o non trova, forse ce l’ha da qualche parte a Pisa scritto chissà dove. Fine della chiamata.
Questa effimera epifania della povertà non ostacola l’ambizioso programma della serata. «Tu hai contante, no?», mi chiede Greta, e già capisco come finirà la nostra storia. Dovrei lasciarla adesso prima che sia troppo tardi, ma sarebbe davvero spiacevole nei confronti di Luisa, che in fondo è una bravissima ragazza e non desidera altro che farci passare vacanze felici.
Pago io l’aperitivo (diciotto euro), faccio benzina (cinquantasette euro). Anche stasera non rinunciamo a un piccolo détour di otto-dieci chilometri per andare a prendere Lorenzo e Marco, due amici di Luisa che abitano fuori Lecce e verranno a cena con noi sulla costa ionica.
Sono entrambi simpatici e alla mano. Per la prima volta in sei giorni mi sento rilassato. A cena beviamo un Primitivo di Manduria (ventisei euro) che fa impallidire il Chianti da tre euro e quarantanove che sono abituato a bere alle serate studentesche.
Sarà l’abbronzatura, sarà che sono un po’ brillo, ma devo ammettere che stasera, anche se resto deciso a lasciarla, Greta è davvero bellissima. La guardo camminare verso il bagno e non vedo l’ora di tornare a casa con lei per approfittarne una penultima o un’ultima volta. Da quando siamo arrivati non abbiamo ancora fatto l’amore, un po’ per la stanchezza delle giornate lunghe, del mare, degli spostamenti in macchina, e un po’ per le tensioni che si sono accumulate. Tra ieri e oggi ci saremmo detti sì e no venti parole, tutte sul registro della comunicazione di servizio. Ma è un bene, mi dico, i viaggi servono anche a questo: uno scarto dalla normalità che consente di rimuovere la scorza della convenzione e scoprire la vera essenza delle—certo che è proprio splendida, la mia Greta! Cari Lorenzo e Marco, vi credete bravi a dissimulare, ma vi ho pizzicati diverse volte con gli occhi nel décolleté valorizzato dall’abbronzatura. L’ha notato anche il cameriere, che infatti fa lo splendido solo con lei. E aggiungiamoci le gambe lunghe, le caviglie sottili, il portamento da ballerina. Merito anche della mamma notaio, che è una pazza anaffettiva, dice Greta, ma almeno l’ha obbligata a fare sport fin da piccola.
Ho voglia di tornare in camera con lei. Paghiamo e andiamo. Siparietto su chi guida e chi non guida. Le ragazze si sentono troppo ubriache, facciamo il gioco dello stecchino e perde Lorenzo. La traversata del tacco dello Stivale tocca a te, amico mio. E meno male, perché il Primitivo mi ha steso.
Ennesima deviazione: mi risveglio in quella che ha tutta l’aria di essere una stanza di ospedale. Non ci vedo bene da un occhio. Sono venuti i miei genitori (cazzo…), mia madre mi sorride triste, mio padre non è nella stanza ma riconosco il profumo della sua colonia.
Quanto tempo è passato? E dov’è Greta? Vorrei urlarlo, ma mi mancano la voce e il coraggio. Comincio ad agitarmi, provo a muovere le gambe ma non le sento. Mamma chiama un’infermiera che si mette ad armeggiare intorno al mio braccio, e dopo nemmeno un minuto mi sento di nuovo tranquillo.
Eravamo di dietro, io stavo nel mezzo tra le ragazze, seduto in quello che goliardicamente si chiama il “posto del morto”. Dell’incidente non conservo nessun fotogramma, probabilmente mi ero addormentato, e forse si è appisolato anche Lorenzo.
«Gr…»
Sono ridotto così male? La lingua resta incollata al palato e non riesco ad articolare. Mamma mi accarezza la fronte e fa segno di non muovermi. «Stai tranquillo, hanno detto che non hai niente di grave, ma non devi sforzarti».
Sta mentendo. Parlano gli occhi, parla la smorfia di terrore che tenta goffamente di celare.
«Gr…», ripeto, «Grœü».
«Greta? Amore, sì, stai calmo! Neanche un graffio… Greta neanche un graffio, è scesa un momento con papà a sgranchirsi le gambe. Gli altri ragazzi stanno abbastanza bene, anche loro ricoverati ma tutti salvi».
Sprofondo nel materasso e tiro un sospiro che mi fa colare il naso. Mentre mamma mi pulisce, giro gli occhi verso il comodino. Riconosco il portafogli e la mia tessera sanitaria appoggiata accanto.
Il portafogli, la tessera sanitaria. Chi l’ha estratta ha dovuto cercarla scartabellando la carta d’identità, la patente, la carta di credito, il badge della biblioteca, la mia collezione di tessere rubate.
A un rumore di passi mia madre si volta: «Ehi, si è svegliato… Però fate piano, facciamo piano».
Entrano mio padre e Greta; si avvicinano al capezzale con il rispetto che si deve a un morto, le dita intrecciate all’altezza del pube. Papà balbetta qualche frase protocollare per tranquillizzarmi, prima che mamma gli chieda di accompagnarla alle macchinette del caffè.
«Græ…»
«Ehi, ehi… Devi stare calmo. E non muovere il collo, ok?»
Giro gli occhi verso il comodino: due volte, tre, quattro. Spero che lei dica qualcosa, qualsiasi cosa purché mi liberi da questa angoscia.
«Cosa guardi? Le tessere? Le ho viste. Ci ho ritrovato la mia…» Si alza e la prende, strizza gli occhi per mettere a fuoco qualcosa: «GM 270281», dice, «le mie iniziali e il numero di matricola. Potevi almeno cancellare, no? Ma che razza di ladro sei? Devi essere uno di quei ladri un po’ nevrotici che, in fondo, vogliono solo essere scoperti e puniti».
Se il mio apparato fonatorio si degnasse di funzionare tenterei una difesa disperata, la butterei sul romantico, direi che sono un ladro da strapazzo, sì, ma almeno il mio furto è servito a stare insieme. Adesso voglio solo che resti qui.
«Sai cos’è che mi inteneriva di te? Che eri dolce e un po’ patetico. Mi ricordavi me stessa, forse: patetica anch’io. Una volta, avrò avuto tredici anni, ho rubato una sigaretta dalla borsa di mia madre e lei se ne è accorta subito. Mi ha presa da parte in camera sua e mi ha chiesto di giurare sulla sua testa che non ero stata io. Quando ho giurato mi ha dato uno schiaffo… Ciao, Tiziano. Adesso scusa, ma non sei più tenero e nemmeno dolce. Sei patetico e basta».
Riesco solo a gorgogliare, la lingua del tutto intorpidita. Non posso credere che abbia il coraggio di andarsene così, lasciandomi fuori pericolo ma pur sempre su un letto di ospedale. Con che razza di mostro sono stato? Mi agito un po’ e Greta guarda verso il corridoio. Dalla sacca estrae il borsello (lo conosco bene, ormai), fruga negli scomparti a fisarmonica e prende una banconota da duecento euro: gialla, cangiante, intonsa. Si avvicina al mio capezzale e infila i soldi nel mio portafogli.
«Tieni, sono riuscita a prelevare dal bancomat, alla fine. Questi te li regalo io. Ciao».
Il cuore mi bussa in gola, ricomincio ad agitarmi. «Grøða…», riesco a dire. Quando esce, la sento parlare con l’infermiera, che entra trafelata, si china un’altra volta sul braccio e apre il rubinetto dell’oblio. Détour. Almeno questo è gratis.
Claudio Lagomarsini insegna Filologia romanza all’Università di Siena. Oltre a diverse pubblicazioni accademiche, suoi articoli di approfondimento sono usciti per Il Post, minima&moralia, Le parole e le cose. Come narratore, ha pubblicato diversi racconti per Nuovi Argomenti, Colla e retabloid, vincendo un contest organizzato dal Premio Calvino nel 2019. Nel 2020 ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, Ai sopravvissuti spareremo ancora (Fazi Editore).
Editing del racconto a cura di Daria De Pascale
Fonte immagine: Samuele Schirò su Pixabay