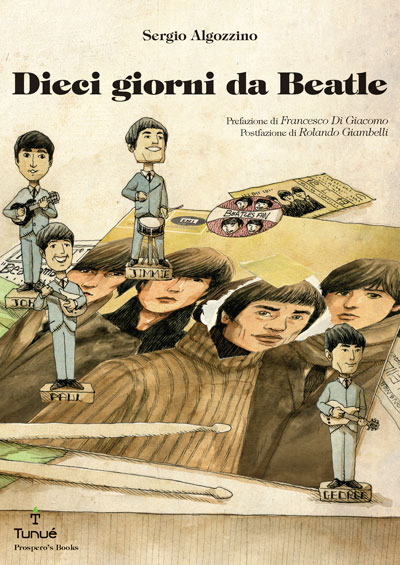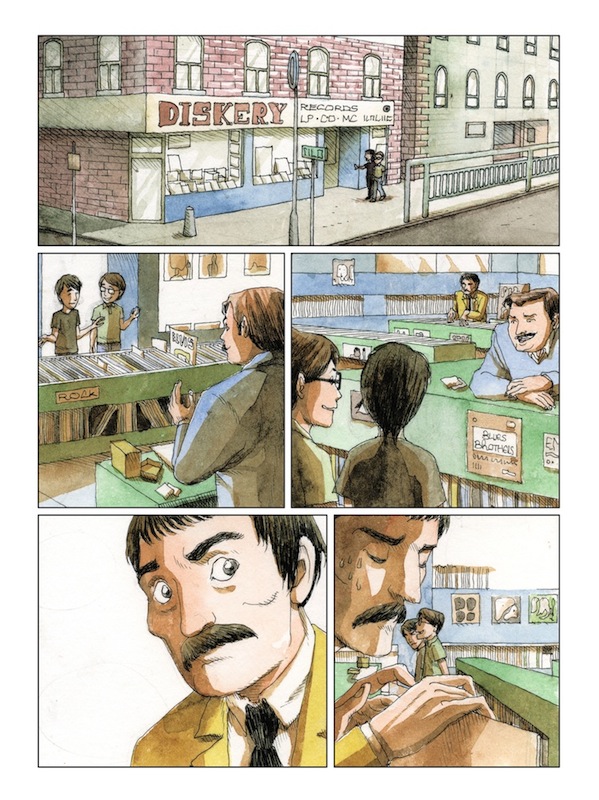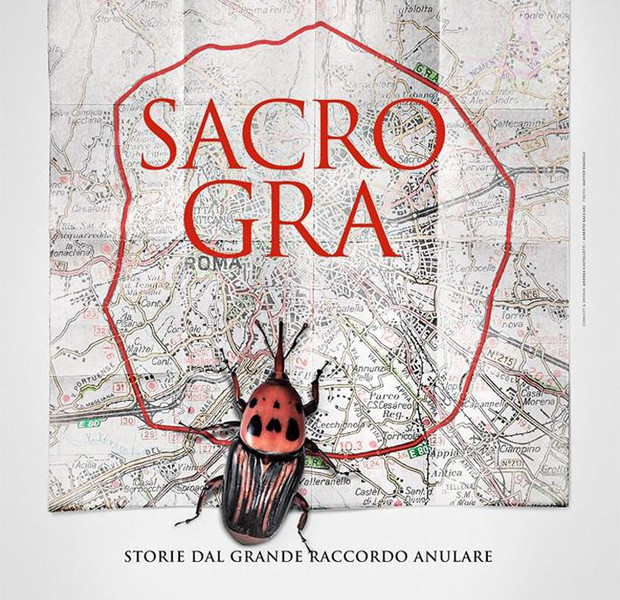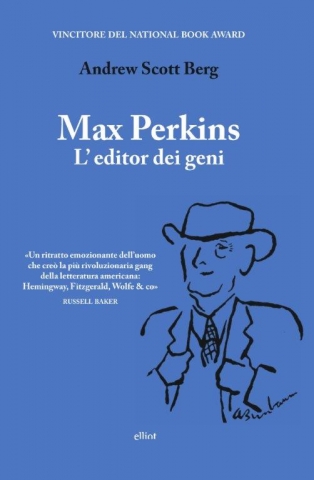E al sessantesimo minuto il flusso sonoro cessa, si spengono gli schermi e resta il silenzio. Qualche secondo di esitazione e arriva l’applauso, quasi di circostanza, si accendono le luci, i tre protagonisti sul palco ringraziano e vanno via. Niente bis come di prassi nei concerti. D’altronde, quello cui abbiamo assistito non è stato un show musicale, ma l’esposizione di una videoinstallazione sonora lunga un’ora. La platea della sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma era piena, anche se il teatro più grande della struttura ideata da Renzo Piano non era certamente soldout.
Gli appassionati capitolini del rock più sofisticato sono accorsi al nome di David Sylvian, l’ex leader dei Japan, l’autore di memorabili dischi come Brilliant Trees, Gone to Earth, Secrets of the Beehive, campione del glam rock e ricercato sperimentatore sonoro con progetti solisti di rock ambient, come le celebri collaborazioni al fianco diRobert Fripp e Ryuichi Sakamoto.
Niente di tutto questo nel progetto The Kilowatt Hour andato in scena domenica 22 settembre a Roma, che ha visto invece Sylvian accompagnato dal polistrumentista austriaco Christian Fennesz e dal guru dell’elettronica sperimentale Stephan Mathieu.

Sylvian ci ha abituato nel corso della sua quasi quarantennale carriera a percorsi sonori sperimentali, inusuali, in cui la musicalità viene tradotta in flussi di note che evocano immagini e tragitti anche molto intimisti. Ma la musica, intesa come sequenza di note e ritmica, e la sua splendida voce piena e soave allo stesso tempo, sottolineavano le immagini che la mente creava e richiamava. Sul palco del progetto Kilowatt Hour ci sono tre grandi tavoli da dj, con quattro Macbook Pro, dei mixer, una chitarra elettrica, un paio di campionatori e un pianoforte a coda.
Sullo sfondo tre grandi maxischermi che proiettano immagini digitali, onde colorate, giochi elettronici di onde e flussi. Non foto, nè immagini nette. A parte una luna che affiora in dissolvenza a un certo punto e un evocato simil-campo di grano formato in realtà da onde luminose che diventano spighe.
Ci si aspettava che la voce dell’ex Japan non dico cantasse, ma almeno sottolineasse o “firmasse” qualche momento dello spettacolo. E invece arriva sì una voce, ma bassa, gutturale, quasi rauca e trasandata che trascina le parole, e che – in un inglese molto biascicato – legge, racconta storie di un viaggio, parla di redenzione, di morte, di malattia. È la voce, registrata, dello scrittore Franz Wright che recita poemi in prosa dal suo Kindertotenwald. Nel getto ininterrotto di suoni c’è spazio anche per il refrain di “Only the Lonely” di Frank Sinatra.
Dopo appena un’ora di questo onirico e depressivo supplizio sonoro in attesa che succedesse qualcosa, dico un suono, un acuto, un sussulto della musicalità che fu di Sylvian, lo show termina e tutti a casa. Carlo Verdone, grande appassionato di rock, si alza e si guarda intorno interdetto dalla sua prima fila. Non abbiamo avuto il coraggio di chiederglielo, ma l’opinione sul concerto era abbastanza intellegibile dal suo volto serio e spiazzato come mai lo abbiamo visto sul grande schermo. E dire che a noi la sperimentazione piace. Questa videoinstallazione però, pardon, questo concerto, a noi è parso un lungo, pervasivo, virulento e noiosamente spocchioso esercizio di stile.